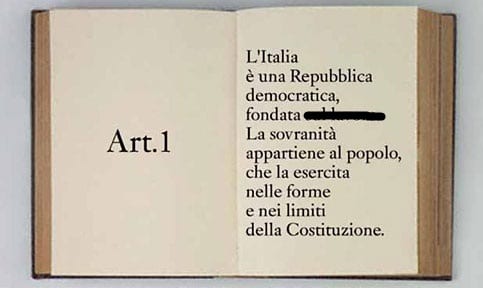
Pensavamo (e speravamo) che il netto pronunciamento dell’elettorato in occasione del referendum del 4 dicembre 2016 avesse posto fine, se non definitivamente almeno per un lungo periodo di tempo, alla periodica (e ormai stucchevole) perorazione sull’indifferibilità delle riforme costituzionali come condizione imprescindibile per la modernizzazione del paese. Purtroppo ci sbagliavamo, ed è toccato a un recente editoriale apparso sul Corriere della Sera con l’autorevole firma di Angelo Panebianco (La Costituzione e le difficili riforme italiane, 21 luglio 2017), risollevare la questione in termini che, se non altro, non peccano di reticenza.
Lo spunto è fornito dalla proposta di flat tax (anch’essa periodicamente ricorrente) nella più recente versione elaborata dall’economista Nicola Rossi per conto dell’Istituto Bruno Leoni di Milano (ndr: la flat tax, in generale, è un modello fiscale in base al quale tutti i contribuenti sono tassati sulla base imponibile con la medesima percentuale e non con un’aliquota progressiva rispetto all’aumentare del reddito).
Secondo l’editoriale del quotidiano milanese, tale riforma si presenta con le carte in regola non solo come contributo essenziale per il rilancio dell’economia, ma anche e soprattutto per il suo valore morale e culturale, di atto di definitivo “congedo dalle ideologie socialisteggianti” dei secoli XIX e XX; malgrado queste virtù taumaturgiche, essa incontra però rilevanti obiezioni sia di merito (da ultimo, quelle di Romano Prodi) sia di altra natura, come quella di Enrico De Mita; quest’ultimo, infatti, avendone eccepito l’incostituzionalità, avrebbe espresso, per questo solo motivo, un diniego puramente “ideologico” a una riforma di stampo liberale. Di qui prende le mosse un ragionamento volto a sostenere che la radice dell’immobilismo del nostro sistema di governo va rintracciata proprio nei principi enunciati nei primi dodici articoli della Costituzione (che peraltro, precedono, con il titolo di “Principi fondamentali” quella che è la vera Prima parte della Costituzione stessa, che va dall’articolo 13 all’articolo 54), autentica selva di vincoli pervasivi e paralizzanti, nelle cui spire sarebbero destinate a cadere tutte le proposte di riforma veramente liberalizzatrici e modernizzatrici, in grado, come la flat tax, di rendere “i cittadini italiani molto più liberi”. Occorre dunque, prosegue il ragionamento, capovolgere l’impostazione sostenuta a suo tempo dai sostenitori della riforma costituzionale Renzi-Boschi: questi ultimi avevano sottolineato le debolezze e le incoerenze della seconda parte della Costituzione (quella, per intenderci, dedicata all’assetto dei poteri di vertice dello Stato) rispetto a una prima parte, condivisa e pertanto considerata intangibile, mentre ora, decaduta quell’ipotesi di riforma, occorrerebbe riconoscere che i limiti dell’una sono la conseguenza logica dell’eccessivo vincolismo dell’altra: di qui, la proposta di rimettere mano alla prima parte (e/o ai “Principi fondamentali”) della Costituzione, da liquidare in quanto ingombrante lascito di un’epoca storica ormai superata.

A quali contenuti dovrebbe ispirarsi questa revisione della prima parte della Costituzione? Per spiegarlo, il professor Panebianco prende spunto dal modo in cui la Carta fondamentale si occupa del diritto di proprietà.
“È sicuro […] – si chiede – che la convivenza civile ci rimetterebbe se la nostra Repubblica anziché essere fondata sul lavoro fosse fondata sulla libertà? È sicuro che se il diritto di proprietà, anziché essere relegato fra i cosiddetti «interessi legittimi», fosse riconosciuto fra i diritti fondamentali, quelli su cui poggia la libertà, ce la passeremmo peggio? Le enunciazioni contenute nella prima parte della Costituzione furono il frutto di compromessi fra alcune forze (democristiani, socialisti e comunisti) che, all’epoca, non brillavano per adesione ai principi liberali”.
Nel secondo quesito, la verve polemica trascina l’editorialista a un’affermazione comprensibile come espediente retorico ma scarsamente fondata dal punto di vista giuridico. In realtà, l’articolo 42, secondo comma, nella Prima parte della Costituzione, afferma: “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.” Si tratta di una formulazione aperta, ma fondata sull’affermazione del riconoscimento e della garanzia per legge del diritto di proprietà, il cui esercizio è soggetto a limiti, esattamente come quello di qualsiasi altro diritto che sia positivamente riconosciuto in un ordinamento democratico e pluralista.
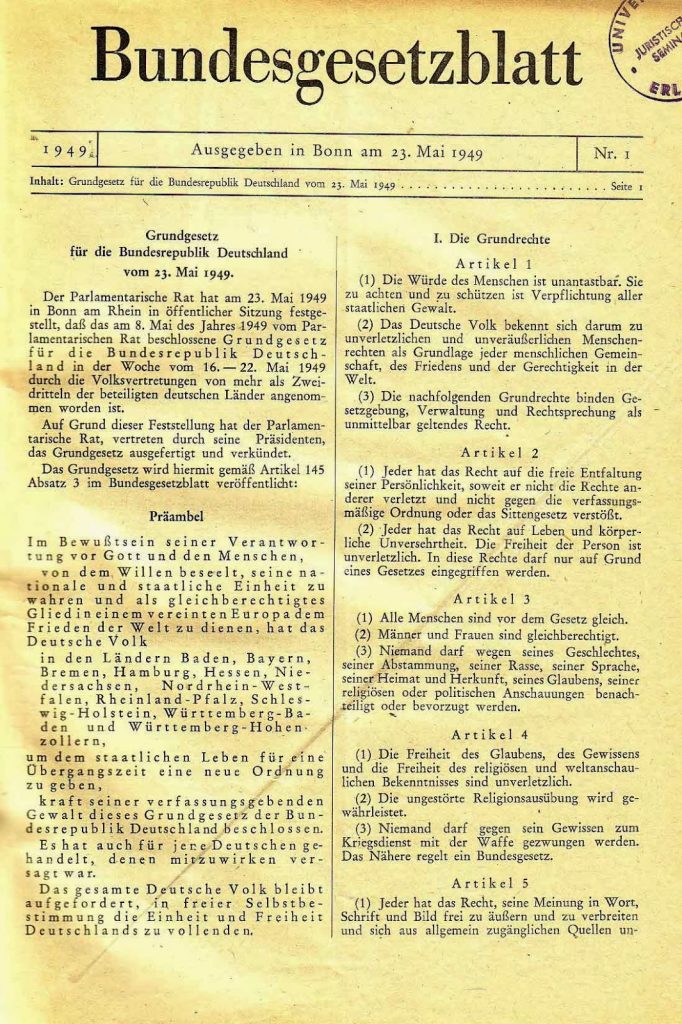
Federale di Germania del 23 maggio 1949,
che promulgò la sua Legge Fondamentale (da http://4.bp.blogspot.com/-AOuL81PAiFM/UmKsK-Fj5LI/AAAAAAAAAak/oKyXq5hbvlM/s1600/20130015-ph06.jpg)
Molto più esplicita, in tal senso, è, tanto per fare un esempio, la Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca, imputabile di tutto, ma non di criptosocialismo, nella quale, ai primi due commi dell’articolo 14, si afferma: “1. La proprietà e il diritto di successione sono garantiti. Contenuto e limiti vengono stabiliti dalla legge. – 2. La proprietà impone degli obblighi. Il suo uso deve al tempo stesso servire al bene comune”. Possiamo affermare, senza timore di essere smentiti, che la formulazione, molto stringente, di questa norma non ha costituito un ostacolo allo sviluppo dell’economia della Germania. In conclusione, l’affermazione secondo la quale nella Costituzione italiana il diritto di proprietà è degradato a interesse legittimo può essere per l’appunto un’estremizzazione polemica (peraltro, vorremmo osservare, efficace solo tra gli addetti ai lavori) ma non certo un’argomentazione fondata, a meno che non si voglia sostenere (e siamo certi che non è questa l’intenzione del professor Panebianco) che sono diritti in senso stretto solo quelli che possono essere esercitati senza limiti.
Il punto principale, allora, non è questo, ma quello contenuto nella seconda parte della citazione: quella che imputa alle principali forze politiche che diedero vita alla Costituzione (socialisti, comunisti e cattolici) una carente cultura liberale, ovvero, per dirla in termini più espliciti, una sostanziale ostilità nei confronti dell’economia di mercato. Il fatto che, malgrado questa tara d’origine, la Costituzione repubblicana “servì ad ancorare l’Italia al mondo occidentale” è liquidato come un evento casuale e privo di rilevanza storica, in forza dell’indimostrabile argomento controfattuale, per cui essa avrebbe potuto anche adattarsi alla realtà del blocco sovietico, qualora nelle elezioni del 1948 avesse prevalso l’alleanza social-comunista.
A tale fine, che è poi – sostiene non tanto implicitamente l’editoriale – quello di cancellare il peccato originale di una presunta impostazione “socialisteggiante” della Costituzione, occorrerebbe rimuovere dall’articolo 1 il fondamento lavoristico della Repubblica e sostituirlo con un esplicito riferimento alla libertà. Verrebbe da obiettare che l’insieme dei diritti civili, politici e sociali che danno forma e contenuto alla moderna idea di libertà, sono compendiati nella dizione “Repubblica democratica”; ma si tratta di un’argomentazione di carattere formale, anche se non certo irrilevante. Il punto è che l’articolo 1 va letto insieme ai primi dodici articoli, e poi a quella che è in senso stretto la prima parte della Costituzione: vi si parla di solidarietà, di diritti inviolabili e doveri inderogabili, di uguaglianza formale e sostanziale, di diritto al lavoro; e insieme di autonomia, decentramento, tutela del paesaggio, arte e cultura, rapporti con l’istituzione religiosa, oltre che di pace e di partecipazione all’organizzazione internazionale. Il fine ultimo di questo insieme di norme e di principi, forse ancora troppo poco meditati, è costituito dalla realizzazione della persona umana, nel rispetto delle sue prerogative e della sua dignità: l’economia di mercato è presa in considerazione in quanto può concorrere alla realizzazione di questo fine, ma può anche agire in senso contrario ad esso. Per questa ragione la disciplina costituzionale del diritto di proprietà è collocata nella prima parte, ma non fra i principi fondamentali della Costituzione, in quanto strumento e non fine; e per questa stessa ragione, ci è difficile condividere l’opinione che degrada quelle norme e quei principi a espedienti retorici utili soltanto a imbrigliare la creatività dell’homo oeconomicus.

Inoltre, l’idea di libertà fondata sul diritto di proprietà, come suggerisce l’editoriale del Corriere della Sera, ripropone, come parametro di modernità, una concezione risalente in realtà ai primi passi del costituzionalismo ottocentesco (quella stessa concezione, peraltro, che subordinava al censo il diritto di voto), ma che ha trovato più recenti e fortunate declinazioni nei modelli politico-istituzionali veicolati dal centro destra di berlusconiana memoria, ispirati a una cultura (si fa per dire) ultraeconomicista, nella quali i cittadini sono presi in considerazione in quanto consumatori (la misura della loro libertà sarà il denaro di cui potranno disporre, magari grazie alla flat tax), i valori sono riconvertiti dagli interessi e il mercato è riconosciuto come l’unico spazio pubblico di scambio e di confronto.
Poteva essere, ed è stato, un modello suggestivo qualche anno fa, prima della crisi del 2008, una crisi che di recente il Presidente del Consiglio ha giustamente definito la più grave del dopoguerra; una crisi che ha costituito anche la bancarotta dell’integralismo neo liberista, prolifico di principi la cui applicazione, dopo l’euforia dei primi anni del secolo, ha avvelenato il mercato, lasciandosi alle spalle non poche rovine. In quegli anni l’individualismo più sfrenato è apparso destinato a prevalere sui principi di solidarietà, di uguaglianza e di partecipazione, posti a fondamento di sistemi di welfare liquidati dai corifei della nuova economia, spesso in modo sprezzante, come fonti di assistenzialismo, sprechi e inefficienze dell’azione pubblica. In verità, solo laddove lo Stato sociale è riuscito almeno in parte a mantenere le sue posizioni, è stato possibile contenere l’azione disgregatrice della crisi: non a caso, oggi molti tra gli uomini politici, tra i rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee e tra gli operatori economici, appartenenti a correnti ideali e a scuole diverse, vanno riconsiderando criticamente le scelte economiche del passato, e ritengono giunto il momento, per il Vecchio continente, di girare pagina e andare oltre un’austerity paralizzante e distruttiva, causa ed effetto di un corto circuito del rapporto tra istituzioni democratiche e cittadini, che ancora oggi minaccia le basi stesse della convivenza civile.
Se si guarda ancora più indietro, occorre riconoscere che i costituenti del dopoguerra, e non solo in Italia, più che scarsamente dotati di spirito liberale, furono consapevoli del nesso tra la crisi devastante del 1929, che aveva messo in ginocchio le economie più avanzate, e l’origine della più sanguinosa guerra della storia, e per questa ragione avvertirono, come un dovere morale ancor prima che politico, la necessità di compiere scelte in grado di dotare gli ordinamenti democratici in costruzione di strumenti, anche normativi, adeguati a scongiurare il rischio di altre possibili crisi, altrettanto gravide di pericoli. Tutto questo si tradusse in principi e regole inscritti nelle carte fondamentali di diversi Paesi non per paralizzare le economie di mercato, ma per prevenire i loro fallimenti e per aprire nuove strade, a partire dalla previsione della cooperazione tra Stati nell’ambito del processo di costruzione europea. Non quelle regole né quei principi sono manchevoli, ma è stata manchevole la loro attuazione, e qui va cercata l’origine di molteplici malesseri la cura dei quali, nel nostro Paese, difficilmente può essere affidata alla scorciatoia di una sommaria revisione costituzionale: per restare nella metafora medico-chirurgica, i tagli del bisturi riformatore invocati dal professor Panebianco sulla prima parte della nostra Costituzione rischiano di incidere le arterie più vitali dell’organismo e, soprattutto, lungi dal sanare vere o presunte malattie, di compromettere definitivamente la salute di un paziente che, in fin dei conti, non gode propriamente di ottima salute.
Pubblicato venerdì 8 Settembre 2017
Stampato il 23/04/2024 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/primo-piano/costituzione-articolo-1-superato/









