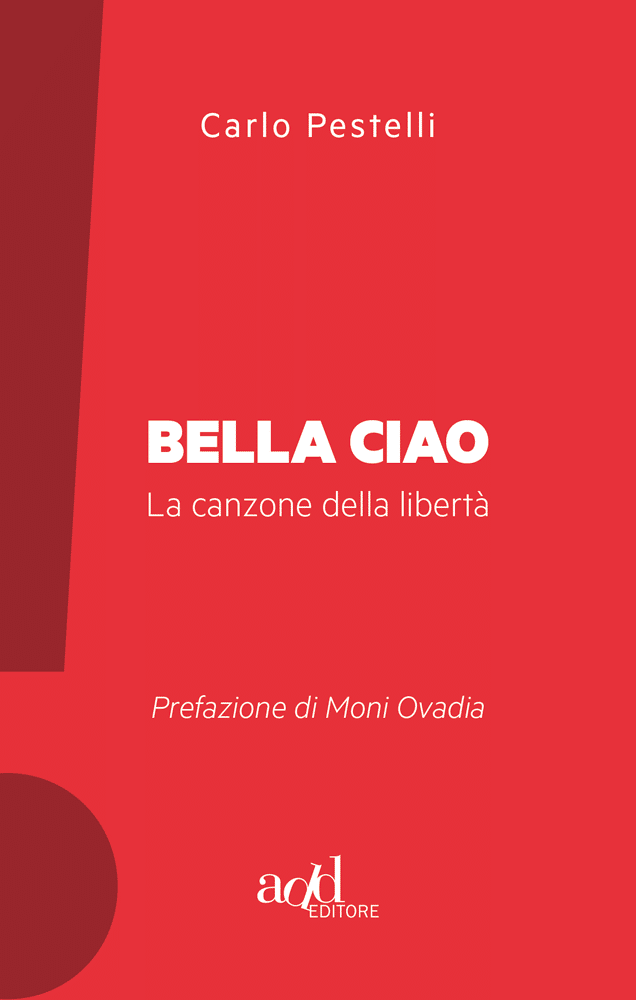Ho incontrato Aldo Simeone il 20 ottobre scorso, in occasione del Bookpride di Genova. Mi trovavo lì per presentare il mio nuovo romanzo, Un altro candore, e subito dopo, nel pomeriggio, io e lui ci siamo seduti dietro a un lungo tavolo chiaro per parlare al pubblico del suo romanzo. Il suo esordio.
Ho incontrato Aldo Simeone il 20 ottobre scorso, in occasione del Bookpride di Genova. Mi trovavo lì per presentare il mio nuovo romanzo, Un altro candore, e subito dopo, nel pomeriggio, io e lui ci siamo seduti dietro a un lungo tavolo chiaro per parlare al pubblico del suo romanzo. Il suo esordio.
Aldo è un ragazzo magro e alto, porta occhiali scuri e un accenno di pizzetto. Quel pomeriggio indossa un maglione rosso, senza camicia, pantaloni scuri e scarpe da ginnastica. Apparteniamo alla stessa generazione, io sono del 1978 e lui del 1982; ma veniamo da luoghi diversi: lui è nato a Pisa, lì si è laureato in Lettere e ha conseguito il dottorato in Studi italianistici e oggi lavora nella casa editrice scolastica Loescher di Torino, per la quale si occupa dei testi di storia e musica. Entrambi abbiamo esordito con un romanzo ambientato negli anni della Resistenza. Il suo, Per chi è la notte? (Fazi editore) è un testo che potrebbe essere rubricato nella categoria del realismo magico ma è in fondo anche un romanzo storico – con pennellate gotiche – che narra l’alba del partigianato come si racconta la nascita di una leggenda dalle tinte scure e chimeriche ma irresistibilmente affascinanti.
Aldo Simeone pubblica il suo primo romanzo a 37 anni. Ma la tua passione per la scrittura quando e come nasce?
In verità, io la passione per la scrittura non ce l’ho, a meno che non si usi questa parola col significato etimologico di «tormento». Scrivere è faticoso e nevrotico. Ci sono un sacco di cose più divertenti da fare, per esempio guardare film o telefilm, vedere cose e persone, spettegolare. E leggere. Insomma, raccogliere storie. Scrivere è un po’ come farsi il pane in casa. Io, da toscano trapiantato in Piemonte, a Torino non trovo il mio amato pane «sciocco» (senza sale), quindi me lo faccio da me.
Il primo romanzo – forse più di tutti gli altri che verranno – è un condensato di passioni, di spinte, di tensioni emotive e, assieme, la riserva, il giacimento di pensieri accumulati magari nel corso di anni. Cosa è confluito, dunque, nella stesura di Per chi è la notte?
In effetti questo non è il mio primo romanzo. Ce ne sono stati altri, prima, che per fortuna non hanno visto la stampa. Per chi è la notte raccoglie l’eredità di quei fallimenti: non nel senso che ne recupera le idee migliori, ma proprio che li seppellisce. Da ingenuo studente di Lettere, ero convinto che scrivere volesse dire «fare letteratura» (una parola ingombrante, che oggi preferisco non utilizzare). Perciò quello che scrivevo era pretenzioso, supponente. Fallire – come insegna la Rowling – mi ha salvato. Così ho smesso di fare letteratura e ho deciso di «limitarmi» a raccontare storie.

Al centro del romanzo c’è il bosco. Si tratta, come è ovvio, di un luogo-simbolo per eccellenza, presente nei recessi ancestrali di tutte le culture e non solo; è un luogo semanticamente stratificato dal punto di vista letterario. A un certo punto scrivi che “le direzioni possibili erano infinite” e mi vengono in mente i nomi di Ariosto, di Calvino, di Borges… Di quali autori hai subito la cosiddetta “angoscia dell’influenza”?
Tutte le esperienze della vita ci lasciano qualcosa, ci condizionano. Questo vale anche per i libri, qualsiasi sia il loro valore. Plinio il Giovane scriveva: «Nessun libro è tanto cattivo da non avere una qualche utilità». Sarebbe stupido credersi figli di nessuno, rincorrere l’ossessione dell’originalità a tutti i costi. Tanti sono gli autori che mi hanno influenzato, ma senza angoscia. Anzi, oserei direi: tutti. Certo, alcuni più di altri: per esempio Stephen King ed Eraldo Baldini.
E poi c’è Bosconero. Cosa dobbiamo leggere in filigrana dietro a questo paese? Perché hai sentito l’esigenza di inventare un luogo letterario?
Bosconero di Garfagnana esiste davvero, ma con un nome diverso, anzi, almeno un paio. È Fabbriche di Careggine, il paese realmente sommerso dall’acqua del lago di Vagli. Però io non ho potuto visitarlo, perché l’ultima sua emersione è avvenuta nel 1994, quando non ne avevo ancora sentito parlare. Perciò, nell’immaginare i vicoli di Bosconero, avevo in mente Minucciano, dove hanno la casa alcuni amici di famiglia. Ecco perché ho deciso di usare un nome fittizio. All’inizio avevo pensato a San Silvestro, poi un mio amico mi ha «regalato» questo nome tanto suggestivo, Bosconero. Solo più tardi ho scoperto che esiste già un paese chiamato così, e proprio vicino a Torino, la città in cui vivo. E questo dimostra che la realtà è piena di umorismo. Come diceva Zeno Cosini, la vita non è né bella né brutta: è originale.

Il bosco è abitato dagli streghi: chi sono costoro? È giusto dire che, rispetto ad altre creature fantastiche, queste – almeno nel modo in cui tu le tratteggi – non assumono di netto i tratti della malvagità, non grava su di loro il peso di una precisa condanna, sono in sostanza creature ambigue (come forse lo potevano essere i partigiani agli occhi di chi per la prima volta ne sentiva parlare nell’autunno del 1943)?
Giustissimo. Ciò che subito mi ha affascinato degli streghi è proprio la loro ambiguità. Se ne sono accorti gli stessi studiosi del folklore garfagnino e si sono domandati: perché gli streghi sono guardati con sospetto, con paura, dalla cultura popolare se non esiste la prova di alcun loro crimine? Pensiamo alla stregoneria: sono innumerevoli i racconti, le false testimonianze, le leggende di sabba infernali, infanticidi, pozioni venefiche ecc. Nulla invece è dato sapere degli streghi: dove vanno? Cosa fanno? Perché sono considerati «malvagi»? Le ricerche hanno condotto a un’ipotesi: probabilmente, in origine, gli streghi non erano considerati maligni; è stato il cristianesimo a censurare questo mito pagano, associandolo alla stregoneria e al demonio. Forse, in precedenza, gli streghi erano solo gli «altri»: gli spiriti dei morti, e incontrarli significava trapassare. Ecco perché non si trattava di un incontro raccomandabile…
Il protagonista del romanzo è Francesco Pacifico. Si tratta evidentemente di un nome parlante.
Anche questo è un furto: dallo stesso amico a cui ho rubato il toponimo «Bosconero». Il suo nome è Francesco Tommaso: un’antitesi – come mi ha fatto notare lui stesso. Francesco è il santo della fede cieca, ingenua; Tommaso, invece, è colui che «se non vede non crede», l’incarnazione del dubbio, senza il quale non c’è vera conoscenza. Così ho deciso di dare questi due nomi ai due protagonisti del romanzo. Poi ho ricordato che in Garfagnana è rarissimo trovare nomi usuali. Basta fare un giro per i cimiteri e imbattersi in lapidi dedicate a Odolino, Orlindo, Diciottimio, Ulpiano, Iperide, Amerube… Di regola, inoltre, i nomi registrati all’anagrafe sono sempre diversi da quelli usati in famiglia. A volte i garfagnini scoprono il proprio nome «vero» solo quando diventano maggiorenni e iniziano a firmare documenti che non hanno alcun valore legale. Un mio amico ha sempre saputo di chiamarsi Mario per poi scoprire di essere Amelio. Così ho pensato a Francesco come a Pacifico. Quel nome è inciso su una lapide in un cimitero della Garfagnana. Del resto anch’io ho altri nomi, oltre ad Aldo, ma per fortuna dopo la virgola. Mi piace pensarli come le mie identità nascoste. Tabucchi diceva «la confederazione delle anime».
E poi ci sono gli amici di Francesco, Secondo e Tommaso: l’uno diverso dall’altro, nelle scelte etiche compiute e nell’influenza esercitata sul protagonista.
Il nocciolo del romanzo, nelle mie intenzioni, è proprio la scelta. Crescere è scegliere. Un’operazione tutt’altro che indolore, troppo spesso sottovalutata. A posteriori è facile distinguere il giusto dallo sbagliato, soprattutto in prospettiva storica. Ormai è acquisito per tutti, o almeno per tanti (speriamo!) che il nazifascismo fu criminale. Dirò di più: antistorico, perché pretendeva d’interrompere il cammino verso il progresso dei diritti, dell’internazionalismo, della tolleranza. La storia è piena di queste ondate di risacca, e anche oggi – se leggiamo fra le righe della cronaca – ce ne rendiamo conto. Il «nuovo» spaventa; il «vecchio» rassicura. Ma quanto è facile capire ciò che sta succedendo oggi, scegliere da che parte stare quando si è immersi nel presente? Francesco, nel mio romanzo, deve decidere fra Tommaso e Secondo, fra il paese e il bosco, fra le leggende della nonna e lo scetticismo dell’amico «illuminista».
Tommaso, in particolare, è un amico perduto e non più ritrovato (almeno materialmente). C’è qualche eco del celebre romanzo di Fred Uhlman?
Può darsi, ma senza un volontario richiamo intertestuale. Per lo stesso motivo che ho detto poco fa: siamo tutti dei ladri, anche quando inventiamo. I mattoni con cui costruiamo edifici nuovi sono pur sempre mattoni: li usavano anche gli antichi romani!
Nel romanzo, come nelle fiabe, convivono molte proficue tensioni: quella tra la paura e la speranza, tra la luce e il buio, tra le proibizioni e la disobbedienza, tra la verità e la menzogna, tra i buoni e i cattivi, tra il perdersi e il non perdersi, tra eroi e traditori. Cosa tiene legate queste coppie di elementi?
Il loro reciproco contrapporsi. Non possiamo pensare al bene senza il male, senza avere deciso prima cosa è male e cosa è bene, e avere compreso che la linea di demarcazione non è mai fissata una volta per tutte. Un tempo l’omosessualità era bollata come peccato contro natura. Il sesso era visto con sospetto. Si riteneva giusto che la donna avesse meno libertà dell’uomo. Mi ha impressionato leggere, in un libro di fisica, che il freddo, dal punto di vista scientifico, non esiste: è assenza di calore. Eppure lo percepiamo distintamente. La stessa cosa vale per il buio: non esiste in se stesso. Forse anche il male, in senso lato, è solo assenza di bene. Pensarla così ci indurrebbe probabilmente a essere meno intolleranti, meno moralisti, meno «saputi».
A questo proposito, a un certo punto del libro scrivi che “non esiste perdita che non lasci una traccia; anche l’assenza è qualcosa, una cavità dentro cui il tempo si adagia creando l’impronta di un fossile, un calco come i gessi di Pompei”. Quante ellissi, quante assenze sono presenti nel romanzo?
Tante: per Francesco, l’assenza del padre; l’amore imperfetto della madre, incapace di gesti affettuosi; la lontananza dei coetanei, che lo additano come figlio di un disertore. Lo stesso bosco è un’assenza, come tutti i misteri. Lo sono gli streghi, che spaventano perché non si conoscono, al pari dei partigiani. L’esperienza, la conoscenza sono le armi più valide per combattere e sconfiggere la paura. La vicenda di Francesco Pacifico è soprattutto la storia di come si diventa grandi, a discapito del mondo, che rimpicciolisce.
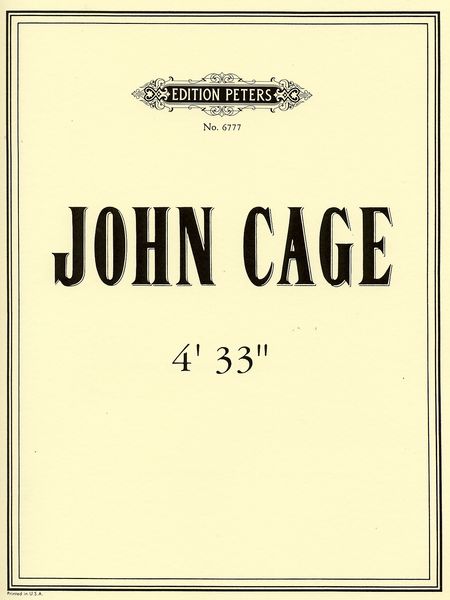 È un romanzo ambientato durante la guerra di Resistenza, ma in realtà i partigiani non si vedono mai (ecco un’altra assenza), radicati come sono alla vita segreta del bosco.
È un romanzo ambientato durante la guerra di Resistenza, ma in realtà i partigiani non si vedono mai (ecco un’altra assenza), radicati come sono alla vita segreta del bosco.
Non si vede neppure la guerra. Qualcuno ha giudicato un limite del romanzo il fatto che, nel finale, quando questa arriva davvero, prorompente, il narratore tace. Per me era necessario. C’è una composizione di John Cage che s’intitola Quattro minuti e trentatré secondi, per qualsiasi strumento. Per quell’esatta durata di tempo, il musicista sta fermo e non fa assolutamente nulla. La musica è il silenzio, o piuttosto i suoni della sala prodotti dagli ascoltatori. Senza arrivare a quegli estremi provocatori, Carver (o il suo editor) ci ha insegnato quanto siano più potenti delle parole i vuoti riempiti dall’immaginazione. Il romanzo più breve della storia della letteratura l’ha scritto Hemingway, per sfida: «Vendesi scarpe di bimbo. Mai nato».
La storia è gravida di superstizioni. Possiamo dire che il tuo libro sia anche un saggio romanzato di come fosse stato difficile, sul nascere della guerra partigiana, riconoscere un valore positivo ai ‘banditi’, sottrarsi cioè – per tutti coloro che non avevano avuto una specifica preparazione politica (specialmente i giovani) – o smaliziarsi (come scrisse Alberto Cavaglion in La Resistenza spiegata a mia figlia) dalle malìe del regime?
Sì, esattamente. Ed è un insegnamento sempre attuale e cocente. La storia non potrà mai essere «maestra di vita» fino a quando resterà storia. Per questo, piuttosto, servono le storie.
Giacomo Verri, scrittore
Pubblicato mercoledì 27 Novembre 2019
Stampato il 16/04/2024 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/bosconero-gli-streghi-e-i-partigiani/