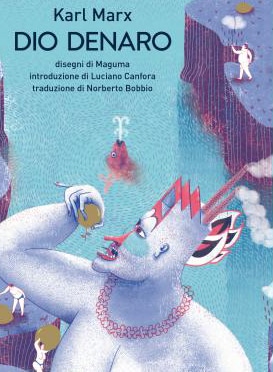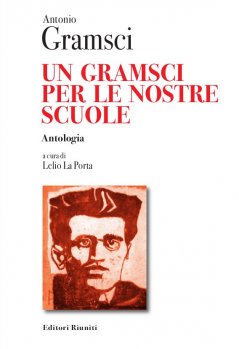 Isolare un tema specifico per illustrare un sistema di pensiero particolarmente complesso e articolato può rivelarsi un metodo efficace, soprattutto quando ci si rivolge alle generazioni più giovani, con un fine esplicitamente pedagogico e formativo. Ancor più, quando il tema adottato presenta caratteristiche tali da rivelarsi un importante punto di intersezione con altre questioni, che da esso si irradiano fino a investire tutti i punti essenziali del percorso di riflessione che si intende intraprendere. Sembra essere questo il criterio adottato da Lelio La Porta nel curare un’antologia di scritti di Antonio Gramsci, rivolta alle scuole medie superiori che, per impostazione e scelta dei testi, si colloca in modo originale e innovativo nel pur ricco panorama di raccolte di scritti gramsciani per le scuole, a partire da quella curata da Carlo Salinari e Mario Spinella nel 1963. Malgrado la pluralità di iniziative editoriali succedutesi da allora, ed esplicitamente finalizzate a introdurre allo studio del pensiero di uno dei maggiori intellettuali del ’900 italiano, il nome di Antonio Gramsci resta ancora ai margini dei curricula scolastici che, per questo aspetto, riproducono una incongruenza di carattere più generale, sottolineata dal curatore al termine della sua densa e appassionata introduzione, quando rileva come ancora oggi, Gramsci sia “letto (nei testi originali e nelle traduzioni), studiato, commentato in quasi tutti i Paesi del mondo e, in alcuni Paesi, più che nella sua e nella nostra Italia (e quindi nelle nostre scuole)”.
Isolare un tema specifico per illustrare un sistema di pensiero particolarmente complesso e articolato può rivelarsi un metodo efficace, soprattutto quando ci si rivolge alle generazioni più giovani, con un fine esplicitamente pedagogico e formativo. Ancor più, quando il tema adottato presenta caratteristiche tali da rivelarsi un importante punto di intersezione con altre questioni, che da esso si irradiano fino a investire tutti i punti essenziali del percorso di riflessione che si intende intraprendere. Sembra essere questo il criterio adottato da Lelio La Porta nel curare un’antologia di scritti di Antonio Gramsci, rivolta alle scuole medie superiori che, per impostazione e scelta dei testi, si colloca in modo originale e innovativo nel pur ricco panorama di raccolte di scritti gramsciani per le scuole, a partire da quella curata da Carlo Salinari e Mario Spinella nel 1963. Malgrado la pluralità di iniziative editoriali succedutesi da allora, ed esplicitamente finalizzate a introdurre allo studio del pensiero di uno dei maggiori intellettuali del ’900 italiano, il nome di Antonio Gramsci resta ancora ai margini dei curricula scolastici che, per questo aspetto, riproducono una incongruenza di carattere più generale, sottolineata dal curatore al termine della sua densa e appassionata introduzione, quando rileva come ancora oggi, Gramsci sia “letto (nei testi originali e nelle traduzioni), studiato, commentato in quasi tutti i Paesi del mondo e, in alcuni Paesi, più che nella sua e nella nostra Italia (e quindi nelle nostre scuole)”.
Ed è proprio dalla scuola che il curatore dell’antologia, egli stesso docente e autore di numerosi saggi di argomento gramsciano, prende le mosse, per richiamare l’attenzione del lettore non soltanto sulla ricchezza della meditazione di Gramsci sui temi dell’apprendimento e della formazione – iniziata precocemente negli anni della militanza socialista torinese e portata a piena maturazione in numerosi passaggi dei Quaderni dal carcere – ma anche sulla sua attualità.
Il riconoscimento dell’attualità di un pensatore del passato è spesso e volentieri un’operazione retorica, una sorta di monumentalizzazione che, di fatto, contraddice il proprio presupposto; nel caso di Gramsci, e in particolare negli scritti presentati e riproposti nell’antologia, l’attualità consiste invece nella presenza di motivi e di indicazioni che, al di là dei contenuti contingenti, tratteggiano i contorni di un organico progetto formativo e al tempo stesso suggeriscono una chiave di lettura idonea a comprendere l’attuale momento di grave crisi delle istituzioni formative e a immaginare alcuni possibili rimedi.
 La bulimia normativa che ha egualmente connotato i governi di centro-destra e di centro-sinistra negli ultimi anni, non solo non ha risolto l’impasse del sistema formativo, ma, in una certa misura, la ha aggravata, laddove ha elaborato una risposta formalistica e burocratica a una condizione di radicale smarrimento che è in primo luogo dipendente da una diffusa perdita di valori e da una caduta di consapevolezza circa i fini dell’istituzione scolastica stessa. Molto opportunamente, a questo proposito, l’introduzione ai testi si apre con una considerazione profondamente gramsciana, che guarda in primo luogo alla soggettività dei protagonisti del processo formativo, segnalando l’emersione di una posizione di doppia subalternità: dei docenti, emarginati in un processo formativo di cui non sono più protagonisti e appiattiti su mere funzioni di controllo, e dei discenti, che attingono a fonti di conoscenza esterne, organizzate “dalle nuove, sofisticate tecnologie” e non più mediate in via prioritaria dall’istituzione scolastica. Nei contesti di una contemporaneità ridotta a un eterno presente, la scuola tende quindi a smarrire la sua dimensione originaria di “formazione sociale” entro la quale si attua il progetto di realizzazione della personalità, nella sua dimensione privata e pubblica; di conseguenza, le regole formali e informali che la governano si presentano sempre meno come il frutto di un’autodisciplina liberamente accettata, in quanto percepita nella sua immanente necessità, e sempre più come un insieme di prescrizioni estrinseche, prive di quella forza persuasiva che si traduce in consenso, e avvertite solo come vincolo esterno, subìto ma non accettato da chi deve sottostarvi: non solo chi apprende, ma anche chi insegna.
La bulimia normativa che ha egualmente connotato i governi di centro-destra e di centro-sinistra negli ultimi anni, non solo non ha risolto l’impasse del sistema formativo, ma, in una certa misura, la ha aggravata, laddove ha elaborato una risposta formalistica e burocratica a una condizione di radicale smarrimento che è in primo luogo dipendente da una diffusa perdita di valori e da una caduta di consapevolezza circa i fini dell’istituzione scolastica stessa. Molto opportunamente, a questo proposito, l’introduzione ai testi si apre con una considerazione profondamente gramsciana, che guarda in primo luogo alla soggettività dei protagonisti del processo formativo, segnalando l’emersione di una posizione di doppia subalternità: dei docenti, emarginati in un processo formativo di cui non sono più protagonisti e appiattiti su mere funzioni di controllo, e dei discenti, che attingono a fonti di conoscenza esterne, organizzate “dalle nuove, sofisticate tecnologie” e non più mediate in via prioritaria dall’istituzione scolastica. Nei contesti di una contemporaneità ridotta a un eterno presente, la scuola tende quindi a smarrire la sua dimensione originaria di “formazione sociale” entro la quale si attua il progetto di realizzazione della personalità, nella sua dimensione privata e pubblica; di conseguenza, le regole formali e informali che la governano si presentano sempre meno come il frutto di un’autodisciplina liberamente accettata, in quanto percepita nella sua immanente necessità, e sempre più come un insieme di prescrizioni estrinseche, prive di quella forza persuasiva che si traduce in consenso, e avvertite solo come vincolo esterno, subìto ma non accettato da chi deve sottostarvi: non solo chi apprende, ma anche chi insegna.
Si tratta, in altri termini, del dilemma che è comune alla pedagogia alla politica, e che fa della prima un elemento essenziale della seconda: il rapporto tra autorità e libertà. Nella riflessione gramsciana sulla scuola, la consapevolezza del difficile e instabile equilibrio che si instaura tra questi due elementi è una costante, e l’accettazione di un grado ragionevole di subordinazione da parte di chi apprende, come contropartita dell’assunzione di una funzione “dirigente” di chi insegna, costituisce il presupposto di un’educazione alla libertà che coincide con l’acquisizione della piena coscienza di sé, “in grado, scrive La Porta, di esprimere giudizi in totale e completa autonomia, del tutto sottratti al senso comune e al conformismo”. Secondo il giovane Gramsci, una scuola che assecondi il processo di emancipazione umana annunciato dal socialismo, è una “scuola di libertà e di libera iniziativa, e non una scuola di schiavitù e di meccanica”; una scuola in grado di impartire un insegnamento “disinteressato”, in quanto scevro di qualsiasi finalità che non sia quella, appunto, della formazione, ma al tempo stesso fortemente incardinata su una disciplina alla quale non sono estranei, come si legge nei Quaderni, “lo sforzo, la noia e anche la sofferenza”: esattamente allo stesso modo in cui, senza disciplina e istruzione, la classe operaia non potrà mai esercitare una funzione di egemonia nei confronti dell’intera società.
 Le numerose incursioni di Gramsci nel campo dell’educazione e della formazione non possono infatti essere lette in maniera separata dal suo pensiero politico complessivo, né dal contesto di radicalizzazione del conflitto di classe che si verifica negli anni della guerra e del primo dopoguerra (nei quali si situa la maggior parte degli scritti antologizzati). È questo, infatti, il clima del quale si alimentò lo “spirito di scissione” che animò il giovane dirigente socialista, nei confronti del pensiero delle classi dominanti, ma soprattutto nei confronti delle volgarizzazioni di esso e della sua riduzione a senso comune e conformismo. Si tratta di vizi e deformazioni che Gramsci stigmatizzava non solo nelle posizioni degli avversari politici, ma anche quando essi si manifestavano all’interno della sua parte politica, in quanto davano la misura della rinuncia a contendere con i ceti dominanti sul terreno più difficile, ma al tempo stesso strategicamente più proficuo: quello, appunto, della capacità di realizzare una visione del mondo egemone, cioè attivamente in grado di plasmare l’insieme dei rapporti sociali. Questo approccio si dispiegava anche nella pluralità e varietà degli oggetti sui quali si appuntava, negli anni torinesi, la polemica del giovane dirigente socialista: l’enciclopedismo di stampo positivistico delle Università popolari, il corporativismo goliardico del sindacalismo studentesco, attore di una banalizzazione del sistema scolastico funzionale a un progetto di spoliticizzazione dell’intera società, le rivendicazioni clericali a sostegno della scuola privata, ma anche le intemperanze oratorie di dirigenti socialisti, pure colti e avvertiti come Claudio Treves. La vigorosa dichiarazione di guerra agli “indifferenti”, contenuta in uno degli articoli più noti – nel quale echeggiavano le parole di un autore molto amato da Gramsci, il tedesco Friedrich Hebbel – è una manifestazione coerente di questo impegno contro il conformismo e la pigrizia ideologia, matrici di un’inerzia civile di cui il declino delle istituzioni formative costituiva una delle manifestazioni più preoccupanti, propedeutica ad altri e più gravi fenomeni di degenerazione.
Le numerose incursioni di Gramsci nel campo dell’educazione e della formazione non possono infatti essere lette in maniera separata dal suo pensiero politico complessivo, né dal contesto di radicalizzazione del conflitto di classe che si verifica negli anni della guerra e del primo dopoguerra (nei quali si situa la maggior parte degli scritti antologizzati). È questo, infatti, il clima del quale si alimentò lo “spirito di scissione” che animò il giovane dirigente socialista, nei confronti del pensiero delle classi dominanti, ma soprattutto nei confronti delle volgarizzazioni di esso e della sua riduzione a senso comune e conformismo. Si tratta di vizi e deformazioni che Gramsci stigmatizzava non solo nelle posizioni degli avversari politici, ma anche quando essi si manifestavano all’interno della sua parte politica, in quanto davano la misura della rinuncia a contendere con i ceti dominanti sul terreno più difficile, ma al tempo stesso strategicamente più proficuo: quello, appunto, della capacità di realizzare una visione del mondo egemone, cioè attivamente in grado di plasmare l’insieme dei rapporti sociali. Questo approccio si dispiegava anche nella pluralità e varietà degli oggetti sui quali si appuntava, negli anni torinesi, la polemica del giovane dirigente socialista: l’enciclopedismo di stampo positivistico delle Università popolari, il corporativismo goliardico del sindacalismo studentesco, attore di una banalizzazione del sistema scolastico funzionale a un progetto di spoliticizzazione dell’intera società, le rivendicazioni clericali a sostegno della scuola privata, ma anche le intemperanze oratorie di dirigenti socialisti, pure colti e avvertiti come Claudio Treves. La vigorosa dichiarazione di guerra agli “indifferenti”, contenuta in uno degli articoli più noti – nel quale echeggiavano le parole di un autore molto amato da Gramsci, il tedesco Friedrich Hebbel – è una manifestazione coerente di questo impegno contro il conformismo e la pigrizia ideologia, matrici di un’inerzia civile di cui il declino delle istituzioni formative costituiva una delle manifestazioni più preoccupanti, propedeutica ad altri e più gravi fenomeni di degenerazione.
 “Noi dell’Avanti! – scriveva Gramsci nel 1920 – non abbiamo esitazione a farci i Don Chisciotte della serietà della scuola e della moralità tra gli studenti, contro la pigrizia e lo scetticismo dei responsabili”: un’assunzione di responsabilità certamente forte, e destinata a restare incompresa in un partito socialista che dava crescenti prove di impotenza di fronte al riorganizzarsi della reazione e anche, negli anni a seguire, in un partito comunista chiuso nella deriva settaria del bordighismo; un’assunzione di responsabilità che riproponeva, in positivo, una visione della lotta politica come espressione di creatività irriducibile agli schemi dell’ortodossia (come nel notissimo articolo La rivoluzione contro il Capitale, del 1917) e risuonava come un monito, espressione del “pessimismo dell’intelligenza”, ad analizzare attentamente la novità costituita dall’ascesa del fascismo e, con essa, a rintracciare le matrici ideali del sovversivismo piccolo borghese che avrebbero costituito uno dei punti di forza del regime. Contro l’interpretazione diffusa anche in seno al movimento operaio, del fascismo come fenomeno politico transitorio, Gramsci infatti aveva colto le caratteristiche di lungo periodo di una formazione politica che, nel mirare all’unificazione delle classi dirigenti sotto il segno della reazione, aveva anche dato sbocco alla “psicologia barbarica e antisociale di alcuni strati del popolo italiano, non modificati ancora da una tradizione nuova, dalla scuola, dalla convivenza in uno Stato bene ordinato e bene amministrato”. In tale modo, il fascismo si presentava come causa ed effetto di un processo di disgregazione sociale e politica, nel quale si trovava ad agire puntando, paradossalmente, a fondare il proprio consenso sulla pretesa di restaurare l’autorità dello Stato nel momento stesso in cui ne minava le basi e, con esse, il presupposto di una convivenza civile più avanzata. “Il fascismo – si legge in Forze elementari, un articolo del 1921 – è il nome della profonda decomposizione della società italiana, che non poteva non accompagnarsi alla profonda decomposizione dello Stato, e oggi può essere spiegato solo con riferimento al basso livello di civiltà che la nazione italiana aveva potuto raggiungere in questi sessanta anni di amministrazione unitaria”.
“Noi dell’Avanti! – scriveva Gramsci nel 1920 – non abbiamo esitazione a farci i Don Chisciotte della serietà della scuola e della moralità tra gli studenti, contro la pigrizia e lo scetticismo dei responsabili”: un’assunzione di responsabilità certamente forte, e destinata a restare incompresa in un partito socialista che dava crescenti prove di impotenza di fronte al riorganizzarsi della reazione e anche, negli anni a seguire, in un partito comunista chiuso nella deriva settaria del bordighismo; un’assunzione di responsabilità che riproponeva, in positivo, una visione della lotta politica come espressione di creatività irriducibile agli schemi dell’ortodossia (come nel notissimo articolo La rivoluzione contro il Capitale, del 1917) e risuonava come un monito, espressione del “pessimismo dell’intelligenza”, ad analizzare attentamente la novità costituita dall’ascesa del fascismo e, con essa, a rintracciare le matrici ideali del sovversivismo piccolo borghese che avrebbero costituito uno dei punti di forza del regime. Contro l’interpretazione diffusa anche in seno al movimento operaio, del fascismo come fenomeno politico transitorio, Gramsci infatti aveva colto le caratteristiche di lungo periodo di una formazione politica che, nel mirare all’unificazione delle classi dirigenti sotto il segno della reazione, aveva anche dato sbocco alla “psicologia barbarica e antisociale di alcuni strati del popolo italiano, non modificati ancora da una tradizione nuova, dalla scuola, dalla convivenza in uno Stato bene ordinato e bene amministrato”. In tale modo, il fascismo si presentava come causa ed effetto di un processo di disgregazione sociale e politica, nel quale si trovava ad agire puntando, paradossalmente, a fondare il proprio consenso sulla pretesa di restaurare l’autorità dello Stato nel momento stesso in cui ne minava le basi e, con esse, il presupposto di una convivenza civile più avanzata. “Il fascismo – si legge in Forze elementari, un articolo del 1921 – è il nome della profonda decomposizione della società italiana, che non poteva non accompagnarsi alla profonda decomposizione dello Stato, e oggi può essere spiegato solo con riferimento al basso livello di civiltà che la nazione italiana aveva potuto raggiungere in questi sessanta anni di amministrazione unitaria”.
C’è più di una ragione per riconoscere che alcuni dei problemi adombrati in queste parole, pur riferiti a un momento storico molto diverso, parlano di un passato che presenta non pochi addentellati con l’attualità. Se è vero che la crisi delle istituzioni formative costituisce la spia di fenomeni più estesi che investono elementi cruciali della moderna democrazia, è ancora più vero che sono proprio i fondamenti di essa a essere rimessi spesso in discussione, nel quadro di contesti non privi di tratti inquietanti. In una contemporaneità sempre meno decifrabile, la tendenza alle semplificazioni, il ricorso all’emotività, la ricerca di capri espiatori su cui scaricare le tensioni collettive, la condanna in blocco della politica da parte di leader che vantano una presunta estraneità all’establishment, possono esercitare una fascinazione perversa sui gruppi sociali che stanno pagando pesantemente i prezzi di una crisi nella quale l’elemento strettamente economico si intreccia con quello riguardante il declino di modelli consolidati di società e di cultura. In questi contesti, l’impegno volto a restituire senso e valore all’istituzione formativa può assumere un carattere emblematico, come punto di snodo di un problema più generale, che pone interrogativi non eludibili sulla riattivazione di circuiti democratici che appaiono sempre più in sofferenza, e sulla costruzione di una cittadinanza attiva e solidale, in grado di contestare in concreto le forme di individualismo esasperato prodotte dall’egemonia neo liberista, e spesso connotate da un integralismo identitario incline a produrre sentimenti di isolamento, di competizione e di ostilità.
Calarsi nella concretezza di questi problemi senza prestarsi a facili trasformismi ideologici in nome di un empirismo vacuo e inconcludente è un dilemma che si pone a chiunque non intenda ridurre la politica a manifestazione di mero attivismo. Da questo punto di vista, l’importanza e l’attualità della lezione gramsciana consistono proprio nella consapevole affermazione di un atteggiamento perseverante nell’impegno ad andare oltre le contingenze dell’oggi per cercare di comprendere le linee di fondo sulle quali si estende la lunga durata dei processi di trasformazione economica, sociale e culturale del nostro tempo. A ottant’anni dalla morte, il pensiero di Gramsci costituisce uno dei lasciti più importanti della cultura italiana del ’900 e un punto di riferimento per tutti coloro che, come scrive La Porta concludendo l’introduzione ai testi, guardano al proprio tempo con il “pessimismo dell’intelligenza” senza però rinunciare all’“ottimismo della volontà”.
Pubblicato mercoledì 8 Marzo 2017
Stampato il 19/04/2024 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/riflessioni-sul-passato-sul-presente/