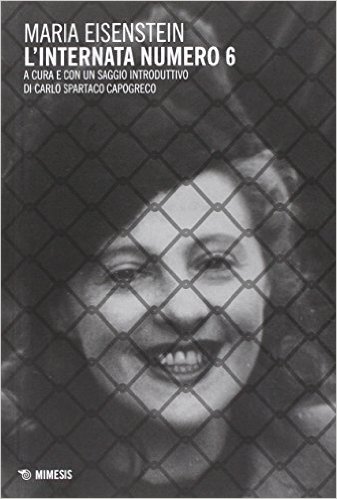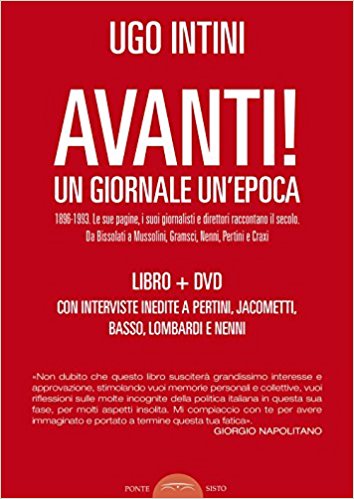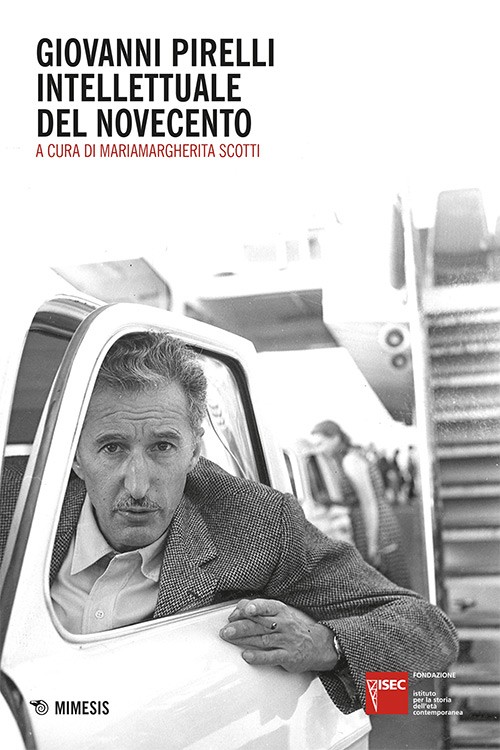Nel 1907 il medico statunitense MacDougall effettuò degli studi su dei pazienti poco prima della loro morte per dimostrare non solo che l’anima esiste ma che ha una sua massa definibile e quindi misurabile. Qualcosa di straordinario si stava compiendo, la scienza non sapeva spiegarlo ma poteva dimostrarlo. Il paziente moriva e il bilancino immediatamente cadeva dalla parte opposta, come se qualcosa – con un suo peso specifico – si fosse sganciato dal corpo. Quel peso, che si differenziava di pochissimo da paziente a paziente, era di 21 gr. Da qui il grande film intitolato proprio 21 grammi di cui si ricorda senz’altro il singolare e quanto mai toccante monologo: “Quante vite viviamo? Quante volte si muore? Si dice che nel preciso istante della morte tutti perdiamo 21 grammi di peso. Nessuno escluso. Ma quanto c’è in 21 grammi? Quanto va perduto? Quando li perdiamo quei 21 grammi? Quanto se ne va con loro? Quanto si guadagna? 21 grammi, il peso di cinque nichelini uno sull’altro. Il peso di un colibrì, di una barretta di cioccolato. Quanto valgono 21 grammi?”. Ricordo nitidamente di essermi chiesta, più o meno arrivata alla metà del libro di Romeo Vernazza, Quelli erano giorni (Tempesta Editore, Trevignano Romano, pp. 176), quale fosse il peso specifico che si portava dietro quel Sarva lì, il protagonista di quella storia, perché un uomo come quello non poteva di certo avere un’anima che pesava solo 21 grammi. O almeno non dopo che i nazisti gliene succhiarono un bel po’.
Nel 1907 il medico statunitense MacDougall effettuò degli studi su dei pazienti poco prima della loro morte per dimostrare non solo che l’anima esiste ma che ha una sua massa definibile e quindi misurabile. Qualcosa di straordinario si stava compiendo, la scienza non sapeva spiegarlo ma poteva dimostrarlo. Il paziente moriva e il bilancino immediatamente cadeva dalla parte opposta, come se qualcosa – con un suo peso specifico – si fosse sganciato dal corpo. Quel peso, che si differenziava di pochissimo da paziente a paziente, era di 21 gr. Da qui il grande film intitolato proprio 21 grammi di cui si ricorda senz’altro il singolare e quanto mai toccante monologo: “Quante vite viviamo? Quante volte si muore? Si dice che nel preciso istante della morte tutti perdiamo 21 grammi di peso. Nessuno escluso. Ma quanto c’è in 21 grammi? Quanto va perduto? Quando li perdiamo quei 21 grammi? Quanto se ne va con loro? Quanto si guadagna? 21 grammi, il peso di cinque nichelini uno sull’altro. Il peso di un colibrì, di una barretta di cioccolato. Quanto valgono 21 grammi?”. Ricordo nitidamente di essermi chiesta, più o meno arrivata alla metà del libro di Romeo Vernazza, Quelli erano giorni (Tempesta Editore, Trevignano Romano, pp. 176), quale fosse il peso specifico che si portava dietro quel Sarva lì, il protagonista di quella storia, perché un uomo come quello non poteva di certo avere un’anima che pesava solo 21 grammi. O almeno non dopo che i nazisti gliene succhiarono un bel po’.

Il fatto è che uno se li immagina quei ragazzi giovanissimi strappati dalla propria esistenza, improvvisamente indossare una divisa brandendo un fucile, mandati chissà dove a difendere la patria. Mentre magari ragionano sul fatto che la loro di patria era perfettamente al sicuro prima dell’inizio di una guerra di cui anche loro da quel momento in poi entravano a far parte. Perché è così, una volta che ci sei dentro non ne esci più, neanche a chilometri di distanza, neanche dopo anni, neanche dopo aver capito che vinta o persa non fa alcuna differenza. E dicono: “Sì, ma la guerra è così”, ma in fondo non la capisce mai nessuno, soprattutto chi la fa. Sarva raccontò che quando vide Mussolini, l’uomo per cui in una sorta di roulette russa evitava granate e colpi di mitragliera al posto dei suoi compagni – meno fortunati – pensò che era molto più basso di quello che aveva immaginato. Ai più verrà da sorridere ma è un passaggio davvero emblematico. Erano dei fascisti ancor prima di capire cosa fosse il fascismo e cosa il fascismo si aspettasse da loro. Anzi questo lo avevano intuito: andare a morire come carne da macello al suon di Dux nobis. Spaventati, esausti, confusi: sparavano. Oh sì se sparavano! E si proteggevano come meglio potevano, che tanto si era tutti sulla stessa giostra lì, pur senza che nessuno di loro avesse pagato il biglietto. Il peso di un’anima non può mai esser corrispondente a quello di una coscienza collettiva, perché le coscienze, una volta unite, smettono di essere tali respirando dalle proprie bocche e plasmandosi a un disegno molto più grande. Perché le coscienze muoiono nel momento esatto in cui qualcun altro muore per mano nostra: “Qualche volta è difficile morire, a volte non bastano gli spari a bruciapelo e le coltellate nella pancia, perché non si muore così, semplicemente, sembra quasi che gridare ti impedisca di morire, sbatterci la testa su una pietra una, due, tre volte, urlarci basta, basta, per favore, cercate di morire che non sopportiamo più di vedervi contorcere nel fango, con i budelli in mano, guardarci con lo stupore di un bimbo che ha perso la strada di casa. Li vedi da vicino, finalmente, i greci che supplicano e ti finiscono, e scopri che sono esattamente come noi, poveri e tristi come noi, una faccia una razza, si dice così, no? Eccoli qui, facce stanche e impaurite di operai, barbieri, contadini, troppo giovani e già troppo vecchi, in tasca la foto sgualcita della mamma o della bella del paese. Ci ammazziamo tra di noi e siamo talmente sporchi di sangue e fango che dobbiamo continuare a urlare nella nostra lingua per riconoscerci. Ma perché non ci fermiamo, non stiamo zitti, non ci inginocchiamo e preghiamo tutti insieme? Già, ma pregare chi, o cosa?”. Come si può anche solo pensare che un uomo che torna a casa dopo la guerra, e ha la forza di raccontare tutto questo, riesca a trovare anche quella che gli serve per riappropriarsi di un briciolo di carne che era prima, prima del sudore, del freddo, del sangue e del peso della storia e che, prima di trovarsi nelle pagine caotiche dei libri, giaceva sulle loro spalle. E come si fa a riportare queste testimonianze con una lucidità disarmante, lì dove c’è così tanto cuore che sembra di riuscire a tenerlo tra le mani, soprattutto se quel cuore è quello di un padre; sì, perché Romeo Vernazza, pur parlando in prima persona, è il figlio del protagonista di questa storia ed è questo forse a renderla ancora più vera, cruda o semplicemente solo più umana.
Un testo che consiglio, anche per scelta stilistica dell’autore che trovo estremamente coraggiosa senza lasciare spazio a nessun altro tipo di giudizio. Coraggiosa e lecita, a tratti perfino doverosa. Se è vero – come è vero – che la Storia è fatta dagli uomini, che senso ha studiarla se non ci si sofferma sui sentimenti, vero motore della storia, di chi l’ha compiuta? E io ne resto convinta: il peso dell’anima di quell’uomo lì non poteva contare 21 grammi nelle sue molteplici vite vissute e perdute, senza perdonarne in fondo nemmeno una. È notevole il merito di Vernazza e, senza possibilità di dubbio alcuno, del suo papà. A cui non è stato dato il tempo di scegliere da che parte stare.
Pubblicato venerdì 8 Settembre 2017
Stampato il 19/04/2024 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/ventuno-grammi/