
Vivo tra un mondo di neri e un mondo di bianchi, tra i tasti neri e i tasti bianchi del mio pianoforte, ma ho trovato l’equilibrio.
Nina Simone
Nina Simone, ovvero Eunice Kathleen Waymon, aveva un sogno: diventare la prima concertista classica di colore. Ma negli anni delle disuguaglianze razziali in America quel destino le fu negato. Eppure, quella bambina di colore, nata nel 1933 in una famiglia povera e religiosa della Carolina del Nord, possedeva un talento innegabile: a due anni e mezzo suonava a orecchio i salmi sull’armonium di famiglia, a quattro accompagnava sua madre, reverenda, all’organo della chiesa di Tryon, a sei iniziava la sua formazione classica con un’insegnante bianca. Formazione che proseguiva grazie a una borsa di studio messa a disposizione dalla comunità della sua cittadina, non potendo, la famiglia, provvedere a quelle spese. A vent’anni (e poi più volte successivamente), Eunice sosteneva l’esame d’ingresso al conservatorio, rifiutata da una commissione bianca. Il sogno si spezzava, la ragazza non credeva più in se stessa, addio alla musica classica dei bianchi. Così, Eunice Kathleen Waymon, nata da una discendenza di schiavi, lasciava il posto a Nina Simone. Che percorreva strade imprevedibili. Contrastate dalla famiglia, sconvenienti per una giovane donna nell’America degli anni Cinquanta. Strade che l’avrebbero portata a diventare una stella della canzone americana: “L’artista sfavillante, la diva assoluta, la creatrice visionaria, l’interprete del dramma, la voce del disastro” [David Brun-Lambert, Nina Simone. Una vita, p. 7]. Perché la sua vita sarà attraversata da profonda solitudine e infinite tragedie personali e collettive, in un’epoca segnata da radicali cambiamenti sociali. Ne sarà protagonista a fianco di grandi personaggi, da Martin Luther King, a Stokely Carmichael e Malcom X. Fino a diventare autrice di canzoni di protesta e portabandiera di una rivoluzione, il Movimento per i diritti civili. Fiera testimonial della sua negritudine, intenzionata a rovesciare ogni forma di ingiustizia nei confronti delle persone di colore.
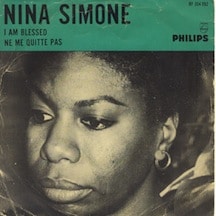 Quando viene al mondo, il 21 febbraio 1933, Tryon, in passato stazione di villeggiatura, è una città fantasma, a causa degli effetti del crollo di Wall Street. Suo padre John Divine è senza occupazione, ma si adatta a fare di tutto, sua madre Mary Kate lavora come domestica. La famiglia Waymon, composta di sei fratelli, resta a galla e l’infanzia di Eunice è segnata, oltre che dalla povertà, dalla musica: la madre canta inni religiosi, il padre suona la chitarra, l’armonica, l’armonium. Tutta la famiglia si alterna agli strumenti rivisitando ogni sera gli stessi canti gospel. “Mia madre mi raccontava che ancora piccola, mi bastava sentire alla radio una pubblicità composta da due o tre note musicali che mi mettevo subito a canticchiare. Era dentro di me, mi diceva. La musica era dentro di me” [N. S. Una vita, p. 19].
Quando viene al mondo, il 21 febbraio 1933, Tryon, in passato stazione di villeggiatura, è una città fantasma, a causa degli effetti del crollo di Wall Street. Suo padre John Divine è senza occupazione, ma si adatta a fare di tutto, sua madre Mary Kate lavora come domestica. La famiglia Waymon, composta di sei fratelli, resta a galla e l’infanzia di Eunice è segnata, oltre che dalla povertà, dalla musica: la madre canta inni religiosi, il padre suona la chitarra, l’armonica, l’armonium. Tutta la famiglia si alterna agli strumenti rivisitando ogni sera gli stessi canti gospel. “Mia madre mi raccontava che ancora piccola, mi bastava sentire alla radio una pubblicità composta da due o tre note musicali che mi mettevo subito a canticchiare. Era dentro di me, mi diceva. La musica era dentro di me” [N. S. Una vita, p. 19].
Quando a due anni e mezzo Eunice suona all’armonium un canto di lode i suoi genitori cadono in ginocchio. In poco tempo si sparge la voce e da lontano arrivano fedeli che vogliono ascoltare la bambina prodigio. A sei anni Eunice diventa la pianista ufficiale della cappella metodista di Tryon, dove sua madre predicatrice è diventata reverenda.
È una madre che condizionerà non poco la vita di Eunice. La avvicina alla musica, ma la sua carica di reverenda della comunità di Tryon, la voterà totalmente al culto. Di qui la disapprovazione delle scelte artistiche della figlia e la sua condanna.
 Eunice è così talentuosa che una signora della buona borghesia di Tryon si assume le spese per pagare alla bambina un anno di lezioni al pianoforte. I Waymon non si oppongono che sia una donna bianca a trasmettere alla bambina un’arte bianca. Eunice si immerge nello studio di Mozart, di Liszt, di Bach. “Bach ha fatto sì che votassi la mia vita alla musica”, dirà. All’età di otto anni decideva di diventare concertista consacrandosi al pianoforte classico. Ore e ore lì seduta, a costringere la schiena a stare dritta, la memoria a immagazzinare miliardi di note. Combattendo con se stessa: da una parte il gospel, le sue radici, il canto materno. Dall’altra Bach: la cultura dei bianchi, l’Europa lontana.
Eunice è così talentuosa che una signora della buona borghesia di Tryon si assume le spese per pagare alla bambina un anno di lezioni al pianoforte. I Waymon non si oppongono che sia una donna bianca a trasmettere alla bambina un’arte bianca. Eunice si immerge nello studio di Mozart, di Liszt, di Bach. “Bach ha fatto sì che votassi la mia vita alla musica”, dirà. All’età di otto anni decideva di diventare concertista consacrandosi al pianoforte classico. Ore e ore lì seduta, a costringere la schiena a stare dritta, la memoria a immagazzinare miliardi di note. Combattendo con se stessa: da una parte il gospel, le sue radici, il canto materno. Dall’altra Bach: la cultura dei bianchi, l’Europa lontana.
È grazie al fondo Eunice Waymon che Miz Mazzy, l’insegnante di pianoforte, raccoglie le offerte che permettono alla sua allieva di proseguire l’educazione musicale in un istituto. Tutta la comunità prende parte alla raccolta di denaro. Bianchi e neri, nell’America degli anni Quaranta e della segregazione, si uniscono intorno al destino di Eunice: lei doveva diventare la prima concertista classica di colore. Al termine del liceo la ragazza è pronta a entrare al conservatorio, il rinomato Curtis Institute di Philadelphia. Avrebbe preparato l’esame di ammissione alla Julliard School di New York a cui accedeva grazie a una borsa di studio di due mesi. Unica allieva di colore al corso di pianoforte, il 12 agosto 1950 sosteneva l’esame. Nessun documento di quella prova è stato conservato. Ma sulla lettera inviatale qualche tempo dopo vi era scritto: “scartata”. Eunice non studierà mai al Curtis, pur tentando ogni anno quell’esame. Non sarà mai la prima concertista classica nera d’America. Non si dava spiegazioni per quel rifiuto, se non per il colore della sua pelle: il razzismo che fino a quel momento non l’aveva sfiorata, protetta nella comunità di Tryon, ora si mostrava in tutta la sua verità.
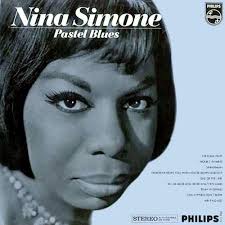 Luglio 1954: Eunice è in viaggio per Atlantic City con un’amica, ha saputo che nei locali del posto i pianisti sono ben pagati e lei vuole raggranellare qualche soldo per rendersi autonoma, andarsene dalla famiglia, continuare a studiare. “Ero programmata per diventare una stella del pianoforte classico – racconta – ma ho dovuto accettare un lavoro in un night club. Appena arrivata mi hanno chiesto se cantavo. Ho detto di no ma hanno preteso che cantassi se volevo tenere il lavoro. Allora ho cantato” [N. S. Una vita, p. 56]. Così, dal palcoscenico di una lurida bettola del New Jersey, il Midtown Bar & Grill, inizia la metamorfosi di Eunice in Nina Simone. Giovane donna in abito di mussola bianco e capelli a chignon, che volta le spalle a Dio consacrandosi alla musica del diavolo. Una poco di buono, per sua madre. Una che sprecava tutto quel talento nei bar per ubriaconi.
Luglio 1954: Eunice è in viaggio per Atlantic City con un’amica, ha saputo che nei locali del posto i pianisti sono ben pagati e lei vuole raggranellare qualche soldo per rendersi autonoma, andarsene dalla famiglia, continuare a studiare. “Ero programmata per diventare una stella del pianoforte classico – racconta – ma ho dovuto accettare un lavoro in un night club. Appena arrivata mi hanno chiesto se cantavo. Ho detto di no ma hanno preteso che cantassi se volevo tenere il lavoro. Allora ho cantato” [N. S. Una vita, p. 56]. Così, dal palcoscenico di una lurida bettola del New Jersey, il Midtown Bar & Grill, inizia la metamorfosi di Eunice in Nina Simone. Giovane donna in abito di mussola bianco e capelli a chignon, che volta le spalle a Dio consacrandosi alla musica del diavolo. Una poco di buono, per sua madre. Una che sprecava tutto quel talento nei bar per ubriaconi.
Ma Nina Simone, come niña cioè bambina, il soprannome che le diede un suo fidanzato latino e Simone come la Signoret nel film Casco d’oro, lei aveva un diverso destino. Che contemplava il pianoforte ma soprattutto il canto. Aveva sempre cantato in chiesa con la madre, da bambina, ma solo ora si rendeva conto delle potenzialità della sua voce e di quel timbro ammaliante. Di quelle due sole ottave in cui il suono poteva farsi suadente o rabbioso, profondo, setoso. Una voce da contralto piena di grazia. Che canta musica classica, pop, varietà, inni religiosi. Una musica versatile attraverso cui Nina racconta la storia dolorosa dell’America razzista.
Nel 1955 Rosa Parks veniva arrestata per essersi rifiutata di cedere il suo posto a un passeggero bianco. Poco dopo iniziava il boicottaggio della Montgomery City Lines. L’Alabama metteva al bando l’organizzazione per la difesa delle persone di colore. Il giovane pastore Martin Luther King cominciava a predicare alla Dexter Avenue Baptist Church.
In città si sparge la voce: una giovane musicista di colore suona qualcosa di unico. Un repertorio che si arricchisce di brani tratti da Porgy & Bess di George Gershwin, tra cui I loves you Porgy
e Summertime.
Quando Nina li intona per la prima volta cade il silenzio. Insieme al chitarrista Alvin Schackman, conosciuto nei locali, Nina entrerà nel music business incidendo il suo primo album: 1956, Good Bait. Conteneva For all we know,
You’ll never walk alone,
il bolero Plain gold ring con un’emozionante introduzione a cappella.
Poi lo swing Love me or leave me,
la ballata Little girl blue con l’introduzione del pianoforte da pelle d’oca
e due brani musicali scritti al momento: African Mailman
e Central Park blues.
Infine My baby just cares for me, canzone inoffensiva a cui Nina dovrà il suo più grande successo commerciale.
Segue l’album Little girl blue che la critica elogia sottolineando la tecnica della pianista e la voce profonda e interessante di Nina. Ne escono altri, come Nina Simone & her friends, The amazing e Starring Nina Simone, album dal vivo del concerto di Philadelphia del 1957: “La si sente arringare il pubblico, commentare il viavai del club, offrire una versione allungata di Don’t smoke in bed. C’è tutta l’autorità della pianista, la sua tecnica è chiara, capace di mantenere un equilibrio permanente tra il dramma e la leggerezza dello swing” [N. S. Una vita, p. 86].
Cominciano i concerti nei luoghi eletti, le sale votate alla musica classica, come il Town Hall di Pittsburgh. Nina apre il live con il folk Black is the colour of my true love’s hair, traditional scozzese degli Appalachi, storia di una giovane che attende il suo amore.
Seguono gli standard: lo swing Exactly like you di Billie Holiday, di cui Nina verrà considerata l’erede,
la ballata The other woman,
e il classico Wild is the wind.
Poi composizioni strumentali come Under the lowest
o Return home.
Il giorno successivo la stampa annuncia la nascita di un’artista folgorante. Nina aveva raggiunto i suoi obiettivi: i palcoscenici, il denaro, la fama, la rispettabilità, una carriera, il successo. Piovono proposte, collaborazioni, ingaggi da locali prestigiosi. Come il Vanguard, tempio folk nella Greenwich Village dell’effervescenza artistica e politica dei primi anni Sessanta. Poi il Casino Royale di Washington, il Blue Note di Chicago, il Village Gate di New York.
La grande cantante folk Odetta la inizia alle radici del folklore americano, facendole conoscere brani tradizionali come Nobody knows you when you’re down and out,
insieme a brani suggestivi come House of the rising sun.
Ma il mondo di Nina è variegato, e c’è spazio anche per le canzoni di un cantautore francese raffinato come Charles Aznavour conosciuto in un club di New York. Nel giro di qualche anno ne registrerà alcune: Tomorrow in my turn
e You’ve got to learn.
Brani incisi per la Philips insieme a una versione di Ne me quitte pas di Jacques Brel che Nina prova per tre anni prima di cantare: “Ero a New York, ascoltavo quella canzone senza capirne assolutamente il testo e ogni volta che Brel diceva Ne me quitte pas mi mettevo a piangere.” [N.S. Una vita, p.178].
Il 30 giugno 1960 Nina viene invitata al Newport Jazz Festival. Canta You’d be so nice to come home to di Cole Porter,
il blues Trouble in Mind,
il vivace Little Liza Jane
e un brano da lei composto, Flo Me La che significava “marciare” e accompagnava i lunghi spostamenti dei guerrieri yoruba. È il primo brano in cui Nina afferma la sua africanità, un grido di guerra, la dichiarazione di una identità rivendicata da una musicista in cerca di sé.
Ma è solo nel 1961, quando Nina compie il suo primo viaggio in Africa e calpesta la terra dei suoi antenati, che comprende la sua condizione: un’africana che vive sul suolo americano. Era necessario riconquistare le proprie radici, lottare per l’affermazione della comunità nera, schiavizzata e umiliata da più di quattrocento anni. Ad affiancarla in questa battaglia ci sono i due grandi poeti di Harlem, James Baldwin e Langston Hughes, leader della vita intellettuale nera americana, promotori dell’iniziazione di Nina alla storia della sua cultura originaria. Sono loro a comprendere che la sua personalità avrebbe potuto essere fondamentale alla causa della riconquista dei diritti civili per i neri. Mentre Newark, Detroit, le città nere del New Jersey e del Michigan sono incendiate da rivolte, forte si leva la voce di Martin Luther King, che avrebbe portato il popolo nero a ottenere il diritto di voto. Ma se il Movimento per i diritti civili canta We shall overcome insieme a Joan Baez e sotto la presidenza Kennedy si svolgono le prime marce pacifiche per la libertà, Nina si rende conto che la nonviolenza e l’amore professati da King non sarebbero bastati a combattere il potere politico. Era il momento di incitare le masse di fronte all’ingiustizia.
Fondamentali al conseguimento di questa causa sono alcuni incontri: con l’artista sudafricana Miriam Makeba, figura leggendaria nella lotta per l’uguaglianza dei neri e il marito Stokely Carmichael, portavoce dei Black Panthers, corrente che rompeva con la politica della nonviolenza. Ma prima, Lorraine Hansberry, figura di spicco della vita intellettuale nera del Greenwich Village. Profondamente impegnata nel Movimento per i diritti civili, Lorraine istruisce Nina sulla condizione dei neri negli Stati Uniti. Quando Martin Luther King e altri pastori vengono arrestati, il 12 aprile 1963, durante il suo concerto a Chicago Nina mette il palcoscenico, il suo repertorio e la sua arte a servizio del Movimento, informando, spiegando, raccontando ciò che stava avvenendo. Per l’amica Lorraine, morta di cancro poco dopo, a trentaquattro anni, Nina scriverà To be young, gifted and black, dedicata alla sua memoria e alla gloria del Movimento.
L’impegno con il Movimento non rallenta la sua carriera: nel 1962 Nina incide un omaggio a Duke Ellington, Nina sings Ellington tra i cui brani troviamo Cotton eyed Joe
e nel 1963, dopo la maternità e le difficoltà con il marito e manager Andy Stroud, torna in scena con un concerto travolgente alla Carnegie Hall. Nina apre con un bolero funebre, Black swan,
suona i temi strumentali di Sansone e Dalila
e quello in stile giapponese di Theme from Sayonara.
Di fronte agli attentati che portano alla morte di giovani di colore, il 15 settembre 1963 Nina decide di fare della musica uno strumento di lotta. Al pianoforte in un’ora compone la sua prima canzone contestataria: Mississippi Goddam. Una canzone che rifiuta la nonviolenza per darsi alla lotta, una canzone diretta che denuncia l’ipocrisia del governo e dell’opinione pubblica americana che finge di non accorgersi di ciò che sta accadendo alla comunità di colore: Non siete obbligati a vivere accanto a me, ma datemi semplicemente la mia uguaglianza. Se ciò non fosse accaduto, era tempo di imbracciare le armi. Posizione che la avvicinava alle idee del leader nero Malcom X.
L’ingresso di Nina nella lotta rappresentava la sua rivincita verso le ingiustizie del passato. Era la chiave per raggiungere la propria autonomia, la strada per condurre la sua arte nella Storia.
Così il suo repertorio cambia, le protest songs scavano sempre più nella sua sofferenza, nel profondo delle sue radici africane. Ma prendono spunto anche dalle più intense esperienze culturali europee di quegli anni, come i songs di Brecht e Kurt Weil. Registrerà infatti Pirate Jenny dall’Opera da tre soldi, canzone piena di odio che Nina canta lasciando il pubblico senza fiato.
Anche Nina, come gli artisti tedeschi e quelli francesi in questi anni sperimenta che una musica non elitaria, ma comunque sofisticata, poteva toccare la coscienza delle persone. Le canzoni potevano diventare strumenti per il raggiungimento di obiettivi più importanti: la causa della liberazione dei neri, la consapevolezza delle origini di un popolo, la lotta per la fine delle sopraffazioni. Icona del Movimento, Nina inventa così un nuovo genere, la Black Classical Music, una musica composta di pop, gospel, classica, jazz, folk, capace di parlare a tutti e di incarnare la voce degli oppressi.
“C’era bisogno di me – dirà –. Potevo cantare per aiutare il mio popolo. Era diventato il pilastro della mia vita. Era ciò che più mi stava a cuore. Non il piano classico, né la musica classica, né la musica popolare, ma la musica dei diritti civili” [N.S. Una vita, p. 157]. E i suoi concerti diventano inni alla resistenza, dichiarazioni di guerra contro il popolo bianco.
La canzone di lotta le dà una tale visibilità da farle guadagnare un contratto con la Philips con cui Nina incide gli album Nina Folksy e Nina with strings, ma soprattutto I put a spell on you (1965). Sono album che la rendono popolare anche in Europa portandola in classifica con la meravigliosa Feeling Good
e I put a spell on you, canzone in cui l’amore è il frutto di un sortilegio. Intero album:
Ma il capolavoro di Nina è senz’altro Pastel blues (1965), album composto da canzoni classiche del repertorio americano: come quella a cappella Be my husband,
o la cover di Billie Holiday, Tell me more and more and then some.
Ma soprattutto due canzoni manifesto della sua poetica. La prima è Sinnerman, ispirata a un gospel rivolto a Dio: Oh peccatore, dove scappi? […] Signore mi puoi nascondere?/Peccatore, faresti meglio a pregare. Nina sembra voler dire che non ci sono più vie di scampo, forse rimangono solo le preghiere per i peccatori che nella vita hanno praticato l’ingiustizia.
La seconda canzone è Strange Fruit, canzone epocale che riprende una ballata antilinciaggio e ne fa una bomba lanciata nel mezzo di un contesto politico sprofondato nella violenza. Fino agli anni Quaranta i linciaggi erano una sorta di divertimento, rimpiazzavano l’ippica, il teatro, gli spettacoli di piazza. La canzone, scritta da un professore bianco, comunista ed ebreo di New York, si ispira a un doppio linciaggio di persone di colore avvenuto sulla linea di demarcazione tra nord e sud. Billie Holiday è la prima a cantarla nel 1939,
poi solo Nina osa tanto nel contesto tormentato delle lotte razziali degli anni Sessanta. Gli strani frutti sono corpi appesi tra i pioppi.
Tra i brani più radicali di Nina c’è poi Four Women. Canzone femminista, racconta di un cambiamento, il passaggio dalla sottomissione alle leggi dei bianchi, alla violenza per l’affermazione dei diritti dei neri. La canzone è un’autobiografia che ricostruisce la storia di Nina, partendo dalla bambina Eunice, la sua sudditanza fino all’invenzione del suo alter ego consapevole, pronta alla violenza per il raggiungimento della libertà. Sono quattro fasi della vita rappresentate da quattro donne nere il cui colore varia dal più chiaro al più scuro. Finché le donne di colore non sapranno riconoscere la loro bellezza africana invece di adeguarsi ai gusti dei bianchi non saranno mai affrancate. La prima donna è la madre o come sarebbe diventata Eunice se non si fosse ribellata e avesse ceduto allo sconforto di aver fallito il suo progetto. La seconda donna è meticcia: è Nina a metà strada tra la musica dei neri e la musica dei bianchi, il sogno della pianista classica. Poi c’è la donna schiava dei capricci degli uomini, che si annulla pur di avere una vita economicamente dignitosa. E infine c’è lei, la Nina desiderosa di vendetta per tutte le ingiustizie subite fin dai suoi avi.
Versione live:
Le canzoni erano armi e Nina non smetterà di battersi, attraverso di loro, contro altre ingiustizie. Basti pensare alla sovversiva Backlash Blues, manifesto contro la guerra in Vietnam,
come Ain’t Got No / I Got Life, contro la società americana
o I wish I knew, un inno ai diritti civili.
E poi Westwind, di Miriam Makeba, una preghiera di liberazione per il suo popolo.
The pusher, canzone di denuncia dello spaccio di droga
e Damballah, canzone sul dolore dell’essere schiavi.
L’uccisione di Martin Luther King, il 4 aprile 1968, risveglia sentimenti di rabbia e vendetta, il desiderio di una rivolta radicale e violenta. Per lui canterà Why? (The king of love is dead).
Ma con la morte di King il Movimento va in crisi e Nina si sente tradita.
Il fallimento la getta in una cupa disperazione da cui non sembra riemergere. Ma è qualcosa di più, un malessere che la accompagna da tutta una vita. Prende il nome di squilibrio psichico o di ciclotimia, di depressione, di schizofrenia. Con crisi che possono farla sprofondare dal mutismo, all’apatia, alla violenza cieca. Ogni caduta è però seguita da una nuova rinascita; ogni sofferenza per aver ceduto all’uomo sbagliato, tra rotture, divorzi, violenze, dal desiderio di trovare quello giusto. Ogni senso di colpa, dalla voglia di reagire, mettere la sua arte al servizio di chi non ha voce e come lei ha vissuto la privazione. Continue risalite e discese agli inferi. Che in scena si manifestano con la totale imprevedibilità: dalla rabbia verso gli spettatori, spesso apostrofati, al distacco, fino alla foga trascinatrice.
Vivrà periodi di isolamento musicale, viaggerà perdendosi ora alle isole Barbados, in alberghi costosissimi, ora in Africa, in Olanda, in Svizzera, in preda ai suoi tormenti.
Ma inciderà ancora album memorabili come Nina Simone and piano! (1969) in cui compare Another spring, cronaca della solitudine di una donna disperata.
In To love somebody (1969) partecipa al clima di rivolta registrando The times they are A-changing di Dylan,
Suzanne di Leonard Cohen
e la sua Revolution.
Prende parte a manifestazioni importanti come il Montreux Festival
e pubblica Nina Simone Live at Ronnie Scott’s, ultima testimonianza live del suo genio.
Muore sola, povera e malata il 21 aprile 2003 nella sua casa di Carry le Rouet, a pochi chilometri da Marsiglia. Ma resterà per sempre viva la prodigiosa Eunice, che voleva suonare la musica dei bianchi e invece ha creato Nina. La guerriera che ha trasformato la sua musica e la sua voce indimenticabile nello strumento di lotta di un intero popolo, per l’affermazione della sua indipendenza.
L’arte di Nina Simone è raccontata nel film The Legend, di Frank Lords.
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
Parte 5
Parte 6
Chiara Ferrari, coautrice del documentario Cantacronache, 1958-1962. Politica e protesta in musica, autrice di Politica e protesta in musica. Da Cantacronache a Ivano Fossati, edizioni Unicopli
Pubblicato lunedì 20 Maggio 2019
Stampato il 18/04/2024 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/pentagramma/nina-simone-larte-il-genio-e-la-rivolta/








