 Il tema del “consenso” al fascismo ha attirato nel corso del tempo l’interesse di numerosi storici e commentatori. Il dibattito, avviatosi a cavallo degli anni Sessanta-Settanta, si saldò quasi subito con quello sull’esistenza o meno di una cultura e di una ideologia fascista mentre di pari passo emergeva, anche se con molta lentezza, la necessità di una più articolata riflessione circa il grado di compromissione degli italiani con la dittatura. In questo lungo e tortuoso percorso di ricalibratura degli studi sul fascismo nel secondo dopoguerra si può forse fissare un momento di svolta decisivo tra il 1974 e il 1975 con la pubblicazione da parte di Renzo De Felice del quarto volume della biografia di Mussolini, significativamente sottotitolato Gli anni del consenso, e dello studio di Emilio Gentile sulle origini dell’ideologia fascista, che individuò le complesse radici culturali e politiche del movimento fondato a Milano nel marzo del 1919. Da quel momento l’impegno degli studiosi è andato via via aumentando nel tentativo di fornire una definizione storico-scientifica esaustiva e magari, attraverso una sorta di confronto/scontro con le tesi di De Felice, una più corretta periodizzazione del “consenso” nel Ventennio.
Il tema del “consenso” al fascismo ha attirato nel corso del tempo l’interesse di numerosi storici e commentatori. Il dibattito, avviatosi a cavallo degli anni Sessanta-Settanta, si saldò quasi subito con quello sull’esistenza o meno di una cultura e di una ideologia fascista mentre di pari passo emergeva, anche se con molta lentezza, la necessità di una più articolata riflessione circa il grado di compromissione degli italiani con la dittatura. In questo lungo e tortuoso percorso di ricalibratura degli studi sul fascismo nel secondo dopoguerra si può forse fissare un momento di svolta decisivo tra il 1974 e il 1975 con la pubblicazione da parte di Renzo De Felice del quarto volume della biografia di Mussolini, significativamente sottotitolato Gli anni del consenso, e dello studio di Emilio Gentile sulle origini dell’ideologia fascista, che individuò le complesse radici culturali e politiche del movimento fondato a Milano nel marzo del 1919. Da quel momento l’impegno degli studiosi è andato via via aumentando nel tentativo di fornire una definizione storico-scientifica esaustiva e magari, attraverso una sorta di confronto/scontro con le tesi di De Felice, una più corretta periodizzazione del “consenso” nel Ventennio.
Per quanto di primo acchito l’idea stessa di “consenso” in un regime illiberale possa apparire complicata da sostenere, l’analisi storica ha dimostrato con sufficiente chiarezza che violenza, imposizione e adesione rappresentarono i momenti cruciali di un articolato processo politico e sociale attraverso cui il fascismo assicurò a se stesso uno sviluppo duraturo. Si trattò di un cammino lento e dall’esito nient’affatto scontato che ad una pars destruens – il momento ‘violenza’ e di annichilimento delle opposizioni politiche fece seguire a stretto giro una pars construens il momento per così dire ‘propositivo’ o di ridefinizione dell’identità socio-politica che portò alla nascita, già nel corso del 1921, di organizzazioni sindacali e poi, negli anni successivi alla presa del potere, allo sviluppo di tecniche moderne di organizzazione, comunicazione e informazione in grado di assicurare al Regime una presa sempre più forte sulla società. Le importanti riflessioni di Alberto Aquarone, cui fecero seguito gli studi di Jens Petersen e di Adrian Lyttelton, per citare solo gli storici che per primi si posero questi problemi, dimostrarono che il combinato disposto fra repressione, che non venne mai meno, e costruzione del “consenso” contribuì a generare forme diverse, inizialmente rassegnate ma poi opportunistiche, “interessate” e talvolta incoerenti, di adesione al nuovo corso fascista. L’analisi storica delle molte realtà locali appare in questo senso decisiva poiché aiuta a cogliere maggiormente le sfumature e le linee di frattura: consente cioè di descrivere come i vari soggetti aderirono al fascismo in forme differenziate, spesso interagendo in maniera tutt’altro che passiva con il nuovo corso politico stando ben attenti al proprio particulare e comunque non perdendo mai di vista l’esigenza di fare i conti con le necessità della vita quotidiana.

(da https://it.wikipedia.org/wiki/Fasci_italiani_di_combattimento#/
media/File:Fasci_di_combattimento_di_Lissone.jpg)
È bene sottolineare che l’adesione al nuovo corso fascista iniziò a prendere forma molto prima della fase matura dell’esperimento dittatoriale e totalitario. I dati, da soli, esemplificano molto bene questo processo. I Fasci di combattimento, nati a Milano il 23 marzo 1919, trascorsero i primi mesi di vita tra enormi difficoltà politiche ed economiche. Alla fine dell’anno, dopo la pesante sconfitta elettorale alle elezioni generali del novembre, il fascismo contava appena 31 sezioni e 870 iscritti. Si pensi che negli stessi mesi il Partito socialista aveva circa 200.000 iscritti e il Partito popolare, nato da poco, circa 100.000. Tuttavia, nel corso del 1920, il fascismo iniziò una veloce risalita: al 31 dicembre le sezioni erano già 88 e gli iscritti 20.615. Un anno più tardi il fascismo, diventato ormai Partito nazionale fascista, contava già 217.000 iscritti, quasi tutti reclutati al centro-nord, nelle aree agricole della Lombardia, dell’Emilia-Romagna, del Veneto e della Toscana. Un fenomeno di riconversione che non passò certo inosservato ai contemporanei, tanto è vero che Antonio Gramsci, proprio nel giugno 1921, osservò laconicamente che «molte leghe di contadini» avevano «stracciato la bandiera rossa» ed erano «passate al fascismo». E questo processo non era destinato ad arrestarsi: nel maggio 1922, infatti, gli iscritti erano già saliti a 322.000, un numero che faceva del Pnf il più forte partito in Italia. Nove mesi dopo la presa del potere la creatura politica di Mussolini arrivò ad allineare addirittura 625.000 iscritti.
Certo, è innegabile che tra l’inizio del 1920 e la marcia su Roma (ma anche oltre) il fascismo irruppe nell’agone politico italiano con una carica di violenza, connaturata all’essenza stessa del movimento, di cui la storiografia ha ampiamente descritto metodi e obiettivi. Tuttavia lo squadrismo sembrerebbe giustificare lo stato di immobilismo e di catalessi politica in cui caddero il Partito socialista e quello popolare, ma difficilmente può aiutarci a capire le ragioni della repentina conversione al fascismo di migliaia di lavoratori in poco più di anno, anche in quelle aree con una più consolidata tradizione di sinistra. Ragioni che vanno giocoforza ricercate anche altrove. Bisognerebbe ad esempio riflettere sul fatto che una parte non minoritaria dei primi fascisti, pur attestandosi su posizioni nettamente antisocialiste, non amava certo essere confusa con gli aderenti alle numerose associazioni nate per contrastare il movimento dei lavoratori. Antisocialisti ma non antiproletari, erano soliti ripetere questi uomini. Il mito dominante fra la maggior parte di questi fascisti, anche di quelli che si consideravano all’estrema sinistra del movimento, spesso uomini nuovi della politica, non era dunque la rivoluzione sociale ma bensì la rivoluzione italiana da cui sarebbe scaturita una nazione rigenerata e priva dei deleteri conflitti di classe.
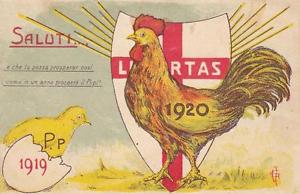
Inoltre, non bisognerebbe dimenticare che nelle aree agricole del centro-nord, già nel corso del 1920, il fascismo iniziò a guadagnare consensi tra i piccoli proprietari, affittuari, coloni e talvolta salariati, magari vicini al Partito popolare, che avevano più o meno direttamente subito l’avanzata trionfale delle leghe rosse e i provvedimenti da loro richiesti. Le squadre d’azione, talvolta, nacquero anche per difendere queste categorie e non soltanto la grande proprietà terriera. Ha scritto, giustamente, Salvatore Lupo, lo squadrismo «non va ricondotto a un gioco binario tra agrari e bracciantato» anche perché la realtà sociale delle campagne italiane era molto più articolata di quel che talvolta si sarebbe portati a pensare e non tutte le categorie era portatrici degli stessi interessi. Sebbene, dunque, sia errato attribuire alle dinamiche di adesione al fascismo tra il 1920 e il 1922 i caratteri evidenti di un movimento di massa, i progressi in termini di “consenso” sono innegabili: e lo sono tanto più se si considera che la sua proposta in materia di politica agraria e, assieme, sindacale, iniziò ad attrarre non soltanto i proprietari terrieri, per i quali dopo mesi di ripiegamento, il fascismo rappresentò l’unica alternativa alla capitolazione, ma anche una parte del composito mondo dei lavoratori della terra i quali, fiaccati da mesi di incursioni squadriste, limitati dalla tattica attendista del Partito socialista, cominciarono a considerare anche proposte politiche alternative e, alla lunga, più attrattive. A questo proposito appaiono ancora corrette le linee interpretative fornite da Paul Corner il quale pur ammettendo che «la violenza ebbe indubbiamente il suo effetto, e furono molti a venir costretti ad iscriversi, pur con molta riluttanza, ai sindacati fascisti», invitò a riflettere sul fatto che «attribuire tutto questo all’azione delle squadre significherebbe mancare in parte il bersaglio». La «vera arma psicologica del fascismo» fu, dunque, «la sua politica agraria che prevedeva la sistemazione sulla terra dei lavoratori agricoli». Essa, «più di ogni altra cosa», fece leva «sulle paure e sfruttò le speranze, andando incontro con grande accortezza alle differenziate aspirazioni» dei contadini. Il problema della terra venne enucleato denunciando in primo luogo la vacuità del massimalismo socialista e l’impoverimento progressivo che questo avrebbe comportato dal momento che i Fasci, fermamente contrari alla socializzazione della terra, auspicavano che gradualmente tutti i coltivatori fossero elevati alla dignità del possesso effettivo e diretto. Un tale programma, teso a rispondere ad una aspettativa di terra che senza dubbio si era diffusa tra i lavoratori in seguito alla guerra, fu sostanziato, in molti casi, dalla garanzia offerta dai Fasci stessi di intervenire direttamente presso i proprietari per ottenere la cessione dei terreni e farsi addirittura animatori, come a Ferrara e a Siena, di scioperi e agitazioni.

Salvatore Lupo ha rilevato che vi furono due flussi che fecero del fascismo «un movimento di massa»: il primo arrivava dalle città ed era «rappresentato dai diversi gruppi borghesi mobilitati alla politica con l’interventismo e il reducismo, ma momentaneamente tagliati fuori dal potere locale dai successi elettorali socialisti e cattolici», soprattutto in seguito alla tornata elettorale amministrativa dell’autunno del 1920. Il secondo flusso arrivava invece dalla campagna e comprendeva «affittuari grandi e piccoli, piccoli proprietari, coloni e braccianti» che si avvicinarono al fascismo attratti da una diversa proposta politica. «Tale doppia (e assai disomogenea) configurazione – continua Lupo –, borghese e popolare, impedisce al fascismo di ridursi a guardia bianca degli agrari, o al conglomerato di “corpi franchi” antibolscevichi destinati a dissolversi» con il venir meno della minaccia rivoluzionaria. Un ruolo rilevante in questo strano processo politico e sociale l’ebbe il fatto che a raccogliere i frutti della proposta fascista, nelle campagne, andarono uomini provenienti dal sindacalismo rivoluzionario (e non i leader dell’Agraria) i quali adoperavano un lessico politico immediatamente comprensibile al mondo dei lavoratori. In questo senso, si potrebbe concludere, la vicenda di questi anni, molto complessa, può essere letta anche come una «violenta» e spasmodica «ricerca del monopolio dell’organizzazione delle masse» da parte del fascismo al fine di sostituirsi alle organizzazioni rosse e bianche con una propria concreta proposta politica radicalmente alternativa.
Federico Melotto, Direttore dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e della società contemporanea
Pubblicato giovedì 24 Gennaio 2019
Stampato il 02/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/longform/il-fascismo-un-consenso-che-arriva-da-lontano/






