
In primo luogo occorre chiedersi perché tanti lettori di giornali, spettatori televisivi politicamente informati, progressisti ma moderatamente tali perché “realisti”, abbiano capito così poco di quanto stava per avvenire negli Stati Uniti. Ricostruiamo i messaggi mediatici. La rete avrebbe potuto essere una ciambella di salvataggio, ma bisogna saperla afferrare, avere l’età per amarla, come diceva una vecchia canzone.
La stecca del concerto mediatico

“La prima risposta è quella che conta, signora Longari!”. Non importa se New York Times o La Repubblica, la lettura delle reazioni alla vittoria di Donald Trump a persone della mia generazione fa venire in mente la battuta di Mike Bongiorno all’infelice signora che aveva sbagliato la prima risposta al quiz che le era stato rivolto a cui era seguita quella giusta. L’intero concerto mediatico della classe dirigente occidentale – chiamiamo le cose col loro nome – per mesi e mesi 1) in una prima fase ha dato ampio spazio a Trump e agli orrori che vomitava, forse nella segreta speranza che egli potesse diventare l’avversario di comodo di Hillary Clinton (come se fosse Salvini l’unico avversario di Renzi); 2) ha ignorato o minimizzato la labilità di costei, menomata da conflitti d’interesse – potenziali armi di ricatto qualora avesse occupato la Casa Bianca – quali l’Arabia Saudita, altri amici dell’ISIS e Goldman Sachs e buona parte dell’alta finanza statunitense, principale responsabile della crisi economica ancora in atto; 3) ha ignorato o minimizzato la sfida di Bernie Sanders, sostenuta da milioni di giovani e vincente delle primarie in ben 21 Stati dell’Unione, malgrado la scarsa visibilità e altri handicap (le assurdità regolamentari delle primarie, aggravate dalle manipolazioni, dimostrate dalle mail, dell’apparato di partito e continue denunce rimaste senza risposta di brogli soprattutto nelle decisive tornate di New York e della California); 4) avendo ormai realizzato che il presunto avversario di comodo era diventato il mostro di Frankenstein, ha finto l’imbattibilità dell’infelice signora Clinton, nella presunzione di compiere una profezia che si sarebbe autoadempiuta, con il supporto di sondaggi opportunamente selezionati (salvo ignorare quelli che continuavano a dare Sanders vincitore di Trump con 8 punti di distacco). Soprattutto, sopra ogni altra ragione, 5) ha continuato a non dare conto delle profonde ragioni sociali ed economiche di una furia maggioritaria nel Paese, intercettata da Trump ma non da Hillary Clinton: l’ineguaglianza crescente dagli anni di Reagan e della Thatcher (mascherata dai coniugi Clinton con l’aiuto di una congiuntura espansiva) è la risultante di una redistribuzione della ricchezza a favore di un’esigua minoranza di ricconi fiscalmente privilegiati a scapito del resto della popolazione e in particolare di giovani disoccupati e sottoccupati, lavoratori licenziati o a rischio, una massa di donne e di uomini abbandonata al degrado di un Paese quasi del tutto privo di ammortizzatori sociali (malgrado qualche sforzo di Obama in senso contrario).

Il boom della diseguaglianza
E ora? Citiamo un esempio della correzione di rotta. Un esempio alto, quello di Alan Johnson, non soltanto per la qualità delle argomentazioni, ma anche perché pubblicato la notte in cui stavano affluendo i primi risultati elettorali (cfr. The New York Times International Edition, 9 novembre, 2016, pp. 1 e 17). Citiamolo come e quanto merita:
“Gli iracondi si sentono abbandonati a loro stessi mentre assistono all’esplosione dell’ineguaglianza. Nel 1950 gli introiti medi di dirigenti aziendali britannici erano trenta volte superiori a quelli del lavoratore; nel 2012, 170 volte. Richard Wilkinson e Kate Pickett, nel loro studio The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone” hanno dimostrato che l’ineguaglianza estrema si associa a crescenti problemi di salute, crisi familiari e criminalità, disturbi mentali e uso di droghe – come anche un generale indebolimento a quello che i politici chiamano ‘coesione sociale’.”
E, tanto per fugare il sospetto che si tratta soltanto di un problema britannico, Johnson aggiunge: “Costoro si sentono esclusi dallo sviluppo. Lo sono. L’OCSE ha constatato che in Danimarca, dal 1975 al 2007, il 90% della popolazione ha usufruito del 90% della crescita della ricchezza. Provate a confrontare queste cifre con gli Stati Uniti ove, negli stessi anni, il 10% della popolazione si è appropriata dell’80% della crescita.”. Aggiungerei da parte mia, senza cifre a disposizione, che la crisi successiva al 2007 ha sensibilmente modificato queste cifre a favore della minoranza che è difficile non individuare come principale responsabile della stessa crisi.
In questi giorni è possibile trovare analisi meno stringenti ma dello stesso tenore, che cospargono di lacrime di coccodrillo le pagine e le immagini dei media moderatamente progressisti alla disperata ricerca di una spiegazione corretta della vittoria di Donald Trump. Almeno la seconda risposta della signora Longari era giusta. Nel nostro caso c’è chi vi si avvicina, come il citato Johnson, ma raramente viene affermato con parole semplici che il risultato di Trump dipende soprattutto dal fatto che egli è riuscito ad intercettare quella parte di una sofferenza e di una protesta che è disposta a tollerare, addirittura a condividere, i disvalori che egli rappresenta. Soprattutto, che la candidatura di Hillary Clinton ha rappresentato in maniera emblematica quegli interessi, quella classe dirigente, quelle aggressività militari che costituiscono l’attuale assetto di potere che domina il mondo. Ciò che, sopra ogni altra cosa, continua a mancare è un’analisi dell’indebolimento delle istituzioni politiche e di chi le occupa in un mondo in lenta e accidentata transizione, irta di pericoli, verso un multipolarismo ancora non strutturato in cui esercita il potere preponderante chi è in grado di spostare capitali e produzione, senza riguardo per le conseguenze umane che ne derivano, gestire la rivoluzione tecnologica in atto, controllare le informazioni e i dati necessari allo scopo (i così detti big data), per nessun altro fine se non il proprio arricchimento. È inquietante pensare che la Cina è il solo paese che sfugge a questa dicotomia tra potere reale e potere formale o istituzionale, accompagnato da una corruttela in continua crescita, perché ciascuno di questi fattori si concentra in un solo luogo, il partito comunista cinese.
La sbagliata lettura del presente
 Tutti i governanti occidentali soffrono della stessa sindrome. Obama, May, Merkel, Hollande, buon ultimo il piccolo Renzi, sono propagatori di una lettura del presente che li condanna ad una condizione di debolezza, bersaglio scontato della furia delle schiere crescenti di dispossessati. La loro mediocrità soggettiva – cui sfugge Obama per la sua lucidità intellettuale, pur manifestata con eccessiva prudenza – risulta secondaria rispetto alla debolezza strutturale che li affligge. Essi sono chiamati a rispondere di poteri e competenze e poteri che, se non in misura limitata, esistono più soltanto sulla carta, come sono scritte nelle costituzioni e nelle leggi. Per fare un esempio concreto, Hollande è alla guida dell’unica repubblica presidenziale presente in Europa, in virtù della quale deve rispondere degli stessi poteri che furono dei suoi più lontani predecessori, da de Gaulle a Mitterand. Egli continua a risponderne, ma non ne dispone se non in piccola parte, perché sono stati trasferiti altrove. Di solito i nomi del passato vengono richiamati per ridicolizzare quelli del presente. Un gioco dialettico tentante perché costoro non avevano subito quella menomazione non soltanto della politica ma delle stesse istituzioni che essa è chiamata a gestire, in atto in misura crescente dagli anni Ottanta, in particolare dalla fine della Guerra Fredda. I media per lo più selezionano informazioni e manipolano interpretazioni funzionali all’oligarchia dominante che finisce per credere alla propria propaganda. Di essa ha fatto parte, lo ripeto, una previsione del futuro che costituisce una sorta di profezia che aveva lo scopo, consapevole o meno, di autoadempiersi. Da cui la sorpresa, non tanto della vittoria di Trump, quanto della sconfitta di Hillary Clinton.
Tutti i governanti occidentali soffrono della stessa sindrome. Obama, May, Merkel, Hollande, buon ultimo il piccolo Renzi, sono propagatori di una lettura del presente che li condanna ad una condizione di debolezza, bersaglio scontato della furia delle schiere crescenti di dispossessati. La loro mediocrità soggettiva – cui sfugge Obama per la sua lucidità intellettuale, pur manifestata con eccessiva prudenza – risulta secondaria rispetto alla debolezza strutturale che li affligge. Essi sono chiamati a rispondere di poteri e competenze e poteri che, se non in misura limitata, esistono più soltanto sulla carta, come sono scritte nelle costituzioni e nelle leggi. Per fare un esempio concreto, Hollande è alla guida dell’unica repubblica presidenziale presente in Europa, in virtù della quale deve rispondere degli stessi poteri che furono dei suoi più lontani predecessori, da de Gaulle a Mitterand. Egli continua a risponderne, ma non ne dispone se non in piccola parte, perché sono stati trasferiti altrove. Di solito i nomi del passato vengono richiamati per ridicolizzare quelli del presente. Un gioco dialettico tentante perché costoro non avevano subito quella menomazione non soltanto della politica ma delle stesse istituzioni che essa è chiamata a gestire, in atto in misura crescente dagli anni Ottanta, in particolare dalla fine della Guerra Fredda. I media per lo più selezionano informazioni e manipolano interpretazioni funzionali all’oligarchia dominante che finisce per credere alla propria propaganda. Di essa ha fatto parte, lo ripeto, una previsione del futuro che costituisce una sorta di profezia che aveva lo scopo, consapevole o meno, di autoadempiersi. Da cui la sorpresa, non tanto della vittoria di Trump, quanto della sconfitta di Hillary Clinton.
Per questo nei mesi scorsi mi è capitato di scrivere più volte che, se era incerto l’esito delle candidature in campo, era invece certa ed evidente la sconfitta del popolo americano, se non delle istituzioni democratiche più robuste del mondo. Innanzitutto perché esso, come capita sempre più spesso in altri paesi – non soltanto in Ucraina – si è visto costretto a scegliere tra due opzioni, per ragioni diverse e in diversa misura bacate o, come dicono gli stessi Americani, flawed, in quanto quella non a caso risultata vittoriosa ha speculato sull’esautoramento economico e sociale del proprio elettorato potenziale, mentre l’altra ha finto di non accorgersene. Mentre quel popolo si accorgeva, eccome, che era stato messo nell’angolo da un sistema politico che non offriva alternative come dimostrano sondaggi, da questo punto di vista unanimi, che per mesi hanno registrato non solo il rifiuto, ma un crescente senso di raccapriccio suscitato da entrambi le candidature da parte di un 60% dell’elettorato. In queste condizioni lo scontro non poteva essere che radicale, in questo caso con quegli effetti degenerativi che, in prima battuta indotti da Trump, hanno finito per contaminare i comportamenti di Hillary Clinton e dell’apparato di sostegno da cui era circondata, media tradizionali e on line compresi. Un esempio per tutti: il New York Times ha costituito uno degli artefici/vittime di questa degenerazione dello scontro politico. Il giornale noto per la propria probità giornalistica, che ha tuttora per fiero motto “All the news that’s fit to print” (Tutte le notizie degne di essere pubblicate), senza omissioni e manipolazioni di comodo, con il continuo sforzo di separare le notizie dalla linea politico, offrendo una gamma variegata e pluralista di commentatori di diverso orientamento, si è gradualmente trasformato un organo di parte. Se a ciò si aggiunge che la principale istituzione preposta alla garanzia della sicurezza dei cittadini, la “Federal Bureau of Investigation” (FBI), è stata autoridicolizzata dal suo direttore, capace di prendere tre posizioni tra loro contraddittorie nei due mesi precedenti il voto riguardo alle mail di Hillary Clinton al punto di permetterle, con una forzatura soltanto parziale, di attribuirgli la ragione della propria sconfitta.
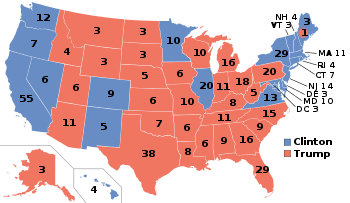 I limiti del sistema elettorale americano
I limiti del sistema elettorale americano
Più in generale, il sistema elettorale di fatto vigente ha mostrato la corda. Non mi riferisco alla discrepanza tra numero totale di voti (a favore di Clinton) ed esito dell’elezione: essa ha diversi precedenti, conseguenza di un sistema federale storicamente consolidato che non è modificabile. Il problema è quello di una legislazione elettorale e di prassi variabili Stato per Stato anche per elezioni federali, a cominciare dalle primarie: difficoltà di ammissione al voto (registration), code infinite in luoghi di voto caoticamente gestiti in una sola giornata lavorativa, collegi elettorali definiti secondo le convenienze delle maggioranze congressuali (jerrymandering). Antichi mali, che in una situazione, come quella attuale, diventano occasione di ulteriori manipolazioni e di tensioni a scoppio ritardato. Si rifletta sulle manifestazioni ex post, dirette contro l’esito elettorale, per noi difficilmente comprensibili, abituati come siamo ad un’organizzazione elettorale che costituisce un unicum di efficienza della nostra pubblica amministrazione. Insomma, vi è pane per i denti degli osservatori internazionali dell’OSCE se sapranno fare il loro dovere. Nel contesto in cui sono avvenute, queste elezioni presidenziali hanno incrinato ulteriormente la fiducia dei cittadini nella loro democrazia. E questo non è poco!
È sfuggito ai più che, ben prima di questa campagna elettorale, era cambiata la natura stessa dello scontro elettorale attraverso l’oscillazione del numero di partecipanti al voto presidenziale. Dal 1980 al 2004 la partecipazione, relativamente stabile, aveva oscillato tra il 49% e il 55% e, salvo per la prima elezione di Reagan, frutto della galvanizzazione di una parte dell’elettorato di destra tradizionalmente assente, all’agone presidenziale partecipava all’incirca lo stesso tipo di elettore tendenzialmente moderato. In quella fase vinceva il candidato capace di conquistare l’elettorato indipendente, per l’appunto moderato. A partire dalla prima elezione di George W. Bush la partecipazione al voto comincia ad oscillare oltre il 55%, fino a raggiungere la punta massima del 61,6% con la prima elezione di Barack H. Obama. In questo caso il candidato democratico, come precedentemente era riuscito a Reagan e a George W. Bush, è riuscito a portare al voto una parte della popolazione tradizionalmente astensionista: in particolare giovani ed afro-americani. Di per sé un fatto democratico rilevante, ma che ha comportato la radicalizzazione dello scontro. In altre parole, vince colui o colei che ha la capacità maggiore capacità di motivare alla partecipazione il maggior numero di potenziali elettori. Anche se – fatto degno di nota – finora non è stata comunicata la percentuale di partecipazione al voto nelle elezioni appena avvenute, è del tutto evidente che la vittoria di Trump è legata alla sua capacità di motivare al voto un elettorato di destra tradizionalmente assente, anticipata dal movimento del così detto Tea Party, mentre Hillary Clinton ha dovuto fare i conti con la delusione soprattutto dei giovani sostenitori di Bernie Sanders.

La sconfitta di chi insegue la destra finanziaria
Veniamo ora agli esiti politici della vicenda. Il più chiaro riguarda il partito democratico che, per la sua importanza oggettiva, si riflette su tutta la sinistra e il centro-sinistra occidentale. La sconfitta di Hillary Clinton e di tutto ciò che la sua candidatura ha rappresentato segna un punto di svolta di un processo carsico in atto da tempo, ma che in questa occasione è diventato visibile in misura tale da tradursi in politica. Per dirla con una battuta: è la fine del blairismo, del clintonismo e di tutto ciò che ad esso s’ispira (compreso il piccolo Renzi di casa nostra). L’inseguimento della destra finanziaria ed economica, prima ancora che politica, da parte di forze e partiti politici che storicamente aspirano ad una maggiore eguaglianza, non può che portare alla sconfitta politica, con ogni probabilità nel breve, sicuramente nel lungo periodo. Il discorso merita un ragionamento approfondito a parte. Qui limitiamoci al contesto statunitense. Da tempo questo tipo di orientamento politico fa acqua a livello intellettuale. Stiglitz, Krugman (malgrado la sua recente adesione strumentale alla candidatura di Hillary Clinton), Piketty, agli occhi di buona parte dell’opinione pensante negli Stati Uniti, hanno minato il così detto pensiero unico liberista che esclude scelte postkeynesiane, di regolazione del mercato (non soltanto l’esclusione del Glass- Steagall Act che a suo tempo separò le banche commerciali da quelle d’investimento, ma anche il Dodd-Frank Act che ne costituisce la versione mitigata di stampo clintoniano), di intervento a scopo sociale e nell’istruzione. Lo stesso Francis Fukuyama, noto teorico della fine della storia, ha recentemente denunciato l’abitudine dell’establishment liberista a liquidare come populismo qualsiasi forma di resistenza all’affermazione dei suoi interessi. Una nuova generazione di ricercatori delle principali università continuano a smontare i presupposti numerici su cui i vari Alesina (che continua indisturbato a pubblicare editoriali sul Corriere della Sera) fondano le loro teorie secondo cui l’arricchimento dei pochi porterebbe maggiori benefici a tutti. È questo il substrato culturale che nutre le posizioni politiche di Bernie Sanders e Elizabeth Warren (che, però, come Krugman, di fronte a Trump, ha preferito scommettere politicamente sul male minore). Sanders, alcuni suoi alleati congressuali e i giovani che in gran parte gli hanno disobbedito non andando a votare per Hillary Clinton, sono impegnati nella conquista della presidenza del comitato nazionale del partito e di alcune posizioni chiave nella gestione della minoranza congressuale. Essi hanno già ottenuto importanti risultati programmatici nella Convenzione e anche nell’impostazione della stessa Clinton negli ultimi giorni della sua campagna elettorale, ormai segnata dalla paura di Trump. Tuttavia, gli attuali detentori del potere nel partito democratico non molleranno facilmente la presa, anche se il vento della storia gioca a loro sfavore. Molto dipenderà dalla capacità di questa nuova sinistra di strutturarsi in maniera duratura all’interno del partito. Essi hanno adottato come parola d’ordine “Our Revolution”, nel contesto statunitense meno sovversiva dell’etichetta di socialista con cui si è autodefinito il loro leader. Molto dipenderà anche dalla prova del fuoco, irta di pericoli, delle manifestazioni in atto nelle strade.

Trump, o della prudenza del vincitore
Assai più difficile ed anche più complicato prevedere le future mosse del nuovo Presidente degli Stati Uniti. Egli ha i piedi in due staffe. È stato premiato dalle istituzioni vigenti, conquistando la più alta carica nella legalità, senza nulla concedere della sua cultura sovversiva di cui è stato portatore. Con qualche forzatura egli può ascriversi le maggioranze sia alla Camera che al Senato e l’opportunità di consolidarla in seno alla Corte Suprema. Eppure egli è tutt’altro che un emarginato. Uno dei giorni precedenti il voto il New York Times ha pubblicato una foto in cui, in vestiti di gala, i coniugi Trump si ritrovavano sorridenti insieme con i coniugi Clinton. Peccato per gli astuti direttori che i potenziali elettori del multimiliardario insolvente ed eludente (il fisco) non leggono quel giornale. Tuttavia, quella foto segnala un’appartenenza socialmente lontana mille miglia del presidente eletto dalla maggioranza dei suoi sostenitori. Il discorso con cui Trump ha salutato la propria vittoria, l’onore delle armi precedentemente concesso alla Clinton, la visita al presidente tuttora in carica, pur con qualche distinguo, indicano la sua ansia ad apparire rispettoso della prassi costituzionale. Ma vi è di più. Qualche voce riguardante le nomine che egli è chiamato ad effettuare nel periodo di transizione – in particolare quella di Jamie Dimon a segretario al Tesoro, presidente ed amministratore delegato della Banca J.P. Morgan, malgrado lo avesse preso a bersaglio nel corso della campagna elettorale – fanno pensare che egli non intenda rompere con alcuni caposaldi economici cari alla classe dirigente trasversale che domina il Paese e che caratterizza la maggioranza congressuale repubblicana. Eppure Trump non può ignorare la sofferenza sociale che la sua campagna elettorale ha intercettato, le vittime della deindustrializzazione che una globalizzazione gestita dalla finanza ha determinato, la richiesta di sostegno di cui costoro hanno bisogno, la cultura in gran parte xenofoba che li segna. Non a caso egli ha precisato che la sua polemica contro il così detto Obamacare non esclude il consolidamento e, addirittura, l’estensione della tutela della sanità che essa comporta. La pregiudiziale nei confronti degli immigranti è stata circoscritta a coloro che si rendono colpevoli di atti criminosi, senza insistere sul tema dell’immigrazione illegale in quanto tale. Un programma di opere pubbliche potrebbe offrire numerose occasioni di lavoro, anche se una riforma fiscale a svantaggio dei più privilegiati, Trump compreso, risulterebbe sicuramente indigesto alla sua maggioranza. La pregiudiziale nei confronti dell’impiego di ex parlamentari nelle lobbies attive a Washington troverà sicuramente un consenso trasversale.
Ancora più difficile è formulare delle previsioni sulle scelte di politica estera di un’amministrazione Trump. Il pericolo maggiore è costituito dal suo diniego pregiudiziale dell’esistenza di una crisi climatica; ostilità conclamata nei confronti di qualsiasi forma di conversione verso fonti di energia rinnovabili, a scapito di quelle tradizionali. Né è immaginabile un ripensamento di una’impostazione fortemente autarchica di un’economia pur fortemente condizionata dalla presenza finanziaria ad esempio cinese che rende più difficile la ripresa di una tensione bipolare con la stessa Cina. Il filo comunicativo con Putin potrebbe effettivamente preludere ad un disimpegno in Europa che costituirebbe uno stimolo salutare all’Unione Europea a dotarsi di una politica di sicurezza e difesa difficilmente declinabile con la rilevanza della NATO, finora stimolata dallo stesso Putin. In quale misura Trump continuerà a subire il doppio condizionamento esercitato da quello che un suo predecessore, il generale Eisenhower, definiva complesso militare-industriale, indicandolo come una minaccia alla stessa democrazia americana? Doppio in quanto condiziona sia la strutturazione della spesa pubblica che la politica estera. Soltanto la Seconda guerra mondiale ha consentito all’economia americana di uscire definitivamente dalla crisi del ’29. Il New Deal non è stato sufficiente. Persino il più pacifista in assoluto dei presidenti successivi a quella guerra – Jimmy Carter – è stato costretto a usare le aggressività brezneviane per dare sviluppo al programma dei missili a media gittata. Al di là di questi esempi, in un epoca di impoverimento delle classe medie, è difficile per qualsiasi presidente mantenere il consenso intorno al paradosso di una spesa militare che non venga messa a frutto sul campo. Si potrebbe concludere in via del tutto provvisoria che la presidenza Trump ha l’opportunità di sorprendere nella misura in cui ogni capo politico è meglio in grado dei suoi avversari di effettuare dei mutamenti anche radicali che siano contrari alla sua identità politica. Due esempi tipici a questo riguardo sono la politica algerina di de Gaulle e le misure di disarmo effettuate da Reagan di concerto con Gorbaciov. Ciò che, invece, più preoccupa è la perdita di potere delle istituzioni politiche nei confronti di altri poteri, causate ed accompagnate dall’impoverimento dei ceti medi cui un capo politico può essere portato a reagire, ancora una volta, con il nazionalismo e la guerra.
* la versione completa sarà pubblicata sul prossimo numero di Mondo Operaio
Gian Giacomo Migone è stato presidente della Commissione affari esteri del Senato dal 1994 al 2001; ha insegnato storia delle relazioni Euro-Atlantiche presso l’Università di Torino dal 1969 al 2010; ha pubblicato recentemente The United States and Fascist Italy. The rise of American Finance in Europe, New York, Cambridge University Press, 2015, 405 pp. g.gmigone@libero.it
Pubblicato venerdì 18 Novembre 2016
Stampato il 02/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/vince-trump-ed-e-la-fine-del-blairismo-e-del-clintonismo/






