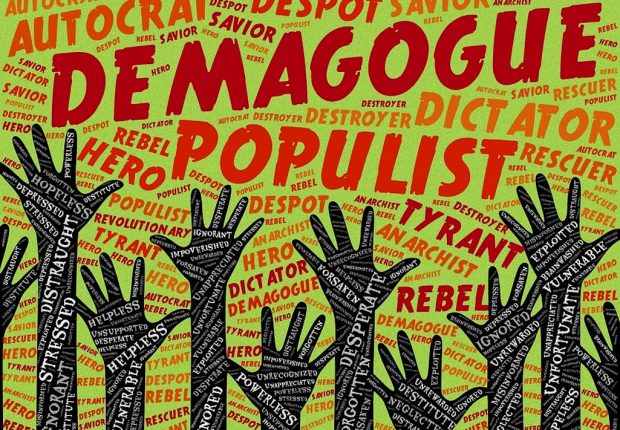 Nella pubblicistica più recente si tende talvolta a equiparare i cosiddetti “sovranismi” con i fascismi oppure si sostiene che le radici ideologiche delle “democrazie illiberali”, definite anche “autoritarismi populisti” o “neo-nazionalismi”, rimontano alle esperienze dittatoriali europee nel Novecento. Al contrario dei fascismi, i movimenti emersi impetuosamente negli ultimi anni sulla scena politica globale, e in Europa in particolare, non paiono tuttavia coltivare una vocazione totalitaria.
Nella pubblicistica più recente si tende talvolta a equiparare i cosiddetti “sovranismi” con i fascismi oppure si sostiene che le radici ideologiche delle “democrazie illiberali”, definite anche “autoritarismi populisti” o “neo-nazionalismi”, rimontano alle esperienze dittatoriali europee nel Novecento. Al contrario dei fascismi, i movimenti emersi impetuosamente negli ultimi anni sulla scena politica globale, e in Europa in particolare, non paiono tuttavia coltivare una vocazione totalitaria.
Le affinità tra i nazionalismi contemporanei e i fascismi, le cui caratteristiche principali sono l’esaltazione della violenza, l’affermazione della gerarchia, il culto del capo, il richiamo alla nazione e il superamento delle categorie di destra e sinistra – considerate faziose e strumentali rispetto alla omogeneità della comunità nazionale – riguardano principalmente la comune avversione nei confronti della democrazia liberale e del socialismo.

I movimenti di Kaczynski e di Orban, diffidano profondamente del liberalismo fondato sul pluralismo incompatibile con l’affermazione di un modello identitario dell’ordine sociale; si oppongono alla divisione dei poteri, cui preferiscono il primato dell’esecutivo quale espressione diretta della volontà nazionale; contestano la centralità legislativa del Parlamento: un’istituzione in cui spesso, secondo i neonazionalisti, sono traditi la volontà del popolo e l’interesse della nazione.

Il radicalismo di destra al potere in diverse parti d’Europa, allo stesso modo del fascismo di un secolo prima, ha visto crescere il proprio consenso e peso politico in seguito ad una crisi dello Stato liberale.
Dopo il 1989, lo Stato di diritto democratico e l’economia di mercato avevano costituito l’approdo obbligato per le élite politiche che avevano rimpiazzato la nomenklatura socialista alla guida di Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia dopo il fallimento delle Repubbliche popolari.

Le nuove élite dei “Paesi Visegrad” avevano fondato la propria egemonia sulle ricette economiche della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale cui erano associate le riforme indispensabili a incoraggiare gli investimenti esteri e favorire lo sviluppo dei saperi (expertise) necessari a trasformare un’economia centralizzata e arretrata in una evoluta e di tipo liberale. Le élite post-comuniste si erano impegnate altresì a realizzare un sistema di rule of law, nel quale il potere di ogni autorità politica, economica o giudiziaria fosse sottoposto, a differenza del passato, al controllo di legittimità costituzionale e soggetto al vincolo delle leggi.

Al programma di ricostruzione nella fase post-comunista, sostenuto da leaders carismatici, quali Wałęsa e Havel e da un’opinione pubblica “affamata di Occidente” ma drammaticamente digiuna dei riti e delle pratiche di una democrazia moderna, le nuove élite guardavano con entusiasmo al fine di superare l’arretratezza economica delle proprie comunità nazionali e agganciarle ai livelli di sviluppo delle “democrazie avanzate”.
Nel corso degli ultimi anni il ruling consensus e l’affinità politica delle élite dei Paesi Visegrad, soprattutto in materia economica, hanno subito una battuta d’arresto, determinata dal parziale insuccesso del progetto di trasformazione voluto trent’anni fa. Dopo l’89, nei Paesi dell’Europa centro-orientale, accanto all’impetuosa crescita economica, si deve registrare la permanenza di larghe sacche di povertà e l’accentuarsi, in seguito alla crisi finanziaria del 2008, di profonde diseguaglianze che hanno generato nella popolazione un diffuso risentimento verso la classe politica e una profonda sfiducia nei confronti delle istituzioni liberal-democratiche.

In questo contesto sono riemerse prepotentemente, alla maniera di un fiume carsico rimasto sottotraccia dopo la fine del Secondo conflitto mondiale, pulsioni di carattere nazionalistico intercettate da quella parte delle élite postcomuniste che ha attribuito le responsabilità dello stato di malessere sociale alle direttive economiche imposte “dagli Stati stranieri” e dalle “élite antipatriottiche”.
Il periodo post-comunista, caratterizzato dalla politica di privatizzazione selvaggia, dalla quasi completa ritirata dello Stato sul terreno economico e dalla estrema flessibilità del lavoro, ha prodotto, da una parte, uno sviluppo disomogeneo delle regioni dell’Europa centrale, attraversate da profonde disuguaglianze e dalla presenza di larghe fasce di cittadini poveri: gli “esclusi dai benefici della trasformazione”; dall’altra, a una profonda divaricazione delle élite che, dopo l’89, avevano sposato il progetto economico “lacrime e sangue” di chiara impronta neoliberale e thatcheriana.

Nel corso degli ultimi decenni, il progetto neoliberale ha non solo perso di smalto, ma ha visto erodere la sua egemonia, contrastata da protagonisti della scena politica, come Kaczynski e Orban, che da un orientamento moderato sono passati a prese di posizione radicali e apertamente nazionaliste, rivendicando il ruolo dello Stato e il primato del potere sovrano, quale espressione della volontà della nazione, nei confronti delle politiche comunitarie e delle organizzazioni internazionali.
In quelle che una volta erano definite società post-comuniste, si assiste a una crescente polarizzazione delle formazioni politiche: da una parte quelle che, nonostante le loro differenze, si definiscono “partiti liberali” e a favore dell’Unione Europea, dall’altra i movimenti politici “nazional-populisti” che si oppongono ai partiti filoccidentali. La polarizzazione della società tra “establishment e popolo”, tra “forze politiche mainstream e outsider”, unitamente alla differenziazione tra città e campagna, tra aree maggiormente evolute e quelle in una condizione di sottosviluppo, hanno provocato, soprattutto negli esclusi dal processo di modernizzazione capitalistico, un diffuso bisogno di identificazione collettiva.
 Il nazional-populismo costituisce la risposta a tale bisogno e si afferma tra gli strati sociali adusi a ridurre il dibattito politico a una lotta tra una casta di cinici avvantaggiati che detiene il potere, sia all’interno della comunità nazionale sia nel contesto internazionale, e il popolo, identificato con le fasce sociali sfruttate e autentiche depositarie dell’identità nazionale.
Il nazional-populismo costituisce la risposta a tale bisogno e si afferma tra gli strati sociali adusi a ridurre il dibattito politico a una lotta tra una casta di cinici avvantaggiati che detiene il potere, sia all’interno della comunità nazionale sia nel contesto internazionale, e il popolo, identificato con le fasce sociali sfruttate e autentiche depositarie dell’identità nazionale.
Il nazional-populismo si muove in un contesto diverso dal nazionalismo che un secolo fa ha preceduto la nascita del fascismo: in una società moderna e nell’ambito di rapporti internazionali nei quali la nazione deve conquistare uno spazio di manovra all’interno dei consessi di cui fa parte e secondo procedure che essa stessa ha contribuito a creare oppure cui ha aderito.

La definizione “nazional-populismo” è da preferirsi a quella di “sovranismo”. Un autentico sovranismo dovrebbe rivendicare per lo Stato nazione, oltre allo ius ad bellum – cui ogni nazione ha rinunciato per entrare a far parte dell’ONU – l’uscita dalle istituzioni europee, dalla NATO, dall’UE, finanche dal Gruppo di Visegrad in favore della piena ricostituzione della sovranità nazionale accompagnata dalla cancellazione dell’insieme di norme di carattere internazionale che regolano in linea generale i rapporti tra i popoli. Nessuno dei nazional-populisti, in Polonia come in Ungheria, in Slovacchia come nella Repubblica Ceca, asserisce di voler tornare a una sovranità “piena” o di tipo moderno, semmai il loro scopo è il rafforzamento delle proprie posizioni nelle istituzioni e nelle grandi famiglie politiche europee. Questo, ad esempio, è il caso di Viktor Orban il quale, nonostante gli ammonimenti da parte dell’UE rispetto alla sua azione di governo, rivendica per sé e il suo partito “Fidesz”, un ruolo non marginale nel partito maggioritario nel Parlamento di Strasburgo, il Partito Popolare Europeo di cui fa parte.

I nazional-populisti perseguono i loro obiettivi sul piano continentale sovente contravvenendo ad accordi stabiliti con forze politiche di altri Paesi simili dal punto di vista programmatico e ideologico. A dispetto delle continue, reciproche attestazioni di stima tra i leader nazional-populisti – di qua e di là dell’Atlantico – è difficile ipotizzare che vi sia tra di loro un reale sentimento di solidarietà e un’effettiva convergenza di vedute. Non può esistere, sotto questo profilo, “l’internazionale sovranista o nazional-populista”, giacché nello scenario immaginato dai nazional-populisti, quale lotta di tipo darwiniano tra le nazioni nei rapporti economico-politici a livello globale, il loro fine è esclusivamente la supremazia della propria comunità nazionale o comunque, in ultima analisi, la tutela del proprio vantaggio a danno di quello altrui. La rappresentazione del “nemico alle porte” costituisce, su questo versante, una delle caratteristiche principali dell’ideologia nazional-populista. Rispetto a un’idea di democrazia inclusiva e all’universalismo dei diritti, le cui radici sono da far risalire all’Illuminismo, il neonazionalismo rivendica una superiorità di un ceppo culturale ed etnico nei confronti di altri gruppi nazionali.
 L’“altro” è considerato “concorrente” o “nemico” degli interessi e dell’identità nazionale. Per “smascherare” il nemico e portare all’attenzione dell’opinione pubblica la minaccia che egli rappresenta, è necessario abbattere il muro di ipocrisia che il linguaggio politicamente corretto erige dinanzi all’implacabile insinuarsi di ogni “elemento ostile”. La retorica nazional-populista è infarcita al riguardo di epiteti nei confronti degli stranieri, di offese nei confronti delle rivendicazioni del genere femminile, di insulti alle persone di credo religioso differente o di diverso orientamento sessuale. La misoginia, il razzismo, l’intolleranza religiosa e l’antisemitismo, ombre che sembravano dover sparire dopo le tragedie del Novecento, ritornano di gran carriera nelle spire di un’ideologia di cui un punto cruciale è, secondo la logica schmittiana dell’“amicus/hostis”, la definizione del nemico quale elemento indispensabile per rappresentare l’identità della nazione: “il gruppo dell’ordine”, il “noi” contrapposto a “loro”.
L’“altro” è considerato “concorrente” o “nemico” degli interessi e dell’identità nazionale. Per “smascherare” il nemico e portare all’attenzione dell’opinione pubblica la minaccia che egli rappresenta, è necessario abbattere il muro di ipocrisia che il linguaggio politicamente corretto erige dinanzi all’implacabile insinuarsi di ogni “elemento ostile”. La retorica nazional-populista è infarcita al riguardo di epiteti nei confronti degli stranieri, di offese nei confronti delle rivendicazioni del genere femminile, di insulti alle persone di credo religioso differente o di diverso orientamento sessuale. La misoginia, il razzismo, l’intolleranza religiosa e l’antisemitismo, ombre che sembravano dover sparire dopo le tragedie del Novecento, ritornano di gran carriera nelle spire di un’ideologia di cui un punto cruciale è, secondo la logica schmittiana dell’“amicus/hostis”, la definizione del nemico quale elemento indispensabile per rappresentare l’identità della nazione: “il gruppo dell’ordine”, il “noi” contrapposto a “loro”.
 Proprio intorno al concetto di identità si può constatare la maggiore somiglianza tra il nazionalismo e il populismo moderni. Quest’ultimo ha tra i suoi caratteri costituivi la rappresentazione del popolo quale soggetto unico, “identitario” e omogeneo la cui volontà è incarnata da un individuo o da una pluralità di persone. La volontà del popolo deve essere fatta valere di fronte alle mire di una casta parassitaria e corrotta o alle macchinazioni di un potere estraneo al popolo e in grado di sottometterlo.
Proprio intorno al concetto di identità si può constatare la maggiore somiglianza tra il nazionalismo e il populismo moderni. Quest’ultimo ha tra i suoi caratteri costituivi la rappresentazione del popolo quale soggetto unico, “identitario” e omogeneo la cui volontà è incarnata da un individuo o da una pluralità di persone. La volontà del popolo deve essere fatta valere di fronte alle mire di una casta parassitaria e corrotta o alle macchinazioni di un potere estraneo al popolo e in grado di sottometterlo.
Nella prospettiva nazional-populista gli interessi della nazione sono calpestati dalle élite finanziarie internazionali, dalla “medicina ufficiale” che nasconderebbe, a scopo di profitto, i ritrovati miracolosi di qualche santone a beneficio dei cittadini oppure, al tempo della diffusione del Covid, persuaderebbe la maggior parte di essi all’inutile utilizzo delle mascherine al solo scopo di impaurirli e sottometterli alla casta.

In questo senso, oltre al rifiuto dell’universalismo giuridico, il nazional-populismo ribalta una delle acquisizioni fondamentali della modernità: la divisione del lavoro o differenziazione sociale secondo le competenze legate alla scienza e alla formazione. La disintermediazione, “l’uno vale uno”, non è altro che il capovolgimento dei ruoli sociali fondato sulla ricerca e, in generale, sulle forme di sapere. La cultura, le norme dello Stato e la mediazione parlamentare degli “addetti ai lavori” celebrerebbero un compromesso contrario alla reale volontà della nazione di cui i neo-nazionalisti si arrogano il diritto di essere gli unici interpreti e rappresentanti. In diversi casi, alla verità accolta dagli specialisti nei diversi ambiti della ricerca scientifica, si contrappone una “verità alternativa”, preconfezionata e che dovrebbe rispecchiare l’interesse della nazione.

Con Beck si può sostenere che si va imponendo un “nazionalismo metodologico” per cui ogni soggetto, al fine di difendere l’identità dello Stato-nazione, deve rifiutare ciò che è straniero e promuovere l’omogeneità culturale del popolo. Esisterebbe, sotto questo profilo, una scienza occidentale e “una scienza polacca”, una storiografia aderente alla narrazione delle élite liberali cosmopolite, che non tiene in debito conto il ruolo dei Paesi Visegrad nella storia europea, e una gradita alle forze nazionaliste al governo.
Da tali premesse deriva l’aspetto fondamentale del nazional-populismo: la superiorità del potere politico su ogni altro tipo di potere, economico, culturale o “generalmente” straniero, non subordinato alla volontà del soggetto sovrano: il popolo o la nazione. Il potere politico ha il compito di dare forma alla società e subordinare ogni altro potere alla volontà della maggioranza dei cittadini, per questo motivo oppone all’“autoritarismo economico” delle élite degli anni della trasformazione post-comunista l’“autoritarismo della maggioranza”: una sorta di “democrazia di tipo autoritario” o “democratura” nella quale l’unico limite all’attività dei “governi della nazione” non è costituito dalle norme costituzionali, ma da un mandato popolare di cui i nazional-populisti sarebbero i genuini portavoce.

I neonazionalismi, in maniera simile al fascismo, affermano la preminenza della difesa dell’identità nazionale sulle procedure e le istituzioni dello Stato democratico; la sostituzione del “governo delle leggi” con “il governo della nazione”; la strenua difesa dell’utile nazionale nei rapporti tra gli Stati contraddistinti dalla lotta per la sopravvivenza e l’affermazione della propria soggettività culturale. Pur rifuggendo dal culto del capo e dall’uso della violenza fisica, i leader nazional-populisti non disdegnando quella verbale per la conquista del potere. I nemici del nazional-populismo, come per il fascismo, sono il liberalismo, “ideologia straniera” che promuove l’egoismo, l’atomizzazione sociale e l’arricchimento di pochi a danno della maggioranza, e il socialismo, minaccia sempre presente, nonostante la fine della sua versione storica, che annulla le caratteristiche identitarie dei popoli allo scopo di promuovere un astratto scontro di classe internazionale.
Il riemergere del nazionalismo è dovuto alla crisi del progetto liberale inerente alla fase di trasformazione nell’Europa centro-orientale negli anni Novanta del secolo scorso.
 La crisi finanziaria del 2008 e ancor più la pandemia, con l’introduzione di misure securitarie e l’inquietante accentuarsi del potere degli esecutivi, hanno indotto una parte delle élite economiche e politiche dei Paesi Visegrad ad abbandonare piuttosto rapidamente i programmi di una destra liberale moderna a favore di un assetto politico illiberale in cambio della conservazione della ricchezza acquisita e la tutela del proprio vantaggio, grazie allo “Stato forte” sul terreno delle alleanze internazionali e degli scenari economici globali.
La crisi finanziaria del 2008 e ancor più la pandemia, con l’introduzione di misure securitarie e l’inquietante accentuarsi del potere degli esecutivi, hanno indotto una parte delle élite economiche e politiche dei Paesi Visegrad ad abbandonare piuttosto rapidamente i programmi di una destra liberale moderna a favore di un assetto politico illiberale in cambio della conservazione della ricchezza acquisita e la tutela del proprio vantaggio, grazie allo “Stato forte” sul terreno delle alleanze internazionali e degli scenari economici globali.
Il nazional-populismo ha fatto breccia altresì in una larga parte delle fasce più deboli della popolazione che si aspettano di veder migliorate le proprie vite “umiliate e offese” da una “neoborghesia compradora”, cinica e animata, anche per motivi di carattere storico, da un sentimento di inadeguatezza nei confronti della civiltà occidentale e rispetto alla quale il nuovo corso della politica nazionalista permetterebbe di prendersi una sorta di rivincita.
Nella retorica nazional-populista si mescolano rivendicazioni di carattere sociale e sogni di grandezza che non si fondano sull’emancipazione delle classi subalterne nell’ambito di una trasformazione sociale progressista ed espansiva dei diritti, ma su una torsione autoritaria del sistema connotata da neosciovinismo, megalomania, disinvoltura nei rapporti internazionali e permanente ritrattazione degli accordi comunitari. Una politica che si risolve, come dopo l’89, in una modernizzazione dall’alto; basata sulla leva del potere dello Stato e che pare aspirare principalmente alla conservazione dello status quo, saldamente nelle mani delle élite politiche ed economiche favorite dalla trasformazione, e alla passivizzazione e omogeneizzazione culturale delle masse.
 Alla realizzazione dell’interesse nazionale possono essere sacrificate le regole del gioco dello Stato liberale, tra cui la divisione dei poteri, in favore dell’instaurazione di uno Stato autoritario e sotto il controllo della formazione che rappresenta i valori della nazione e gli interessi autentici del popolo. Nonostante le critiche nei confronti dei totalitarismi del Secolo breve, strumentali e dettate dal solo obiettivo di conquistare spazio e visibilità nel contesto internazionale, come nel caso della famigerata risoluzione del Parlamento europeo dell’anno scorso relativa all’equiparazione tra nazismo e comunismo, alcuni punti in comune, tenuto conto delle diverse condizioni storiche, tra i governi nazionalisti e i regimi dittatoriali del Novecento, appaiono tuttavia non poter essere sottovalutati o sottaciuti. Tra questi la svolta autoritaria, seguita alla crisi del liberalismo, che sembra riportare pericolosamente indietro le lancette della storia.
Alla realizzazione dell’interesse nazionale possono essere sacrificate le regole del gioco dello Stato liberale, tra cui la divisione dei poteri, in favore dell’instaurazione di uno Stato autoritario e sotto il controllo della formazione che rappresenta i valori della nazione e gli interessi autentici del popolo. Nonostante le critiche nei confronti dei totalitarismi del Secolo breve, strumentali e dettate dal solo obiettivo di conquistare spazio e visibilità nel contesto internazionale, come nel caso della famigerata risoluzione del Parlamento europeo dell’anno scorso relativa all’equiparazione tra nazismo e comunismo, alcuni punti in comune, tenuto conto delle diverse condizioni storiche, tra i governi nazionalisti e i regimi dittatoriali del Novecento, appaiono tuttavia non poter essere sottovalutati o sottaciuti. Tra questi la svolta autoritaria, seguita alla crisi del liberalismo, che sembra riportare pericolosamente indietro le lancette della storia.
Daniele Stasi, docente di storia delle dottrine politiche all’Università di Foggia e di filosofia della politica all’Università di Rzeszów, Polonia
Pubblicato mercoledì 14 Ottobre 2020
Stampato il 02/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/longform/est-e-il-nazional-populismo/







