
Da quasi trenta anni si cerca di accreditare la favola di un primo ministro scelto direttamente dal popolo nel turno elettorale, un leader eletto con la sua maggioranza per la durata del mandato. Secondo tale modello il popolo sceglie il primo ministro e la maggioranza, che governano per la legislatura; il popolo valuta i risultati nel successivo voto. Queste concezioni già affiorano negli anni ’80. Craxi propone una riforma in chiave di presidenzialismo con l’elezione diretta del Capo dello Stato. Il Presidente Cossiga (il “picconatore”), nel messaggio alle Camere del 26 giugno 1991 afferma che la scelta della forma parlamentare di governo e il no al presidenzialismo nella Costituzione del 1948 venivano unicamente dall’esperienza della dittatura allora appena conclusa. In Aula, il 19 giugno 1992, in un lucido intervento Rodotà afferma: “… abbiamo assistito alla totale conversione della questione politica in questione istituzionale imputando ogni nefandezza ad una Costituzione invecchiata e non più a persone o partiti. Per fare ciò si è via via delegittimata la Costituzione nel suo insieme”. Fuori della ufficialità delle istituzioni, nel piano di riforma democratica di Gelli, al punto VI.I dei programmi a medio e lungo termine troviamo “modifica della Costituzione per stabilire che il Presidente del Consiglio è eletto dalla Camera all’inizio di ogni legislatura e può essere rovesciato soltanto attraverso le elezioni del successore”.

Nel 1994 si giunge a un pensiero istituzionale compiuto. Il Berlusconi vincente nel voto popolare lo espone con chiarezza in Senato il 16 maggio 1994: “Le forze che sostengono questo Governo non stanno insieme per una qualche alleanza o alchimia decisa nelle sedi dei partiti, bensì per una delega data direttamente dagli elettori. Quel che si è chiamato “Polo delle libertà e del buon governo” è un’alleanza elettorale che oggi si trasforma in coalizione di Governo su esplicito mandato dei cittadini … Credo che questa maggioranza e questa legislatura debbano coincidere e che per costituire una nuova maggioranza siano politicamente necessarie nuove elezioni”.
Berlusconi ribadisce il suo pensiero nel 2001, quando vince le elezioni, e ancora nel voto anticipato del 2008. Questo non meraviglia, mentre certo può stupire che accenti analoghi vengano da Prodi nel 1996, da D’Alema nel 1998, da Amato nel 2000, ancora da Prodi nel 2006 e nel 2008, nel momento della sconfitta. E che nella dichiarazione di voto sulla fiducia dello sconfitto Veltroni (14 maggio 2008) sia centrale il riconoscimento del diritto dei vincenti a governare per la durata del mandato.
Quindi, anche autorevoli esponenti di quella che fu la sinistra condividono – in parallelo con Berlusconi – una impostazione che fa perno sulla personalizzazione della politica e sull’investitura diretta del leader per la durata del mandato. Un pensiero unico che distorce la forma di governo parlamentare scritta in Costituzione. Una testimonianza si ritrova nelle campagne elettorali, che dal 1996 al 2008 vedono partiti e coalizioni inserire in misura crescente nei simboli elettorali i nomi dei leader.
È verità, o rappresentazione? La XII legislatura conosce due governi (Berlusconi, Dini), e si chiude dopo soli due anni. La XIII quattro (Prodi, D’Alema I, D’Alema II, Amato). La XIV due (Berlusconi II e III). La XV uno (Prodi II), ma si chiude con il voto anticipato. La XVI due (Berlusconi IV, Monti), la XVII tre (Letta, Renzi, Gentiloni), la XVIII finora due (Conte I e Conte II, persino con un ribaltone di maggioranze da gialloverde a giallorossa). In ventiquattro anni, sette legislature e sedici governi. In ogni legislatura, salvo la XV, c’è una successione di governi determinata da modificazioni all’interno della coalizione vincente. Il tutto accompagnato di volta in volta da polemiche sul tradimento degli elettori, e sulla necessità di andare a nuove elezioni piuttosto che dar vita a governi non legittimati dal consenso popolare.
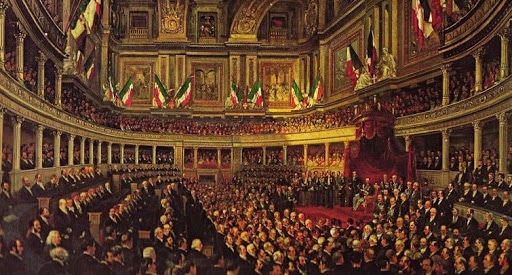
Se una tesi non trova riscontro nella realtà per quasi trenta anni, saggezza vuole che si metta da parte. Al contrario, la storia delle riforme istituzionali nel nostro Paese si riassume nel tentativo di ridurre forzosamente la realtà al modello, piuttosto che costruire un modello aderente alla realtà. La forzatura si realizza soprattutto nel comprimere o azzerare la funzione di rappresentanza politica, svalutando radicalmente il ruolo dell’istituzione parlamento e la sua centralità nel sistema democratico, puntando al miraggio di una più efficace governabilità.
Quest’ultimo passaggio si rende evidente nel turno elettorale del 2008, quando il leader del PD Veltroni decide di non seguire la strada di una nuova coalizione di centrosinistra. Il PD corre da solo, salvo accogliere nelle proprie liste alcuni reduci della pattuglia radicale, e formando una coalizione unicamente con la Lista Di Pietro. Tutti gli altri rimangono fuori. La premessa è che sia stata l’irriducibile eterogeneità delle coalizioni la causa della caduta del Governo Prodi. Berlusconi si muove in tutt’altro senso, e il centrodestra va verso il voto con Forza Italia e Alleanza Nazionale sotto l’unico simbolo del Popolo della libertà, in coalizione con la Lega al Centro-Nord, e con il Movimento per l’autonomia nelle altre regioni. Nel voto, il centrodestra ottiene una solida maggioranza in entrambe le Camere. A destra e a sinistra rimangono fuori del Parlamento le forze politiche minori, anche quelle che testimoniano antiche e grandi tradizioni. Per questo, e per la composizione, affidata alla scelta delle oligarchie di partito attraverso liste bloccate prive di riscontro democratico, nasce un Parlamento di ridottissima rappresentatività. Eppure, si sente magnificare, anche da parte di chi ha perso, la possibilità che finalmente si apra davvero una stagione costituente.
Il 13 maggio 2008 nella Camera dei deputati Berlusconi vittorioso afferma nel suo discorso programmatico: “Gli elettori hanno raccolto e premiato il nostro comune (del PDL e del PD – NdA) appello a rendere più chiaro, più efficiente e controllabile il governo del Paese. Hanno ridotto drasticamente la frammentazione politica e hanno scelto, con nettezza, una maggioranza di governo e una di opposizione, ciascuna con le proprie idee e passioni, ciascuna con una propria leadership. Il voto è stato un messaggio univoco alla classe dirigente, è stata la prima grande riforma di tante altre che sono necessarie”. E tra queste, in particolare “… il rafforzamento dei poteri dell’Esecutivo e della sua guida, contestuale ad un robusto incremento della capacità di controllo delle Assemblee elettive, anche attraverso la modifica dei Regolamenti parlamentari; la diminuzione sensibile del numero degli eletti e la definizione di compiti diversi per le due Camere; un assetto federalista dello Stato che superi le difficoltà incontrate con la riforma del Titolo V della Costituzione; una riconsiderazione attenta e condivisa della legge elettorale …”.
E Veltroni, nella seduta del 14 maggio: “Rivendico al Partito Democratico il merito di aver introdotto ragioni profonde di discontinuità, rispetto ad un Paese che soffriva di una duplice e grave malattia: l’esasperata frammentazione politica e la costante demonizzazione dell’avversario … abbiamo fatto politicamente ciò che, attraverso le riforme istituzionali e la legge elettorale, non siete riusciti a fare. Se oggi questo Parlamento vede sei gruppi, come nel resto d’Europa, e non più i quattordici dell’ultima legislatura, e non più i trentanove partiti ai quali ha fatto riferimento ieri l’onorevole Fassino, se sono finite le coalizioni assembleari messe insieme solo dalla contrapposizione nei confronti dell’avversario, ciò – lo hanno riconosciuto tutti – è perché il Partito Democratico ha avuto per primo il coraggio di compiere scelte difficili e innovative”. E anche per Veltroni le riforme rimangono un obiettivo. Ribadisce l’intento “da subito di approvare misure che diano velocità e trasparenza alla macchina decisionale dello Stato: la riduzione del numero dei parlamentari, l’idea di una Camera legislativa e una delle Regioni, una forte riduzione dei costi della politica e più ampie e necessarie garanzie di autonomia e libertà di informazione, a partire della necessaria indipendenza del servizio pubblico televisivo …”.
Quindi, nessuna contraddizione o incompatibilità tra riforme e ridotta rappresentatività. Al contrario, la ridotta rappresentatività non è assunta a elemento di debolezza, ma di forza. Essa consente e favorisce l’accordo che fino a ieri era impossibile. La sintesi si raggiunge espungendo dal confronto le opinioni diverse. Che non solo non possono esplicitare il proprio dissenso, ma perdono persino il diritto di partecipare. Una grande distanza separa questa fase della vita del Paese da quella che trovava nella piena rappresentatività del Parlamento e nella partecipazione di tutti i più saldi presidi della democrazia, pur di fronte a possibili e leciti dissensi. Nessuno mai avrebbe pensato di celebrare l’assenza di alcuni come occasione finalmente di modificare – in profondità – la Costituzione. Nessuno mai avrebbe pensato di costruire le regole comuni sul fondamento di assenze prodotte da un artificio elettorale. Invece, autorevoli esponenti politici ora esprimono l’opinione che sia un utile, ed anzi indispensabile, passo avanti. Di più. La riduzione della rappresentatività è obiettivo, oltre che presupposto, delle riforme. Si vede con chiarezza che il progetto politico di una grande riforma fatta da un Parlamento a bassa valenza rappresentativa in vista di un supposto incremento di efficienza di processi decisionali più snelli in quanto meno appesantiti da confronti e contrasti era ed è in campo, e con piena consapevolezza.
E così accade – in fine della XVI, XVII e oggi nella XVIII legislatura – che si voglia procedere a fare riforme con Parlamenti lontani dagli equilibri politici che concretamente si esprimono nel paese, o persino delegittimati per la incostituzionalità dichiarata dei meccanismi elettorali che ne determinano la composizione. La debolezza dell’istituzione è non solo palese nella genesi delle assemblee, da un lato amputate di significative soggettività politiche, e dall’altro occupate da rappresentanti non rappresentativi di alcunché, abitualmente definiti come nominati e non eletti. Ma si è poi confermato nello svolgersi della legislatura, segnata da eventi e comportamenti tali da provocare una caduta inarrestabile nella fiducia dell’opinione pubblica.
È paradossale che in un Parlamento di rappresentatività assolutamente incerta venga giocata pesantemente la carta delle riforme. Per di più nel mezzo di una crisi epocale, sulla quale con ogni evidenza nessun lifting istituzionale avrebbe potuto o potrebbe produrre alcun effetto, e che anzi almeno alcune delle proposte messe in campo avrebbero potuto concorrere ad aggravare.
Alla progressiva marginalizzazione dell’istituzione parlamento concorrono poi altre vicende che si svolgono in parallelo a quelle descritte. Nel 2001 viene approvata la riforma del Titolo V, che modifica radicalmente i rapporti tra lo Stato e le Regioni. È in particolare colpito il ruolo del legislatore nazionale, con la definizione di un elenco tassativo di potestà esclusive dello Stato, e di un vasto corpo di potestà concorrenti. Si prevede anche (art. 116, comma 3) la possibilità di forme particolari di autonomia per quanto riguarda le materie di potestà concorrente, e in alcune affidate alla potestà esclusiva statale. Partono tentativi di attuazione dell’art. 116, che approdano nel 2017, dopo referendum locali in Veneto e Lombardia, ad una richiesta di autonomia differenziata da parte di tre Regioni: Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Sulla richiesta si perviene a un re-accordo con il governo Gentiloni, nella persona del sottosegretario Bressa, il 28 febbraio 2018, a pochi giorni dal voto del 4 marzo, nonostante la materia ovviamente non potesse essere riferita al “disbrigo degli affari correnti”, secondo la formula utilizzata nella prassi. Si aprono violente polemiche, sulla “secessione dei ricchi”, e sullo spacchettamento del Paese attraverso l’indebolimento del legislatore nazionale in repubblichette incapaci di politiche di ampio respiro e di riequilibrio territoriale. Questa richiesta di “autonomia differenziata” fortemente sponsorizzata dalla Lega entra nel contratto di governo tra Lega e M5S (Conte I) nonostante il Movimento trovi nel Sud – che ne riceve un probabile danno – la sua cassaforte elettorale. E trova conferma nell’esecutivo che ad esso succede (Conte II). Una delle chiavi di lettura è l’indebolimento del parlamento come istituzione rappresentativa dell’intero Paese. Non è un caso che negli anni si è intanto affermata la Conferenza Stato-Regioni come sede di concertazione tra esecutivi: quello nazionale e quelli regionali.

Merita una specifica menzione anche il tormentato percorso delle leggi elettorali, che vedono il passaggio dal Mattarellum (maggioritario di collegio con correzione proporzionale, 1993) al Porcellum (proporzionale con premio di maggioranza a lista bloccata, 2005). L’indebolimento dell’istituzione rappresentativa qui è data dalla rottura di qualsiasi rapporto tra rappresentanti e rappresentati. La lista bloccata consegna l’intera rappresentanza parlamentare nelle mani delle oligarchie di partito. È il punto iniziale di un degrado inarrestabile dell’istituzione e della qualità del ceto politico che la occupa. La Corte costituzionale interviene dichiarando la illegittimità costituzionale nel caso che l’intera rappresentanza parlamentare sia sottratta alla scelta degli elettori (sentenze 1/2014 e 35/2017). Ma ancora la proposta del presidente della commissione affari costituzionali della Camera on. Brescia – oggi testo base per la discussione sulla legge elettorale che dovrebbe essere il “correttivo” del taglio del parlamento prevede un voto a lista bloccata.
Quindi il taglio del parlamento è solo l’ultima stazione di un lungo viaggio. I risparmi di spesa sono risibili, i vantaggi di efficienza ipotetici e indimostrabili, i danni alla rappresentanza certi ed evidenti.
In realtà, oggi solo M5S vuole davvero il taglio dei parlamentari, che ha scelto come bandiera, in coerenza con l’antiparlamentarismo di fondo che reca anche il referendum popolare oppositivo all’assemblea elettiva, il mandato imperativo, il dominio della rete e dell’instant democracy. Gli altri soggetti politici, che lo dicano o meno, sono o contrari pensando di riceverne un danno, o al più – come la Lega o Fratelli d’Italia – agnostici, perché gli equilibri di oggi comunque assicurano spazi assai maggiori che in passato. Non manca chi – in specie Giorgia Meloni – vede nel taglio e nel conseguente indebolimento del parlamento l’occasione per una opzione presidenzialista, o chi vede l’egemonia della destra – facilitata dal taglio in assenza dei correttivi sopra menzionati – come l’occasione per spacchettare il Paese nelle repubblichette del regionalismo differenziato.
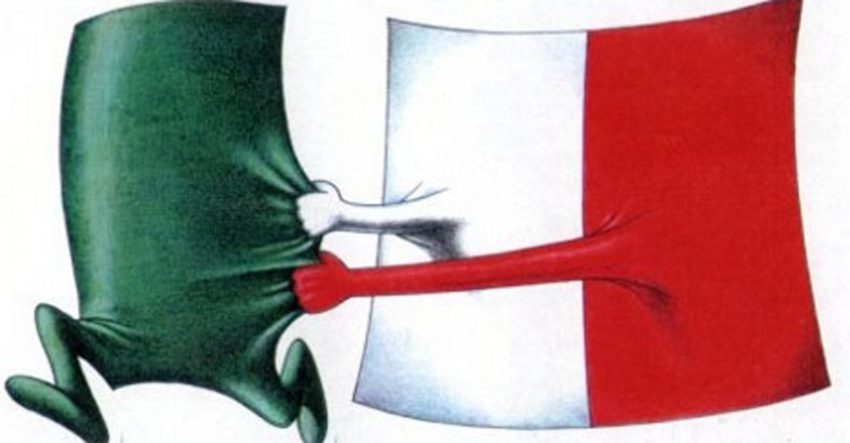
Paghiamo un prezzo alto per il baratto dannato tra la Costituzione e la formazione di un governo. I governi passano, le Costituzioni restano. La stabilità di un Paese dipende in non piccola misura dalla stabilità di una Costituzione recante regole ampiamente condivise. A partire da Titolo V del 2001, viviamo esperienze di riforma di segno esattamente opposto. Ho sostenuto, e ribadisco, che la madre di tutte le riforme sarebbe una sola: mettere in sicurezza la Costituzione modificando l’art. 138 in modo tale da togliere il potere di revisione dalle mani della maggioranza di governo pro tempore. Si eviterebbe così che la Costituzione sia ostaggio della dialettica tra maggioranza e opposizione, o ancor peggio della dialettica interna alla stessa maggioranza.
Buone leggi sui partiti politici e sul sistema elettorale sono in questa prospettiva le riforme necessarie e utili. Leggi che diano nuova forza alle forme organizzate e stabili della politica garantendo i diritti degli iscritti, la trasparenza e la correttezza dei processi politici e decisionali. Leggi che non puntino a privilegiare nell’esito elettorale questo o quel partito o coalizione, nel nome di un’astratta geometria della politica, e nell’illusione che basti per la stabilità e la governabilità garantire in Parlamento una maggioranza numerica, quale che sia, e senza riguardo agli equilibri politici in concreto esistenti nel Paese. Leggi, invece, che consentano a ciascuno di misurarsi nel consenso popolare effettivo e non chiudano la strada alle nuove offerte politiche. Leggi, infine, che perseguano l’obiettivo di consolidare il sistema politico e i soggetti che in esso operano senza forzarne l’evoluzione in un senso conforme alle convinzioni, speranze o interessi dei riformatori, ma non per questo aderente alle domande della storia o alle esigenze del Paese.
Massimo Villone, costituzionalista
Il presente lavoro riprende, con modifiche e integrazioni parti del volume di massimo Villone “Il tempo della Costituzione”, V ed. Aracne, 2014, e di numerosi articoli pubblicati sul Manifesto.
Pubblicato venerdì 18 Settembre 2020
Stampato il 15/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/longform/il-taglio-del-parlamento-e-il-riformatore-cieco/








