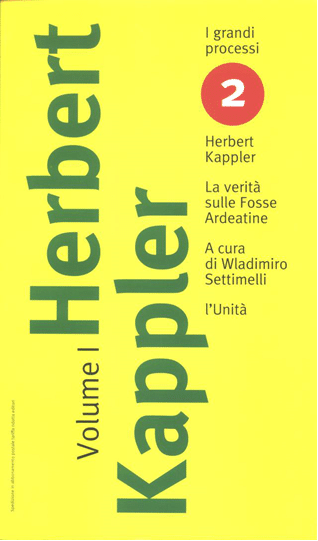 Nel 1994 il quotidiano l’Unità pubblicò per i propri lettori, nella collana “I Grandi Processi”, due volumi sul “Processo a Kappler” – il capo della polizia nazista di Roma ed esecutore della strage delle Fosse Ardeatine – a cura del suo redattore ed inviato Wladimiro Settimelli.
Nel 1994 il quotidiano l’Unità pubblicò per i propri lettori, nella collana “I Grandi Processi”, due volumi sul “Processo a Kappler” – il capo della polizia nazista di Roma ed esecutore della strage delle Fosse Ardeatine – a cura del suo redattore ed inviato Wladimiro Settimelli.
Settimelli, già direttore di “Patria Indipendente” (edizione cartacea) in questo scritto ricorda i tre mesi di duro ed emozionantissimo lavoro negli archivi del Tribunale Militare di Roma.
Lo strazio, il dolore e l’angoscia mi sono arrivati spesso addosso nel mio lavoro, senza che potessi fare niente per difendermi: il terremoto in Irpinia, le stragi, gli anni di piombo, la morte di Moro, Togliatti e Berlinguer e tanti, tanti altri casi. Ma i due volumi messi insieme per l’Unità sul processo a Herbert Kappler per la strage delle Ardeatine, mi hanno segnato davvero per sempre.
Si ha un bel ripetere che erano tutte cose note e che sullo scempio nazista a Roma, nel 1944, erano già stati scritti tanti libri, articoli di giornale, rapporti, verbali, racconti, dichiarazioni, polemiche. Tutto vero.
A Roma c’è poi il grande mausoleo che ricorda la strage di quei 335 innocenti che viene visitato ogni anno da migliaia di persone, eretto perchè nessuno dimentichi. È cupo, soffocante e così opprimente da togliere il respiro. Tutte quelle tombe… quei cognomi, le piccole foto, i fiori sempre freschi. Ma è terribile quando quei nomi impressi sulle lastre di pietra, diventano persone, e tornano ad essere uomini in carne ossa, colti nella sofferenza, nella casualità, nella quotidianità. Sono di nuovo persone che emergono, appunto, dai verbali, dai racconti, dagli oggetti trovati addosso ai poveri corpi, dai foglietti con i quali i nazisti comunicavano la notizia della morte alle mogli, ai figli, ai genitori o dagli interrogatori dei magistrati.
Ho vissuto male quei tre mesi di lavoro presso il Tribunale Militare di Roma.
 Tutto era cominciato quando il giornale aveva deciso di pubblicare una collana di libri dedicata ai “Grandi processi”. Io avevo proposto subito quello contro il tenente colonnello delle “SS” Herbert Kappler, condannato all’ergastolo per il massacro alle Cave Ardeatine dove erano stati uccisi 335 italiani come rappresaglia per l’attacco militare dei gappisti romani in via Rasella che aveva portato alla morte di trentatré soldati tedeschi, dipendenti dal servizio di sicurezza nazista della Capitale.
Tutto era cominciato quando il giornale aveva deciso di pubblicare una collana di libri dedicata ai “Grandi processi”. Io avevo proposto subito quello contro il tenente colonnello delle “SS” Herbert Kappler, condannato all’ergastolo per il massacro alle Cave Ardeatine dove erano stati uccisi 335 italiani come rappresaglia per l’attacco militare dei gappisti romani in via Rasella che aveva portato alla morte di trentatré soldati tedeschi, dipendenti dal servizio di sicurezza nazista della Capitale.
Ho due nipoti e anche quella volta avevo pensato a loro che non sapevano quasi nulla di via Rasella e delle Ardeatine. E come loro tanti altri ragazzi delle ultime generazioni. Ecco perché volevo tornare a parlare di quella strage.
La mia proposta era stata subito accolta ed io mi ero rivolto al Tribunale Militare di Roma per chiedere l’autorizzazione a consultare gli atti del processo Kappler. Il tribunale aveva dovuto emettere una vera e propria sentenza con la quale, a fini soltanto storici, mi si autorizzava alla consultazione di tutti i fascicoli. Una settimana dopo, con in mano un gran blocco di carta bianca per gli appunti, mi ero presentato dal colonnello Capone, il responsabile degli archivi. Lui, mi aveva affidato ad un cortesissimo maresciallo della Finanza che mi aveva sistemato in una stanzetta. Dopo un po’, erano arrivati i primi fascicoli con i verbali quotidiani del dibattimento firmati dal sottotenente Mario Siracusa. Domande e risposte, orari, dichiarazioni, interventi di ogni genere nel corso delle udienze: tutto era registrato e scritto a mano con una calligrafia chiara e leggibilissima. Ma nei fascicoli c’erano anche reperti di ogni genere. Una cosa che non mi sarei mai aspettato. Reperti che facevano accapponare la pelle: un pettinino trovato addosso ad un massacrato, dei biglietti del tram recuperati in tasca ai poveri resti di un uomo grande e grosso. Poi, ancora, decine e decine di telegrammi, lettere, fotografie, pezzetti di stoffa, suppliche scritte su pezzi di carta semidistrutti, biglietti vergati da qualche morituro e gettati fuori dai camion che portavano i martiri verso le cave, con parole quasi illeggibili: “Mi hanno preso ma spero di tornare. Ciao a tutti”. O “Credo che Dio mi aiuterà. Un bacione”. In altri biglietti s’intuivano frasi smozzicate: “Aiutatemi, viva l’Ital…”. O ancora: “Sono innocente. Non ho fatto nu…”.
 I telegrammi erano ancora più angosciosi e terribili. Portavano la firma di persone di ogni angolo d’Italia che chiedevano ai giudici, mentre erano ancora in corso i lavori d’identificazione dei poveri corpi negli anfratti delle Ardeatine, se per caso non c’erano notizie di un loro caro che era sparito dopo un rastrellamento. Altri allegavano un pezzetto di stoffa ad una lettera specificando che di quella stoffa era fatto il vestito di un loro caro portato via.
I telegrammi erano ancora più angosciosi e terribili. Portavano la firma di persone di ogni angolo d’Italia che chiedevano ai giudici, mentre erano ancora in corso i lavori d’identificazione dei poveri corpi negli anfratti delle Ardeatine, se per caso non c’erano notizie di un loro caro che era sparito dopo un rastrellamento. Altri allegavano un pezzetto di stoffa ad una lettera specificando che di quella stoffa era fatto il vestito di un loro caro portato via.
Spostando quei reperti, leggendo quei telegrammi e quelle lettere, maneggiando quel pettinino e quei pezzetti di stoffa, mi tremavano le mani. Erano piccole briciole di tante vite spezzate dalla guerra e dall’infamia, ed erano testimonianze autentiche di morti e di eroi, di gente qualunque e di poveracci. Erano lo specchio terribile di un’Italia disperata, umiliata e offesa da una guerra infame, da una occupazione straniera e da un regime che si reggeva sulla delazione e lo spionaggio, sull’odio e l’ingiustizia. Ma erano anche la testimonianza di chi era morto per combattere per un’Italia che avrebbe dovuto essere migliore e di chi aveva scelto di non sopportare più e di ribellarsi. Toccare quei reperti, leggere, sfogliare lettere e suppliche, mi metteva in un cupo stato di agitazione.
Tornando al giornale raccontavo al primo compagno che incrociavo che cosa avevo letto e visto e quanto mi sentissi a disagio nello scorrere quei materiali. Era come tuffarsi nel cuore di qualcuno per tentare di afferrare il senso di tutto per poi tornare tranquillamente a casa e alla vita di ogni giorno, senza più ansie, paure, senso del pericolo e terrore per le torture e la morte.
Poi, con il passare dei giorni, quell’esplorazione faticosa e difficile dei fascicoli del processo Kappler, mi fece conoscere da vicino le storie di personaggi bellissimi, la loro sofferenza, il loro resistere ai tormenti delle “SS”, il loro caparbio non parlare e il loro resistere a tutto e a ogni cosa, con orgoglio, con passione, con tante diverse e a volte semplici convinzioni. Continuando a leggere, carte e verbali, a quei personaggi mi affezionavo, ne seguivo la vita in cella, nei momenti dei terribili interrogatori, nel parlare con gli amici e i compagni, nello sperare nella salvezza, nei gesti piccoli e grandi che dicevano tutto di una vita, di un carattere, di una scelta.

A volte era proprio come se vedessi quei “degni di morte”, come diceva di loro Kappler. E mi colpivano situazioni improvvise che emergevano dalle deposizioni in aula e dagli atti processuali. Come quando don Pietro Pappagallo, in cella, era stato ignudato dalle guardie naziste che salutavano a pugno chiuso il “prete comunista”. Gli altri compagni di prigionia, per rispettare la povera intimità del sacerdote, si erano girati verso la parete fino a quando don Pappagallo era riuscito a rivestirsi. In quella situazione c’era posto e spazio anche per questo. E la storia del conte Giuseppe Celani, attivo antifascista catturato dopo una spiata. Lo avevano torturato atrocemente e poi, ogni giorno, in un cortiletto della prigione di via Tasso, lo costringevano all’inutile trasporto massacrante di grandi massi.

E mi colpiva, ogni volta, anche la straordinaria figura di Nicola Stame, un affermato tenore dell’Opera di Roma, aderente a “Bandiera Rossa”. In cella a Regina Coeli, quando i compagni lo chiedevano, cantava le più celebri romanze d’opera per tenere su il morale. Raccontano in tanti che la sua bella voce si spandeva per le celle e dava un po’ di serenità. Poi i nazisti lo picchiarono crudelmente e Stame non poté più cantare. Finì alle Ardeatine come tutti gli altri.
Anche la storia del brigadiere dei carabinieri Angelo Ioppi, mi è sempre rimasta in mente. Conosceva i nomi e i nascondigli di almeno cinquecento carabinieri che erano entrati nella Resistenza, ma non parlò mai. Lo torturarono in modo infame a colpi di martello sulle ginocchia e sul viso. Lo tenevano sempre ammanettato con le braccia dietro la schiena e lui, per mangiare, doveva sdraiarsi per terra e tuffare il viso in una ciotola di brodaglia. Proprio come un cane. E il brigadiere mangiava e beveva il sangue che gli usciva dalle ferite. Non parlò mai. Non fecero in tempo a portarlo alle Ardeatine, e si salvò.
Nelle cave finì invece il tenente Maurizio Giglio, un ufficiale coraggiosissimo che dovette essere portato a braccia fin dentro gli antri oscuri della morte: non si reggeva in piedi per le torture subite. Il suo nome, come quello degli altri, fu regolarmente spuntato dalla lista dei “degni di morte” dal boia Erich Priebke che sbagliò persino nei conteggi e provocò la morte di cinque martiri in più del previsto.
Non sono mai riuscito a dimenticare anche le storie di tanti altri assassinati alle Ardeatine: Giorgio Labò, il colonnello Montezemolo, Alfredo Mosca, Gioacchino Gesmundo, Marcello Bucchi. È un elenco senza fine.
Per oltre tre mesi cercare tra le carte del Tribunale Militare, mi ha, come ripeto ancora una volta, davvero segnato.
La soddisfazione? Che i due volumi sul processo Kappler sono stati molte volte ristampati e sempre sono andati esauriti. Sono stati richiesti soprattutto dalle scuole e dalle biblioteche pubbliche.
Pubblicato mercoledì 6 Aprile 2016
Stampato il 14/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/ardeatine-i-reperti-del-massacro/







