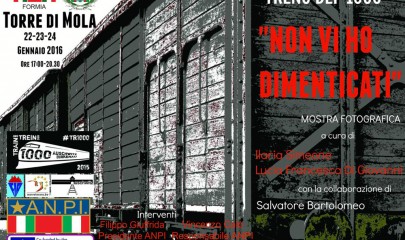Salvatore Pugliese affronta, nel contributo che pubblichiamo, una delle pagine più tragiche della storia della partecipazione italiana alla prima Guerra mondiale, aprendo un ampio squarcio sull’efferata crudeltà con cui la disciplina militare venne applicata alle truppe combattenti, sia dai tribunali militari, sia nelle modalità sommarie prescritte dal Comandante supremo Luigi Cadorna, di esecuzione sul campo, ad opera degli ufficiali in comando, di quanti in vario modo, tentarono di sottrarsi alla carneficina, oltre che attraverso la terribile prassi delle decimazioni; una vicenda, quella della cosiddetta giustizia militare, rimasta a lungo taciuta e riportata alla luce alla fine degli anni 60, grazie all’impegno di storici come Enzo Forcella e Alberto Monticone (Plotone di esecuzione fu pubblicato da Laterza nel 1968), proseguito da ulteriori approfondimenti, come quello più recente, di Irene Guerrini e Marco Pluviano (Le fucilazioni sommarie nella Prima guerra mondiale, pubblicato dall’editore Gaspari nel 2004). Il contributo di Salvatore Pugliese aggiunge ulteriori dati e ulteriori elementi di riflessione su una questione che investe direttamente il tema della narrazione pubblica della Grande Guerra, rivisitata nella prospettiva di chi – e fu la stragrande maggioranza del popolo italiano – subì una guerra non voluta e pagò il prezzo più alto di sangue e di sacrificio. Ci sembra appena il caso di richiamare ancora una volta, a questo proposito, il significativo messaggio inviato il 4 maggio 2015 dal Capo dello Stato, in occasione di un Convegno organizzato dal Museo storico italiano della guerra di Rovereto; in esso, tra l’altro, il Presidente Mattarella aveva sottolineato la necessità di non “lasciare in ombra alcune pagine tristi e poco conosciute di quegli anni di guerra” riferendosi in particolare all’esercizio della cosiddetta “giustizia sommaria” da parte dei tribunali militari. “Una prassi – si leggeva nel messaggio – che includeva la fucilazione immediata, senza processo, e persino il ricorso – sconcertante, ma incoraggiato dal comando supremo – alle decimazioni: soldati messi a morte, estratti a sorte, tra i reparti accusati di non aver resistito di fronte all’impetuosa avanzata nemica, di non aver eseguito ordini talvolta impossibili, di aver protestato per le difficili condizioni del fronte o per la sospensione delle licenze”.
Salvatore Pugliese affronta, nel contributo che pubblichiamo, una delle pagine più tragiche della storia della partecipazione italiana alla prima Guerra mondiale, aprendo un ampio squarcio sull’efferata crudeltà con cui la disciplina militare venne applicata alle truppe combattenti, sia dai tribunali militari, sia nelle modalità sommarie prescritte dal Comandante supremo Luigi Cadorna, di esecuzione sul campo, ad opera degli ufficiali in comando, di quanti in vario modo, tentarono di sottrarsi alla carneficina, oltre che attraverso la terribile prassi delle decimazioni; una vicenda, quella della cosiddetta giustizia militare, rimasta a lungo taciuta e riportata alla luce alla fine degli anni 60, grazie all’impegno di storici come Enzo Forcella e Alberto Monticone (Plotone di esecuzione fu pubblicato da Laterza nel 1968), proseguito da ulteriori approfondimenti, come quello più recente, di Irene Guerrini e Marco Pluviano (Le fucilazioni sommarie nella Prima guerra mondiale, pubblicato dall’editore Gaspari nel 2004). Il contributo di Salvatore Pugliese aggiunge ulteriori dati e ulteriori elementi di riflessione su una questione che investe direttamente il tema della narrazione pubblica della Grande Guerra, rivisitata nella prospettiva di chi – e fu la stragrande maggioranza del popolo italiano – subì una guerra non voluta e pagò il prezzo più alto di sangue e di sacrificio. Ci sembra appena il caso di richiamare ancora una volta, a questo proposito, il significativo messaggio inviato il 4 maggio 2015 dal Capo dello Stato, in occasione di un Convegno organizzato dal Museo storico italiano della guerra di Rovereto; in esso, tra l’altro, il Presidente Mattarella aveva sottolineato la necessità di non “lasciare in ombra alcune pagine tristi e poco conosciute di quegli anni di guerra” riferendosi in particolare all’esercizio della cosiddetta “giustizia sommaria” da parte dei tribunali militari. “Una prassi – si leggeva nel messaggio – che includeva la fucilazione immediata, senza processo, e persino il ricorso – sconcertante, ma incoraggiato dal comando supremo – alle decimazioni: soldati messi a morte, estratti a sorte, tra i reparti accusati di non aver resistito di fronte all’impetuosa avanzata nemica, di non aver eseguito ordini talvolta impossibili, di aver protestato per le difficili condizioni del fronte o per la sospensione delle licenze”.
L’invito a ricordare, così autorevolmente espresso, è stato raccolto, nella presente Legislatura, da una proposta di legge sottoscritta da numerosi deputati, primo firmatario l’on. Gian Piero Scanu (proposta di legge n. 2741, Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale), finalizzata ad attivare il procedimento giudiziario per la riabilitazione dei soldati italiani condannati alla pena capitale nel triennio 1915-18, nonché per restituire l’onore militare e riconoscere la dignità di vittime di guerra a quanti furono passati per le armi senza processo con la brutale pratica della decimazione o per esecuzione immediata e diretta da parte dei superiori. Approvata dalla Camera dei deputati in tempi che non si possono certo definire celeri, la proposta, come si è avuto occasione di ricordare in precedenti articoli, è stata poi ampiamente rimaneggiata nel corso dell’esame presso la Commissione difesa del Senato che, prestando orecchie a pressioni provenienti anche dai vertici militari, ne ha capovolto il significato, sostituendo al procedimento giudiziale di riabilitazione un generico e inefficace “riconoscimento del sacrificio” dei militari giustiziati, e soprattutto concedendo un equivoco “perdono” a persone che, per esplicito riconoscimento del legislatore, vennero fucilate “senza che fosse accertata a loro carico, a seguito di regolare processo, un’effettiva responsabilità penale”. Su questo punto, peraltro, il testo licenziato dalla Camera prevedeva l’esatto opposto, ovvero un atto di riparazione da parte della Repubblica nei confronti dell’accertata ingiustizia compiuta ai danni di persone innocenti.
Consultando i siti web dei due rami del Parlamento, si può constatare che alla data del 21 dicembre 2016, l’esame parlamentare della proposta di legge in questione risultava ancora fermo presso la Commissione difesa del Senato (alla quale è stato assegnato il 5 febbraio 2015). Anche la più ottimistica previsione sulla durata delle Legislatura, non fa ben sperare su una sollecita conclusione dell’iter di un’iniziativa legislativa, che, se accolta nel testo licenziato dall’Assemblea di Montecitorio, avrebbe costituito un importante atto di civiltà, collocandosi inoltre, in occasione delle scadenze del centenario, in un più ampio contesto europeo e mondiale di ripensamento del dramma costituito dal primo atto di una trentennale guerra civile europea. Rinnovare la memoria di quegli eventi nell’imminenza del centenario della rotta di Caporetto appare un dovere civile irrinunciabile, rispetto al quale il perdurante silenzio del Parlamento non farebbe che aggiungere un piccolo ma significativo tassello al mosaico di eventi che inducono molti osservatori a ritenere che il distacco tra politica e paese possa presto raggiungere un punto di non ritorno. (Valerio Strinati)

Uno degli aspetti poco indagati dalla storiografia ufficiale italiana, ma non per questo meno drammatici, fu la repressione interna, l’applicazione cioè di norme per il mantenimento della disciplina tra i soldati durante la Grande Guerra.
Decimazione, processi sommari, lunghe condanne alla reclusione, ritorsioni sulle famiglie con perdita di aiuti economici, ecc. Un numero rilevante di provvedimenti di estremo rigore che raggiunge il suo acme nel 1917 con la rotta di Caporetto, di cui ci occuperemo in un prossimo articolo.
Solo sul finire degli anni Sessanta, in Italia, come pure in Francia, gli archivi militari furono aperti (1) e gli storici ebbero finalmente accesso ai documenti conservati nelle “buste” stipate da decenni nei sotterranei del Ministero della Difesa. Venivano alla luce fatti raccapriccianti, storie di ribellioni individuali e collettive, “un immenso cimitero di drammi umani” (Forcella).
Nel Centenario della Prima guerra mondiale, intendiamo togliere la sordina a questi fatti sia per rispetto della memoria delle vittime, di cui chiediamo la loro riabilitazione, sia per amore della verità storica. La vicenda di questi soldati non ci lascia indifferenti, essa “lungi dall’essere una specie di antistoria dell’Italia combattente nel 1915/18, è parte integrante della storia di quella guerra e dell’esercito che l’ha combattuta e sofferta” (Monticone).
Questa dei reati militari e della loro repressione, è l’altra faccia della realtà, la realtà di una massa di contadini stanca di sacrifici e sofferenze, la realtà di soldati che non si vergognano di aver paura e che non capiscono il senso di una guerra lunga e sanguinosissima. La loro è un’opposizione di tipo pre-ideologico e apolitico, una reazione spontanea, immediata “è una sorda lotta per l’esistenza fra chi vuole costringere l’uomo a morire e l’uomo che si mutila per non morire” (2) (A. Frescura).

Il primo dato che colpisce è l’ampiezza del fenomeno: su circa 5 milioni e 200.000 italiani mobilitati, ci furono 870.000 denunce all’autorità giudiziaria di cui 470.000 per renitenza alla chiamata (la maggior parte residenti all’estero). Escludendo questi ultimi, ben 400.000 sono quindi le denunce per reati commessi sotto le armi. Al 2 settembre 1919, data in cui con un decreto fu concessa la cosiddetta “amnistia ai disertori” (chiamata così perché il reato più diffuso fu la diserzione), la giustizia militare aveva definito 350.000 processi pronunciando 140.000 sentenze di assoluzione e 210.000 condanne (Monticone).
Una folta schiera di processati e condannati che testimonia, da un lato, la severità e l’eccessivo rigore dei comandi militari, dall’altro, il dissenso di molta parte della truppa verso l’atteggiamento autoritario dei superiori. È il sintomo di una frattura interna grave fra l’autorità di comando e parte delle truppe.
Sentiamo l’opinione di Ungaretti, il poeta-fante: “Nell’esercito non c’era coesione: tra i diversi gradi della gerarchia e soprattutto tra truppa e ufficiali, c’era un abisso; io ero soldato semplice, io ero truppa, e tutti i miei compagni, i miei migliori amici erano ufficiali; posso quindi parlare con assoluta imparzialità. […] Non si accusi il popolo, il popolo che ha sempre avuto troppa pazienza” (3) (Ungaretti).
Ma è dalla lettura delle sentenze, con il loro arido linguaggio burocratico e giuridico, che si coglie in tutta la sua gravità la natura aspra e disumana della giustizia militare: condanne a morte o lunghi anni di reclusione per essere rientrati dalla licenza con una settimana di ritardo o per aver lanciato pubblicamente delle ingiurie del tipo “Abbasso la guerra!” o per essersi procurati delle ferite corporali.

Questo delle automutilazioni è un fatto drammatico poiché in generale i protagonisti sono contadini analfabeti che ricorrono ai metodi più rozzi per menomarsi ed essere rispediti a casa: iniezioni sottopelle di benzina o di urina, timpani forati con chiodi, colpi d’arma da fuoco sparati a bruciapelo alle mani o ai piedi, mani mozzate con grossi sassi …
Nella sentenza denominata “La vita per un dito” (4) si racconta di D.B.A., 23 anni, nato in Germania (figlio quindi di emigranti che non si è sottratto alla chiamata alle armi), del 7° alpini, condannato dal Tribunale militare di guerra del IX Corpo d’Armata alla pena di morte col mezzo della fucilazione nel petto per automutilazione. Si era procurato lesioni alla mano in due diverse occasioni.
Ancora più impressionante il caso dei 19 contadini e zolfatari siciliani del 2° deposito compagnie speciali d’istruzione che sono divenuti ciechi per essersi spalmati negli occhi secrezioni blenorragiche (si tratta della gonorrea, una malattia venerea).
Non sempre ci fu clemenza nei giudici militari, anche per le forti pressioni del Comando Supremo; bisognava agire con durezza e inflessibilità altrimenti si veniva spediti al fronte.
Bastano un paio di dati a confermarlo: 170.343 condannati su un totale di 289.343 processati, 4.000 condanne a morte di cui 750 eseguite (dati di G. Mortara, 1927, riportati in B. Bianchi, e Forcella- Monticone).
Codice alla mano, risalente al lontano 1859 (!), i tribunali hanno applicato le norme in maniera estensiva addirittura adottandone alcune illegittime, come l’esclusione dell’ubriachezza dalle attenuanti: “L’ubriachezza del colpevole non importerà mai diminuzione di pena pei reati di rivolta, ammutinamento ed insubordinazione” (art. 135 codice penale militare).
Ma non fu solo l’attività dei tribunali militari con le sue leggi draconiane a far strage dei nostri soldati, bensì tutto il comportamento dei comandi che attuarono processi sommari, quelli senza alcuna garanzia giuridica per l’imputato, ed esecuzioni dirette nel corso delle battaglie sparando sui “codardi”, fatti questi di cui non c’è quasi mai traccia nei registri militari. Di tracce ce ne sono tuttavia nella letteratura e nella memorialistica:
[Altopiano di Asiago, è in atto un massiccio bombardamento austriaco e gli italiani cominciano ad attaccare]
“[…] l’aspirante Perini si rizzò, in mezzo ai suoi soldati, e prese la fuga. Drizzatosi di scatto, quasi una granata lo avesse scavato dalle viscere della terra, voltò le spalle al suo plotone e si precipitò indietro. Giovanissimo e malaticcio, egli non aveva mai preso parte a nessun combattimento. Il maggiore lo vide prima di me, quando ci passò vicino, e me lo indicò. Senza elmetto, la faccia stravolta, l’aspirante urlava: – Hurrà! Hurrà! – È probabile che, nella furia del panico, gli austriaci fossero penetrati talmente dentro di lui, che egli gridasse per loro. – Tiri una fucilata a quel vigliacco! – mi gridò il maggiore. Io sentivo il maggiore, ma guardavo l’aspirante, senza muovermi. Neppure il maggiore si muoveva. Egli continuava a gridarmi: – Tiri una fucilata a quel vigliacco!” (5) (Lussu).

Le Circolari di Cadorna incitano gli ufficiali ad adoperare ogni mezzo per costringere i soldati a battersi:
“Ognuno deve sapere che chi tenti ignominiosamente di arrendersi e di retrocedere, sarà raggiunto, prima che s’infami, dalla giustizia sommaria del piombo delle linee retrostanti e da quella dei carabinieri incaricati di vigilare alle spalle delle truppe, sempre quando non sia stato freddato da quello dell’ufficiale”. Circolare emanata il 28 settembre 1915.
Nell’esercito italiano dominava il “terrore più terrificante”, come ebbero a scrivere nella loro relazione i componenti della Commissione Parlamentare d’Inchiesta (6), istituita nel 1919 sui fatti di Caporetto.
L’atto più grave e terribile di rigore disciplinare è sicuramente rappresentato dai processi sommari, di cui la decimazione costituisce l’aspetto più tremendo. Retaggio di epoca romana, la decimazione, di cui solo l’Italia tra tutti i Paesi belligeranti ha fatto uso, serviva a reprimere atti di ammutinamento: i militari venivano estratti a sorte fra gli indiziati e fatti passare per le armi. Si veniva fucilati senza alcuna prova di colpevolezza diretta.
Morire da innocente, il massimo grado dell’ingiustizia. “L’applicazione di criteri repressivi ha compiuto un salto di qualità, non ha più considerato la colpa individuale, è passata a giustiziare indiscriminatamente non potendo discernere le responsabilità dei singoli: è lo stesso principio della decimazione” (7) (Monticone).
La circolare di Cadorna del 1° novembre 1916 legittima tale aberrazione: “non vi è altro mezzo idoneo per reprimere i reati collettivi che quello di fucilare immediatamente i maggiori colpevoli, e allorché accertamento identità personali dei responsabili non è possibile, rimane ai comandanti il diritto e il dovere di estrarre a sorte tra gli indiziati alcuni militari e punirli con la pena di morte”. La circolare fu resa nota al grande pubblico nel 1919 dal quotidiano socialista Avanti! in una rubrica intitolata “La marcia della verità” e suscitò una generale indignazione.

Un caso di decimazione fu quello avvenuto sull’Altopiano di Asiago durante la Strafexpedition. La sera del 26 maggio 1916, sulle pendici di Monte Mosciagh, i nemici attaccano. Fra i reparti attendati non in primissima linea, c’è il 141° fanteria. Di fronte all’avanzata austriaca, la compagnia si sbanda in preda alla sorpresa e alla paura, i soldati si sparpagliano per i boschi vicini, il tenente stesso segue i suoi soldati. Il 28 maggio, due giorni dopo, “il comando del reggimento (in conformità anche alle superiori disposizioni) per dare un esempio che servisse da ammonimento alla massa […] condannava a morte un sottotenente, tre sergenti ed altri otto militari di truppa” (8).
In nessun altro Paese occidentale la giustizia militare ha raggiunto un così alto livello di repressione. Il nostro esercito detiene per esempio il triste primato delle condanne a morte: in Italia ci furono oltre 4.000 sentenze delle quali 750 eseguite; in Francia, nonostante la maggior durata del conflitto, furono eseguite 600 condanne a morte concentrate nei primi anni di guerra, esse poi diminuirono per le proteste del potere civile e per l’intuito di Pétain (lo stesso che qualche decennio dopo cedette colpevolmente la Francia ai nazisti), che attua una serie di contromisure per evitare il malcontento della truppa (sette giorni di permessi ogni quattro mesi, più cibo, più comunicazione, ecc.) (9).
In Gran Bretagna, nonostante il maggior numero di mobilitati – 9 milioni – furono giustiziati 346 uomini su 3.080 condannati a morte, anche qui declinarono negli ultimi due anni di guerra per le pressioni dell’opinione pubblica e del parlamento inglese sui Comandi militari. In Germania su 150 condanne a morte ne furono eseguite 46 (10).
A proposito delle proteste da parte del potere politico, occorre sottolineare che né il governo di Salandra né quello successivo di Orlando, né il Parlamento, né la stampa, si preoccuparono di contenere la deriva autoritaria del Comando Supremo. Si sono anzi alleati. La tradizionale separazione tra esercito e Paese, la reciproca diffidenza è venuta meno proprio nel ’15-’18: “gli anni di guerra parevano aver procurato il superamento di questa separazione” (11) (Rochat). Un connubio disgraziato quindi, perché in quel contesto serviva invece un controllo da parte del potere civile sull’operato dei militari, come avveniva in tutte le altre democrazie europee.
In conclusione, la giustizia militare è stato un potente mezzo per reprimere gli atti di indisciplina della truppa in una maniera, come si è visto, severa e crudele. Non si è tenuto conto che sotto la divisa c’erano uomini, persone con una dignità da difendere, non automi intercambiabili buoni solo ad ammazzare ed ad obbedire. Nella schiera del nostro regio esercito, circa il 10 per cento dei mobilitati si è ribellato a questo stato di cose. Sarà stata una rivolta consapevole la loro, sarà stato l’istinto alla sopravvivenza, questi uomini meritano il nostro rispetto perché hanno avuto il coraggio di gridare il loro rifiuto della guerra.
Salvatore Pugliese, ricercatore universitario a Paris X-Nanterre
NOTE e BIBLIOGRAFIA
- “Per circa 50 anni l’aspetto punitivo e repressivo della prima guerra mondiale è stato pressoché ignorato dagli storici italiani […] Certo c’è stato il ventennio fascista col loro mito della guerra ma anche dopo negli anni della democrazia il problema è stato sottaciuto. Si è voluto nascondere. Due generazioni di italiani sono state tenute all’oscuro” Forcella–A. Monticone, Plotone di esecuzione, I processi della Prima Guerra Mondiale, Laterza, Bari, 1968 (I ed.) , p. XIII
- Attilio Frescura, Diario di un imboscato, Milano, Mursia, 1981 (I ed., Vicenza, 1919)
- Ungaretti, Il caso Graziani e la sozza speculazione neutralista, Il Popolo d’Italia, 8 agosto 1919
- Forcella- Monticone, op.cit., sentenza n.1, p.3
- Emilio Lussu, Un anno sull’Altipiano, Einaudi, Torino, 1945 (I ed.), ed. del 1995, p. 41
- La Commissione parlamentare d’Inchiesta sulla rotta di Caporetto, ottobre-novembre 1917, era stata nominata da Orlando. I lavori durarono oltre un anno, ci furono 241 sedute, ascoltati 1.012 testimoni, si consultarono 2.310 documenti. Era composta da tre membri militari e tre parlamentari interventisti. G. Rochat, L’esercito italiano da Vittorio Veneto a Mussolini (1919-1925), Editori Laterza-Bari 1967, p.71
- Forcella- Monticone, op. cit., p.451
- Forcella- Monticone, op. cit. Sentenza n. 16, pp. 81-83.
- “Le grande mérite de Pétain est d’avoir compris qu’il recevait comme don une armée qui n’avait pas envie de se battre avec les méthodes jusqu’alors employées et qui entendait être traitée tout autrement» (Il grande merito di Pétain è di aver compreso ch’egli riceveva in dono un esercito che non aveva voglia di battersi con i metodi fino ad allora impiegati e che voleva essere trattato molto diversamente). Guy Pedroncini, Les mutinerie de 1917, Presses Universitaires de France, 1^ediz. 1967, Paris, p. 233
- Bianchi “ Exécutions sommaires et condamnations à mort au sein de l’armée italienne durant la Grande Guerre», pp.237-245, in «La Grande Guerre – Pratiques et expériences» a cura di R. Cazals, E. Picard, D.Rolland, ed. Privat, 2005 Toulouse
- Rochat, op. cit., p.15
Pubblicato martedì 21 Marzo 2017
Stampato il 04/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/la-grande-guerra-morire-mano-amica/