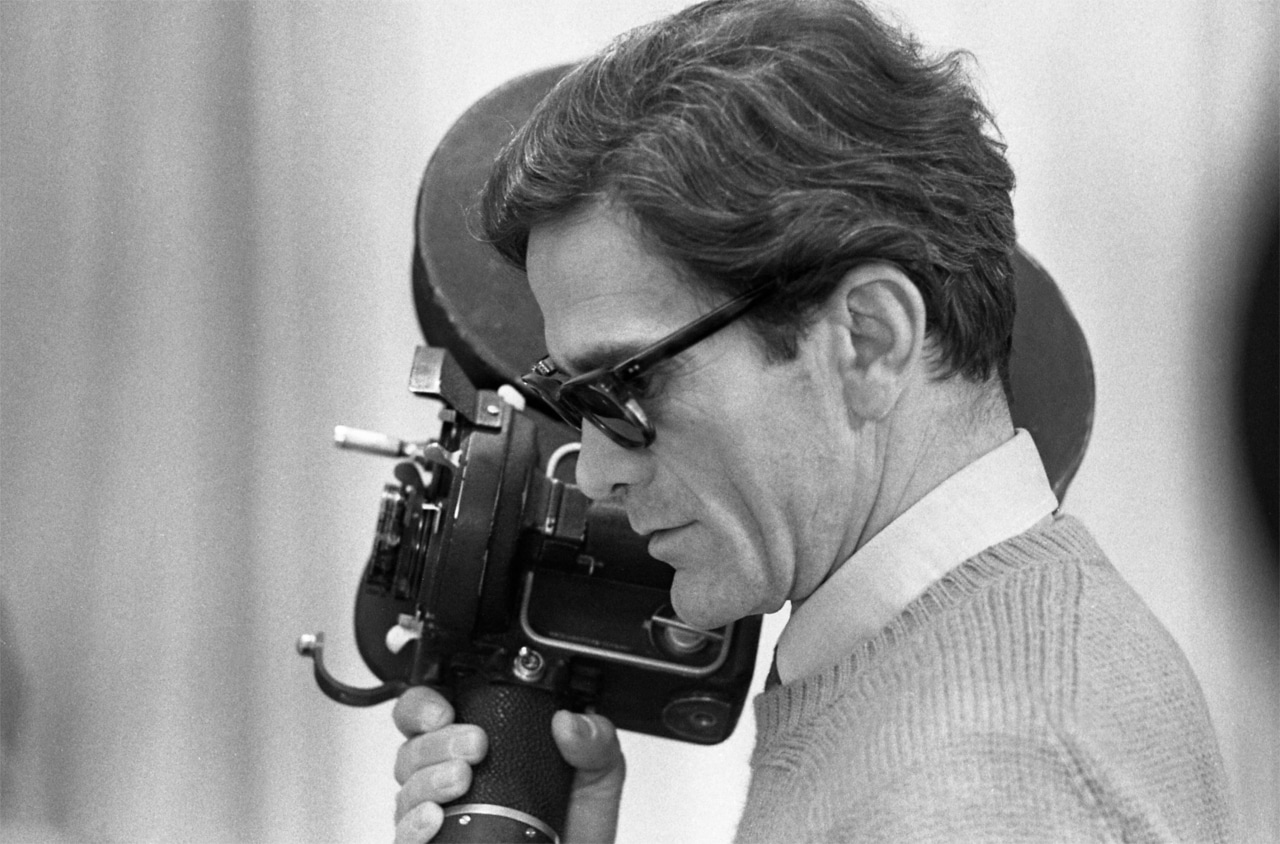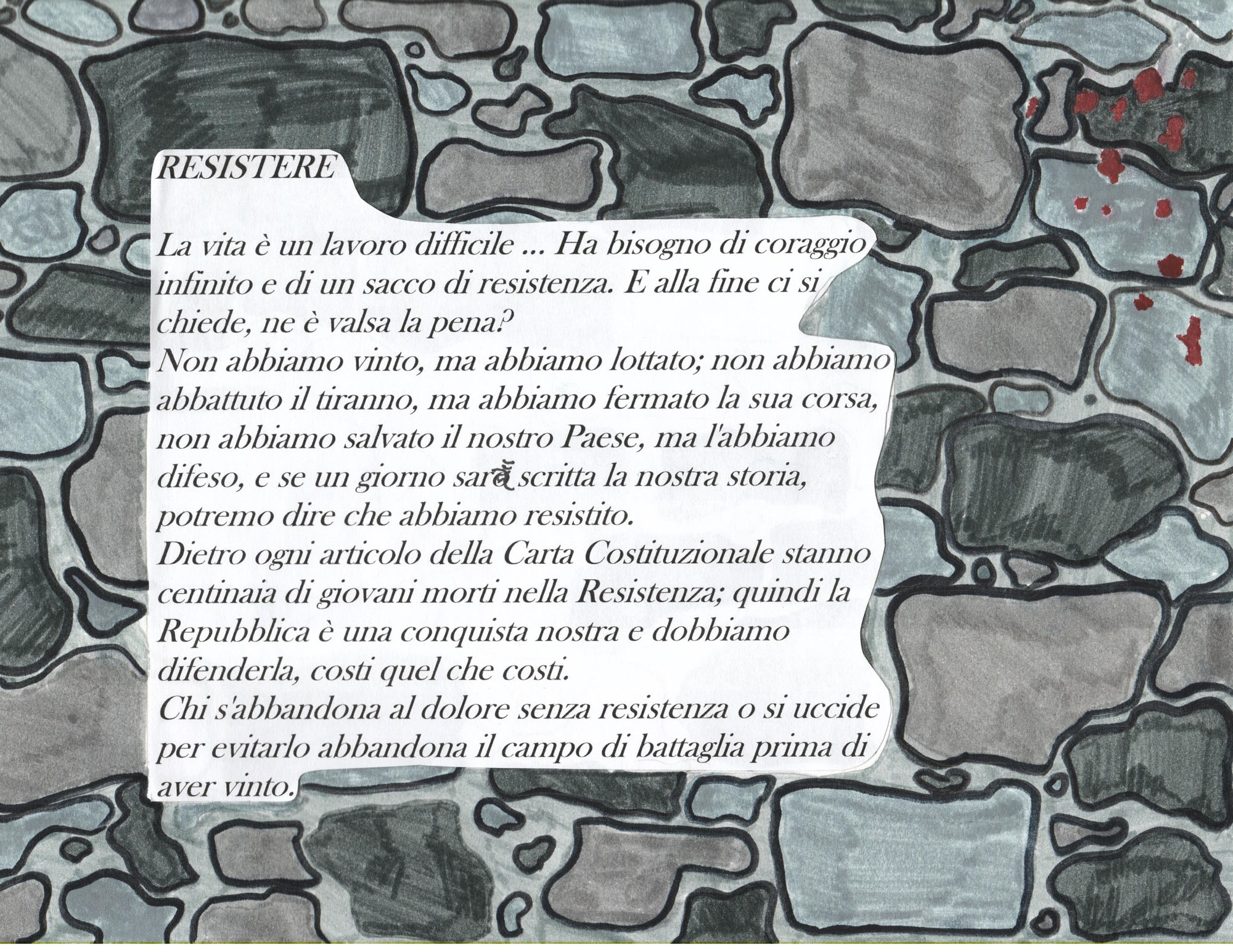Raccontare il rapporto tra mafia e prodotti audiovisivi è impresa articolata e non facile, che impone di evidenziare come, nel corso degli ultimi vent’anni, le modalità di consumo dei prodotti audiovisivi siano enormemente cambiate. Si è assistito al progressivo declino di videoteche e modalità di noleggio “fisico” delle copie dei film, per arrivare allo streaming e all’acquisto temporaneo di una copia digitale. Non solo: è cambiata in modo sostanziale anche la struttura dei palinsesti e si sono ridotti i tempi che intercorrevano tra l’uscita di un film nelle sale e la sua messa in onda televisiva. Inoltre, i servizi di abbonamento come Netflix hanno rappresentato una nuova norma a cui guardare nella produzione di film e serie tv. Si assiste all’ascesa del fenomeno del bingewatching: letteralmente, l’abbuffata dello spettatore, che può decidere di guardare anche tutte le puntate di seguito, il giorno della loro uscita simultanea. I tempi rapidi di realizzazione, poi, fanno sì che tra puntate e stagioni non si assista a significativi cambiamenti socio-politici: in altre parole, il panorama culturale in cui viene concepita una serie tv resta più omogeneo e coerente allo spettatore. E questo aspetto rappresenta una differenza incolmabile con l’epoca dei blockbuster, in cui i sequel arrivavano a distanza di anni, durante i quali potevano esserci stati eventi di fortissimo impatto e mutazioni graduali. Oggi, la serialità ha sovrastato persino le produzioni per il cinema che, ormai, guardano ai prodotti a puntate per confezionare film appetibili. Ed è quindi a questa “nuova” tv che bisogna guardare per provare a fare la disamina del racconto della criminalità organizzata nei mass-media.
Raccontare il rapporto tra mafia e prodotti audiovisivi è impresa articolata e non facile, che impone di evidenziare come, nel corso degli ultimi vent’anni, le modalità di consumo dei prodotti audiovisivi siano enormemente cambiate. Si è assistito al progressivo declino di videoteche e modalità di noleggio “fisico” delle copie dei film, per arrivare allo streaming e all’acquisto temporaneo di una copia digitale. Non solo: è cambiata in modo sostanziale anche la struttura dei palinsesti e si sono ridotti i tempi che intercorrevano tra l’uscita di un film nelle sale e la sua messa in onda televisiva. Inoltre, i servizi di abbonamento come Netflix hanno rappresentato una nuova norma a cui guardare nella produzione di film e serie tv. Si assiste all’ascesa del fenomeno del bingewatching: letteralmente, l’abbuffata dello spettatore, che può decidere di guardare anche tutte le puntate di seguito, il giorno della loro uscita simultanea. I tempi rapidi di realizzazione, poi, fanno sì che tra puntate e stagioni non si assista a significativi cambiamenti socio-politici: in altre parole, il panorama culturale in cui viene concepita una serie tv resta più omogeneo e coerente allo spettatore. E questo aspetto rappresenta una differenza incolmabile con l’epoca dei blockbuster, in cui i sequel arrivavano a distanza di anni, durante i quali potevano esserci stati eventi di fortissimo impatto e mutazioni graduali. Oggi, la serialità ha sovrastato persino le produzioni per il cinema che, ormai, guardano ai prodotti a puntate per confezionare film appetibili. Ed è quindi a questa “nuova” tv che bisogna guardare per provare a fare la disamina del racconto della criminalità organizzata nei mass-media.
 La serialità televisiva italiana gode di grande dignità, grazie a prodotti come Gomorra, Suburra e Romanzo criminale – punte di diamante attorno a cui, negli ultimi vent’anni, si è addensata la narrazione delle associazioni a delinquere. Una rappresentazione scenica in cui confluiscono, da una parte, i grandi film che, a partire dagli anni Settanta, hanno iniziato a portare la criminalità sul grande schermo (La saga de Il Padrino, Scarface e Blow, solo per citare i più celebri) e, dall’altra, un racconto fedele, fatto di atti processuali e dati attendibili. Scrittori come Roberto Saviano, o magistrati Giancarlo De Cataldo o Gianrico Carofiglio, dai cui lavori spesso sono state tratte sceneggiature destinate alle produzioni audiovisive, godono di grande autorevolezza nell’ambiente giornalistico e nel comparto dell’antimafia. Quindi, questi prodotti, molto spesso di elevato pregio artistico, si sono insinuati nella vita quotidiana in modo capillare con lo scopo di veicolare una feroce condanna degli atteggiamenti mafiosi. L’ottima qualità dei prodotti citati ha fatto sì che divenissero più credibili: il lavoro di sceneggiatura ha contribuito a umanizzare i cattivi, presentati al pubblico anche con tormenti interiori e sottotrame articolate. La conseguenza, purtroppo, è stata l’esaltazione del male e l’immedesimazione dello spettatore. Evitare di raccontare un’opposizione manichea tra bene e male che si sarebbe rivelata poco credibile a livello drammaturgico e, quindi, rendere tridimensionali anche gli esempi negativi, ha avuto le sue ricadute. Stando al riscontro del Paese reale, i più giovani risentono maggiormente di un effetto “rimbalzo” di questi contenuti che, veicolati attraverso clip e spezzoni sui social e su YouTube, risultano decontestualizzati, privi di profondità. Quindi, la scena di un omicidio viene fruita esattamente per ciò che appare: un’esecuzione, e poco importa se fa parte di una sequenza più ampia in cui il messaggio è la condanna di determinati comportamenti o stili di vita. Al contrario, quindi, si normalizzano e accettano con disinvoltura gli atteggiamenti mafiosi e la loro trasposizione nel codice quotidiano.
La serialità televisiva italiana gode di grande dignità, grazie a prodotti come Gomorra, Suburra e Romanzo criminale – punte di diamante attorno a cui, negli ultimi vent’anni, si è addensata la narrazione delle associazioni a delinquere. Una rappresentazione scenica in cui confluiscono, da una parte, i grandi film che, a partire dagli anni Settanta, hanno iniziato a portare la criminalità sul grande schermo (La saga de Il Padrino, Scarface e Blow, solo per citare i più celebri) e, dall’altra, un racconto fedele, fatto di atti processuali e dati attendibili. Scrittori come Roberto Saviano, o magistrati Giancarlo De Cataldo o Gianrico Carofiglio, dai cui lavori spesso sono state tratte sceneggiature destinate alle produzioni audiovisive, godono di grande autorevolezza nell’ambiente giornalistico e nel comparto dell’antimafia. Quindi, questi prodotti, molto spesso di elevato pregio artistico, si sono insinuati nella vita quotidiana in modo capillare con lo scopo di veicolare una feroce condanna degli atteggiamenti mafiosi. L’ottima qualità dei prodotti citati ha fatto sì che divenissero più credibili: il lavoro di sceneggiatura ha contribuito a umanizzare i cattivi, presentati al pubblico anche con tormenti interiori e sottotrame articolate. La conseguenza, purtroppo, è stata l’esaltazione del male e l’immedesimazione dello spettatore. Evitare di raccontare un’opposizione manichea tra bene e male che si sarebbe rivelata poco credibile a livello drammaturgico e, quindi, rendere tridimensionali anche gli esempi negativi, ha avuto le sue ricadute. Stando al riscontro del Paese reale, i più giovani risentono maggiormente di un effetto “rimbalzo” di questi contenuti che, veicolati attraverso clip e spezzoni sui social e su YouTube, risultano decontestualizzati, privi di profondità. Quindi, la scena di un omicidio viene fruita esattamente per ciò che appare: un’esecuzione, e poco importa se fa parte di una sequenza più ampia in cui il messaggio è la condanna di determinati comportamenti o stili di vita. Al contrario, quindi, si normalizzano e accettano con disinvoltura gli atteggiamenti mafiosi e la loro trasposizione nel codice quotidiano.
 Che rapporto hanno gli italiani con lo storytelling criminale, quindi? Un esempio, in tal senso, potrebbe essere emblematico: accanto ai prodotti già citati, si profilano produzioni televisive tout court, come quelle di cui Mediaset ha fatto ampio sfoggio. Qualche anno fa, durante la messa in onda della fiction di mafia “Rosy Abate”, venne mostrato un numero di telefono al quale gli spettatori iniziarono a chiamare. In quel caso, il numero era reale e apparteneva a una coppia di Domodossola, che venne sommersa di telefonate minacciose o in cui veniva chiesta una “protezione”: in altre parole, il filtro della finzione era palesemente caduto e gli spettatori avevano ricalcato l’invenzione scenica sulla realtà. Si tratta di un episodio apparentemente marginale, ma che fa rabbrividire per il suo portato sociologico. Ciò che sembra inconcepibile, è accaduto: il pubblico si è svelato nella sua incapacità di discernimento tra vero e falso. E, perciò, non stupirebbe un analogo errore di valutazione trasposto sull’asse bene-male. L’emulazione di atteggiamenti delinquenziali e, prima ancora, l’accettazione di valori criminali come “giusti” conduce proprio sull’orlo di un burrone sociale e mediatico. Quello della fiction Mediaset è, forse, un caso limite, ma confermato dalla ricerca condotta dall’associazione Da Sud sulla percezione degli atteggiamenti mafiosi tra gli adolescenti romani. A partire dalle definizioni, si palesano delle storture: a fronte di 1 su 5 che ha dichiarato di aver sentito parlare dell’inchiesta “Mondo di Mezzo”, tutti hanno detto di conoscere “Mafia Capitale”. Solo il 10% ha indicato Spada e Casamonica come i clan più presenti sul territorio, mentre la metà degli intervistati ha definito più determinanti le mafie straniere. In modo analogo, gli adolescenti hanno iniziato a non individuare come illegali atteggiamenti criminali o a ridimensionarne il peso, come nel caso di lavoro nero, estorsione, prostituzione, riciclaggio e corruzione.
Che rapporto hanno gli italiani con lo storytelling criminale, quindi? Un esempio, in tal senso, potrebbe essere emblematico: accanto ai prodotti già citati, si profilano produzioni televisive tout court, come quelle di cui Mediaset ha fatto ampio sfoggio. Qualche anno fa, durante la messa in onda della fiction di mafia “Rosy Abate”, venne mostrato un numero di telefono al quale gli spettatori iniziarono a chiamare. In quel caso, il numero era reale e apparteneva a una coppia di Domodossola, che venne sommersa di telefonate minacciose o in cui veniva chiesta una “protezione”: in altre parole, il filtro della finzione era palesemente caduto e gli spettatori avevano ricalcato l’invenzione scenica sulla realtà. Si tratta di un episodio apparentemente marginale, ma che fa rabbrividire per il suo portato sociologico. Ciò che sembra inconcepibile, è accaduto: il pubblico si è svelato nella sua incapacità di discernimento tra vero e falso. E, perciò, non stupirebbe un analogo errore di valutazione trasposto sull’asse bene-male. L’emulazione di atteggiamenti delinquenziali e, prima ancora, l’accettazione di valori criminali come “giusti” conduce proprio sull’orlo di un burrone sociale e mediatico. Quello della fiction Mediaset è, forse, un caso limite, ma confermato dalla ricerca condotta dall’associazione Da Sud sulla percezione degli atteggiamenti mafiosi tra gli adolescenti romani. A partire dalle definizioni, si palesano delle storture: a fronte di 1 su 5 che ha dichiarato di aver sentito parlare dell’inchiesta “Mondo di Mezzo”, tutti hanno detto di conoscere “Mafia Capitale”. Solo il 10% ha indicato Spada e Casamonica come i clan più presenti sul territorio, mentre la metà degli intervistati ha definito più determinanti le mafie straniere. In modo analogo, gli adolescenti hanno iniziato a non individuare come illegali atteggiamenti criminali o a ridimensionarne il peso, come nel caso di lavoro nero, estorsione, prostituzione, riciclaggio e corruzione.

A questo scenario già basculante in cui la condanna degli atteggiamenti mafiosi viene fraintesa e interpretata come esaltazione, si aggiungono quei programmi che, pur non facendo esplicito riferimento alle organizzazioni mafiose, ne utilizzano i codici linguistici ed estetici in chiave goliardica. Si tratta (solo per fare due esempi) de Il boss delle torte e Il boss delle cerimonie: il primo, dal 2009 al 2017, ha raccontato le gesta della “Pasticceria da Carlo” e della famiglia italo-americana Valastro, in ogni puntata alle prese con torte faraoniche e cliché culturali. Il secondo, invece, è una produzione italiana che va in onda dal 2014 e che ha cambiato il nome in Il castello delle cerimonie, alla morte del patron Don Antonio Polese. Sì, perché il predicato d’onore non manca mai ai protagonisti di questo docu-reality ambientato in una sfarzosissima sala ricevimenti in provincia di Napoli in cui si svolgono (principalmente) matrimoni in cui il buon gusto non è il primo degli invitati. Un circo interminabile di troni, arredi finto-barocchi, ostentazione, cantanti neomelodici e scugnizzi-valletti che offrono il pesce fresco agli sposi sono dettagli dannosi oltre che pacchiani, molti dei quali assorbiti passivamente dagli spettatori che, inevitabilmente, iniziano a simpatizzare per il clima sovraccarico di oggetti e personaggi kitsch.
 Tra i ritratti presenti nel castello, spunta anche quello di Mario Merola, nei confronti del quale il “don” protagonista della serie (chiamato, in alternativa, “boss”) dimostra commossa devozione. L’aura mistica che i futuri sposi riconoscono al “don” comprende onore, rispetto e una reverenza spesso grottesca. Tutto coronato dal classico brindisi augurale del “boss” durante il pranzo di nozze (poi ereditato dalla figlia Donna Imma): formula standard e pronuncia italiana malferma sono le colonne portanti di quella che sembra proprio una “benedizione” malavitosa. Può sembrare una sopravvalutazione, ma un programma come questo merita la stessa attenzione di serie tv ben più note e seguite. È trasmesso su un canale “di nicchia”, ma la sua pervasività è notevole: la quantità di personaggi e chicche trash prodotta non è misurabile, così come l’espansione a macchia d’olio di queste “pillole”, che rimbalzano dalla tv ai social. È come se una versione più festosa e simpatica del funerale Casamonica fosse mandata in onda a cadenza settimanale, con in più un pregevole lavoro di montaggio e un commento divertente a supporto. I rimandi al mondo della criminalità organizzata in questo programma non sono astratte suggestioni: nel 2016, infatti, i terreni su cui sorge il castello sono stati confiscati per abuso edilizio e due parenti molto prossimi del “boss”, condannati a un anno di reclusione.
Tra i ritratti presenti nel castello, spunta anche quello di Mario Merola, nei confronti del quale il “don” protagonista della serie (chiamato, in alternativa, “boss”) dimostra commossa devozione. L’aura mistica che i futuri sposi riconoscono al “don” comprende onore, rispetto e una reverenza spesso grottesca. Tutto coronato dal classico brindisi augurale del “boss” durante il pranzo di nozze (poi ereditato dalla figlia Donna Imma): formula standard e pronuncia italiana malferma sono le colonne portanti di quella che sembra proprio una “benedizione” malavitosa. Può sembrare una sopravvalutazione, ma un programma come questo merita la stessa attenzione di serie tv ben più note e seguite. È trasmesso su un canale “di nicchia”, ma la sua pervasività è notevole: la quantità di personaggi e chicche trash prodotta non è misurabile, così come l’espansione a macchia d’olio di queste “pillole”, che rimbalzano dalla tv ai social. È come se una versione più festosa e simpatica del funerale Casamonica fosse mandata in onda a cadenza settimanale, con in più un pregevole lavoro di montaggio e un commento divertente a supporto. I rimandi al mondo della criminalità organizzata in questo programma non sono astratte suggestioni: nel 2016, infatti, i terreni su cui sorge il castello sono stati confiscati per abuso edilizio e due parenti molto prossimi del “boss”, condannati a un anno di reclusione.
È legittimo chiedersi quali siano gli effetti di questi processi messi in atto su larga scala a livello mediatico anche se, purtroppo, i risultati non sembrerebbero incoraggianti. Dati, forse, strettamente imparentati con gli episodi sempre più frequenti di babygang, bullismo, cyberbullismo e adesione alla criminalità organizzata. A tal proposito, è emblematico pensare a un film come Arancia meccanica, che racconta e denuncia l’ultraviolenza, portandone in scena le conseguenze, più che mostrandola direttamente. L’effetto di un calcio, ad esempio, prende il sopravvento sulla scena in cui lo stivale del protagonista colpisce il malcapitato di turno lasciando, però, allo spettatore il compito di legare l’atto brutale alle ripercussioni sugli individui. Eppure, dal 1971, anno della sua uscita, sono innumerevoli gli atti di criminalità ispirati ad Alex e i suoi drughi: l’ultimo in ordine di tempo si è registrato a Roma, dove sono stati denunciati dei ragazzi che, vestiti come i protagonisti del film, sputano su maniglie e citofoni nel tentativo di infettare il Covid-19 agli abitanti. Episodi grotteschi, che richiamano alla memoria un dibattito già lungamente affrontato a partire dagli anni Ottanta sulla pericolosità dei videogames sulle fasce più giovani. Come ampiamente dimostrato, i videogiochi non desensibilizzano alla violenza motu proprio, ma si innestano su terreni a vario livello fertili per instillare un’idea di brutalità più “a portata di mano”.

Quindi, allora come oggi, l’interrogativo è: chi fruisce di questi prodotti ha l’alfabetizzazione necessaria all’argomento? Le istituzioni sociali di base, in altre parole, si sono premurate di fornire ai più giovani la capacità di decodifica di questi linguaggi, garantendo loro un antidoto alla stolida fascinazione della violenza? Purtroppo, molto spesso, la risposta è no: per distrazione o incapacità, chi dovrebbe tutelare, si limita a demonizzare. Perché spiegare e capire, in una dialettica proficua, sarebbe incredibilmente più utile che mettere al bando. Ma, nei fatti, ciò che si verifica è un atteggiamento molto poco sano che riduce tutto all’immagine del saggio che indica la luna e, inesorabilmente, lo stolto guarda il dito.
Tuttavia, per una curiosa coincidenza, le parole riassuntive che meglio incarnano lo spirito di questo argomento risultano le citazioni di due siciliani. Di due ambiti tra loro estremamente lontani e con pesi specifici ben diversi, senza ombra di dubbio, ma capaci entrambi di restituire al meglio il fenomeno in questione. Da una parte, l’eminente voce di Paolo Borsellino, la cui statura morale è anche superfluo ricordare, che sentenziò: «Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo». Dall’altra, il cantautore catanese Colapesce che, in un suo brano dal titolo sufficientemente emblematico – Maledetti italiani – racconta, con grande ironia, i cambiamenti occorsi al nostro Paese, tra cui il processo secondo cui La mafia è diventata pop e, in sua vece, è la musica a mietere vittime. Dunque, a conti fatti, probabilmente il problema non è il prodotto di consumo di massa, ma come la massa è abituata a consumare. Se mafia, camorra e affini infarciscono il palinsesto, sarà compito del consumatore capire come fruire di questi prodotti. Ma se il consumo di massa, invece, avviene in modo incontrollato e bulimico, senza nemmeno lasciare da parte le bucce e le lische, ma ingurgitando tutto, allora sì che una spina potrebbe incastrarsi in gola, come probabilmente sta già accadendo a migliaia di spettatori.
Letizia Annamaria Dabramo
Pubblicato giovedì 30 Luglio 2020
Stampato il 03/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/il-fascino-indiscreto-del-crimine/