 “Ma forse proprio per il fatto di non avere ricordi mi sentii, per la prima volta in vita mia, così poco al sicuro”. A dirlo è un ragazzo, il protagonista del racconto che chiude il volume della lituana Daina Opolskaitė, Le piramidi di giorni (Iperborea, traduzione di Adriano Cerri, pp. 237, € 17): un libro fatto di sogni, silenzio e paesaggi immersi nella neve. I personaggi di Opolskaitė stanno in bilico tra realtà – edificata con fittissimi strati di tempo – e dimensione onirica, cosicché le due cose appaiono inestricabilmente legate, come le due facce di una stessa medaglia. Dunque i sogni, segreti cunicoli che bucano il tempo umano, diventano gli unici strumenti – o gli strumenti per eccellenza – in grado di rivelare la realtà profonda delle nostre esistenze.
“Ma forse proprio per il fatto di non avere ricordi mi sentii, per la prima volta in vita mia, così poco al sicuro”. A dirlo è un ragazzo, il protagonista del racconto che chiude il volume della lituana Daina Opolskaitė, Le piramidi di giorni (Iperborea, traduzione di Adriano Cerri, pp. 237, € 17): un libro fatto di sogni, silenzio e paesaggi immersi nella neve. I personaggi di Opolskaitė stanno in bilico tra realtà – edificata con fittissimi strati di tempo – e dimensione onirica, cosicché le due cose appaiono inestricabilmente legate, come le due facce di una stessa medaglia. Dunque i sogni, segreti cunicoli che bucano il tempo umano, diventano gli unici strumenti – o gli strumenti per eccellenza – in grado di rivelare la realtà profonda delle nostre esistenze.
Succede in L’escursione, dove il ragazzo al centro della storia conosce se stesso – filosoficamente – grazie al passaggio sotterraneo che i sogni gli scavano dentro proiettandolo, senza soluzione di continuità, da una tappa all’altra della vita; e succede in Mai, dove lo sguardo sull’esistere prende la forma di qualcosa che è parente del sonno, quasi intravisto dallo specchietto retrovisore di un’auto in corsa; o ancora in L’ora del crepuscolo, dove è detta la vicenda di una donna che sta morendo, o meglio della voce di lei che seguita a fluttuare per la casa anche quando il suo corpo non ci sarà più.
E poi, accanto ai sogni, c’è la rimembranza (sì, così, alla Leopardi): magico sospiro in cui l’occhio della mente fa spazio a qualcosa là dove prima sembrava esserci un semplice, inconsutile nulla; e a volte la rimembranza è gioiosa illusione, altre è malinconia (“tutto si è allontanato come un treno che passa”) o dolore puro. Altre ancora è così ovattata e remota da aver l’impressione che essa provenga da un’altra vita: Io e Madlena – in questo senso esemplare –, dando voce a una bimba ancora nella pancia (“nella polpa dell’albicocca”) e nel passaggio al mondo di fuori, rende conto dello sfumato e intensissimo rapporto madre-figlia, in equilibrio tra ineffabile osmosi (spinta all’annullamento estatico dell’una nell’altra) e sottilissima ma irriducibile alterità (“una campana di vetro di cui al massimo posso toccare la superficie con le dita”).
Infine c’è l’esatta e caritatevole indagine sui moti dell’animo – qui la Opolskaitė è magistrale e le sue pagine fioriscono in immagini che possiamo quasi afferrare e spremere tra le mani – sia quando essi, pungenti e fastidiosi, “infestano l’uomo come piccoli parassiti, si insediano dentro di lui, si cibano dei suoi pensieri”, sia quando ci invadono per restituirci a noi semplicemente sgomenti, increduli, incapaci di comprendere come diavolo si riesca, talora, a obbedire a sentimenti ripugnanti ai quali neppure siamo in grado di dare un nome: è il caso de L’esame di maturità, doloroso ricordo di un cedimento umano, troppo umano; o, per concludere, del racconto di apertura, Inferriate, dove una donna, i cui i figli sono a studiare lontano, per rimediare un po’ di denaro decide di adottare un bambino proveniente dalla remota Siberia. Questo si rivelerà un rapporto sempre difficile, lungo anni durante i quali si conosceranno a fondo senza mai riuscire a superare quella cosa che si erge tra loro separandoli irrimediabilmente. Leggiamo Opolskaitė e sentiamo sulle labbra il gusto dolce della nebbia e della bruma e, mentre oppressi da una strana paura stiamo inchiodati alla croce della vita, accogliamo anche, come un regalo di Natale, le sue epifaniche parole di conforto che brillano come trepidanti promesse escatologiche: “io penso che le persone vivano per vedere qualcosa di molto bello. E per capire qualcosa di molto importante, la cosa più importante nella loro vita. Quando a una persona capita di riuscirci, può andarsene. E tutto è giusto così”.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
 È la vigilia di Natale quando al commissariato di viale delle Medaglie d’oro, a Roma, l’ispettore di polizia prossimo alla pensione, Mario Fagioli, viene incaricato dal capo di andare a dare un’occhiata al morto rinvenuto ai piedi delle scale condominiali di via Minimi 59. Così si apre il nuovo, intrigante giallo di Giuseppina Torregrossa, Morte accidentale di un amministratore di condominio (Marsilio, pp. 191, €14). Mario Fagioli è riluttante all’idea di uscire al freddo, di interrompere il suo rituale (il taglio della pizza in quadratini regolari da far sparire in bocca uno dietro l’altro), di andare a rovinarsi la festa. Un Natale che, comunque, avrebbe trascorso da solo, sintomo di un’esistenza in pacifica rovina. Benché in gioventù si fosse dimostrato uno sbirro coi fiocchi, nervoso e irruento, ma tanto determinato da essere riuscito da solo ad arrestare il potente boss Letojanni e da aver trascorso lunghi periodi da infiltrato in una cosca mafiosa, si è infine adattato (tutta colpa dell’“incidente”) a far da “passacarte nel sottoscala” del più tranquillo commissariato della Capitale. Ma il morto c’è e ci vuole qualcuno a cui passare la patata bollente; il che significa rovinarsi le vacanze natalizie aiutando il medico legale e stendendo uno di quei rapporti anonimi che nessuno mai leggerà.
È la vigilia di Natale quando al commissariato di viale delle Medaglie d’oro, a Roma, l’ispettore di polizia prossimo alla pensione, Mario Fagioli, viene incaricato dal capo di andare a dare un’occhiata al morto rinvenuto ai piedi delle scale condominiali di via Minimi 59. Così si apre il nuovo, intrigante giallo di Giuseppina Torregrossa, Morte accidentale di un amministratore di condominio (Marsilio, pp. 191, €14). Mario Fagioli è riluttante all’idea di uscire al freddo, di interrompere il suo rituale (il taglio della pizza in quadratini regolari da far sparire in bocca uno dietro l’altro), di andare a rovinarsi la festa. Un Natale che, comunque, avrebbe trascorso da solo, sintomo di un’esistenza in pacifica rovina. Benché in gioventù si fosse dimostrato uno sbirro coi fiocchi, nervoso e irruento, ma tanto determinato da essere riuscito da solo ad arrestare il potente boss Letojanni e da aver trascorso lunghi periodi da infiltrato in una cosca mafiosa, si è infine adattato (tutta colpa dell’“incidente”) a far da “passacarte nel sottoscala” del più tranquillo commissariato della Capitale. Ma il morto c’è e ci vuole qualcuno a cui passare la patata bollente; il che significa rovinarsi le vacanze natalizie aiutando il medico legale e stendendo uno di quei rapporti anonimi che nessuno mai leggerà.
Così il cinquantacinquenne Mario Fagioli, “detto il Gladiatore per via di un passato da combattente”, le mani unte di pizza (più che un difetto, un’orgogliosa impuntatura), si fa portare dalla volante in via Minimi 59, alle porte di un pretenzioso condominio anni Settanta. Ed eccolo il cadavere, lungo e disteso vicino al primo gradino della rampa. Da lì inizia una girandola di interrogatori che coinvolgono una serie di donne dai capelli bianchi, ormai. Sì, perché la vittima, Michele Noci, è – era – un anziano amministratore di condominio, ma soprattutto un dongiovanni attorniato da uomini di potere e dalla pletora delle loro mogli (in carica o vedove) annoiate e agguerrite a un tempo. E sebbene il carattere ruvido dell’ispettore non sia il più adatto a trattare con quella gente dalla puzza sotto il naso, per Mario Fagioli l’indagine si rivelerà un vero e proprio risveglio dello spirito (e dell’amore), una riconquista della dignità perduta con l’“incidente” attorno al quale solo a poco a poco si dissipano le nebbie.
Giuseppina Torregrossa torna al genere poliziesco con un romanzo che si inserisce nel flusso della migliore tradizione giallistica a cui aggiunge un tocco di commedia romanesca (“Mario si radicò nella sua convinzione: la poraccitudine dei ricchi”), e un altro di saggezza popolare (“‘I portieri sai chi li ha inventati?’ chiese con tono accondiscendente. ‘Mussolini. Ne mise uno in ogni palazzo perché si impicciassero dei fatti di tutti’”). Alla fine chiudiamo il libro con un doppio sorriso sulle labbra: quello di chi si è goduta la risoluzione di un bel mistero, e quello di chi trova ribadita una verità sempre attuale, ovvero che ogni condominio “non è un condominio, ma un manicomio”.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
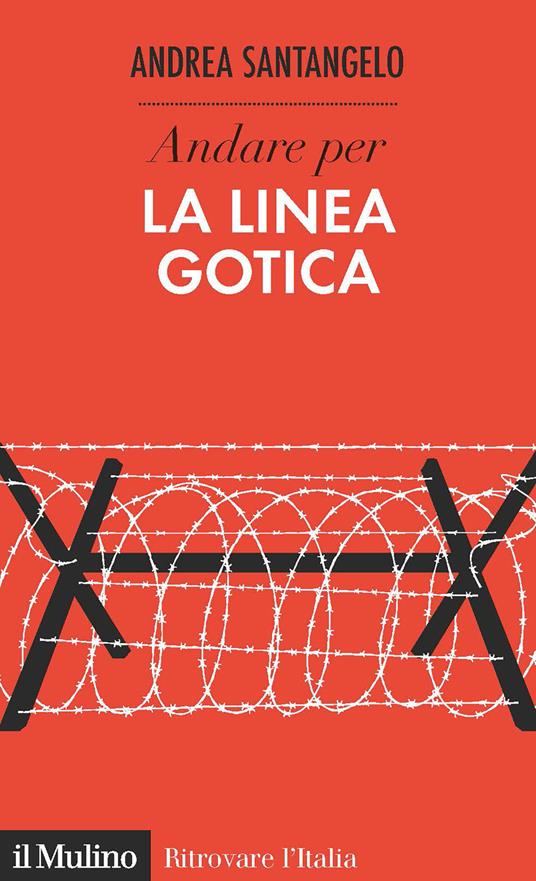 Vale la pena di leggere – per poi mettersi in viaggio – un interessante volume di Andrea Santangelo (lui è un archeologo ed esperto di storia militare), Andare per la Linea Gotica (pp. 157, € 12), pubblicato dal Mulino all’interno della collana Ritrovare l’Italia che propone itinerari d’autore tra storia e cultura (solo per citare un altro titolo, la monografia di Fabio Isman che ripercorre i luoghi “dell’Italia degli intrighi”). Questo di Santangelo è un bel saggio storico e assieme una guida, un viatico lungo quei 320 km di sistema difensivo tedesco – la Linea Gotica, appunto – dentro e attorno al quale, da Pesaro a Marina di Massa, s’accesero i riflettori di molteplici tragedie consumate tra l’estate del 1944 e la primavera del 1945. Un libro in cui non mancano qua e là le testimonianze di chi quei giorni li visse sulla propria pelle e ne serba oggi ancora (o fino a poco tempo fa) un pulsante ricordo; un libro che andrebbe letto non solo dagli addetti ai lavori, ma da chiunque intenda “sentire” la storia là dove si è sedimentata e recuperare, a livello di coscienza e di identità nazionale, un grappolo di avvenimenti troppo spesso dimenticati, a partire dai programmi scolastici (lo stesso Santangelo ricorda gli inquietanti risultati di un sondaggio della Comunità Europea svoltosi nelle scuole superiori e che rivela che l’83% degli studenti italiani ignora che l’Italia abbia subito sanguinose devastazioni durante il Secondo conflitto mondiale).
Vale la pena di leggere – per poi mettersi in viaggio – un interessante volume di Andrea Santangelo (lui è un archeologo ed esperto di storia militare), Andare per la Linea Gotica (pp. 157, € 12), pubblicato dal Mulino all’interno della collana Ritrovare l’Italia che propone itinerari d’autore tra storia e cultura (solo per citare un altro titolo, la monografia di Fabio Isman che ripercorre i luoghi “dell’Italia degli intrighi”). Questo di Santangelo è un bel saggio storico e assieme una guida, un viatico lungo quei 320 km di sistema difensivo tedesco – la Linea Gotica, appunto – dentro e attorno al quale, da Pesaro a Marina di Massa, s’accesero i riflettori di molteplici tragedie consumate tra l’estate del 1944 e la primavera del 1945. Un libro in cui non mancano qua e là le testimonianze di chi quei giorni li visse sulla propria pelle e ne serba oggi ancora (o fino a poco tempo fa) un pulsante ricordo; un libro che andrebbe letto non solo dagli addetti ai lavori, ma da chiunque intenda “sentire” la storia là dove si è sedimentata e recuperare, a livello di coscienza e di identità nazionale, un grappolo di avvenimenti troppo spesso dimenticati, a partire dai programmi scolastici (lo stesso Santangelo ricorda gli inquietanti risultati di un sondaggio della Comunità Europea svoltosi nelle scuole superiori e che rivela che l’83% degli studenti italiani ignora che l’Italia abbia subito sanguinose devastazioni durante il Secondo conflitto mondiale).
Attraverso cinque itinerari, proposti seguendo un rigoroso ordine cronologico degli eventi, andiamo alla riscoperta dei principali teatri di scontro lungo quella che è stata definita “la grande muraglia italiana”, voluta da Kesselring ed edificata da 18.000 genieri tedeschi, 2.000 soldati cecoslovacchi, 250 tecnici norvegesi e 30.000 prigionieri di guerra ridotti in schiavitù.
Si parte dalla difficile battaglia di Rimini del settembre 1944 per arrivare alla liberazione di Ravenna nel dicembre dello stesso anno; dagli attacchi americani ai passi della Futa e del Giogo nell’autunno di quell’anno fino alla liberazione di Bologna nella primavera del 1945; lungo il cammino della sofferenza, ripercorrendo la strage infinita di adulti e bambini tra Marzabotto-Monte Sole e Sant’Anna di Stazzema, per approdare all’ultimo tentativo di offensiva italo-tedesca e alla controffensiva dei leggendari nisei, ovvero i figli del Sol Levante nati fuori dal Giappone. Costoro erano quei nipponici residenti negli Stati Uniti che, all’indomani dell’aggressione di Pearl Harbor, erano stati, per volontà del presidente Franklin Delano Roosevelt, rinchiusi in un campo di concentramento. Erano 110.000 individui a cui vanno aggiunti altri 112.000 persone di origine italiana e tedesca. Questi giapponesi nati in America, col progredire della guerra, si offrirono volontari per servire nell’esercito degli Stati Uniti. Confluirono dapprima nel 100° battaglione (già formato dagli ex appartenenti alla Guardia nazionale hawaiana) e poi nel neonato 442° Regimental combat team, appositamente costituito per accogliere i volontari nippo-americani. Una bella storia, dunque, a chiusura di volume, una storia di uomini che hanno guardato al di là dell’appartenenza etnica per accogliere nei loro cuori di porpora (il Purple Heart era la decorazione assegnata ai soldati americani feriti o uccisi in battaglia) il coraggio di combattere per l’idea giusta, a fianco dei partigiani; e un bel suggerimento di viaggio, là dove natura e storia sono legate indissolubilmente, nel nostro Paese, “alla maniera proposta da Marcel Proust: non per scoprire nuove terre, ma per avere nuovi occhi nel guardare la propria terra”.
Giacomo Verri, scrittore
Pubblicato giovedì 23 Dicembre 2021
Stampato il 02/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/la-necessita-di-leggere-per-un-buon-resistente-natale/







