
La strage nazista di Cefafonia fu la tragedia di un’esplosione d’odio tra alleati diventati improvvisamente nemici in un luogo ameno nel quale nessuno avrebbe mai potuto immaginare che potesse accadere. Questo è vero perché quell’isola dal dolce paesaggio, distesa nel mare Jonio, era stata una specie di oasi di pacifica convivenza per italiani e tedeschi fino alla sera dell’8 settembre, quando l’amicizia tra le parti cominciò a convertirsi in odio. I militari italiani (la divisione “Acqui” e alcuni corpi della marina, dei carabinieri e della guardia di finanza), da camerati sarebbero diventati nemici, accusati di un presunto “tradimento” (di nient’altro, invero, che della loro decisione di non consegnarsi passivamente al nemico e di non disattendere i pur ambigui ordini del governo Badoglio diramati insieme all’annuncio dell’armistizio). Dopo sette giorni di duro ed eroico combattimento, il 22 settembre, le truppe italiane ‒ sopraffatte soprattutto dalla preminente aviazione tedesca, isolate da un fantomatico Comando supremo e prive di rifornimenti, ignorate dagli anglo-americani ‒ furono costrette alla resa. Sui sopravvissuti, ovvero sui militari ormai ridotti alla condizione di prigionieri di guerra, imperversò, implacabile, assecondando gli ordini di Hitler, una criminale
furia “punitiva” teutonica, in spregio ai codici del diritto internazionale e dell’onore militare.
La tragedia trasformò in un inferno quello che appena pochi giorni prima era stato il luogo di una felice convivenza di “camerati” tra loro differenziabili soltanto per i colori delle divise, un po’ impigriti dal fatto stesso di trovarsi in una piccola isola distante dalla guerra guerreggiata, in un mite clima di quieta quotidianità che avrebbe potuto essere quello ben rappresentato in un film di Gabriele Salvatores, Mediterraneo, premiato con l’Oscar anche se, forse, ormai caduto nell’oblio. Lì, soltanto qualche giorno prima, sarebbe stato ben difficile evidenziare – ammesso che ci fossero – sentimenti ed idee diversi da quelli che la formazione ricevuta e l’esperienza vissuta nei due rispettivi ed alleati regimi, il fascista e il nazista, avevano introiettato nelle menti dei militari di entrambe le parti.

È impossibile sapere quanti, sulle basi di quella formazione, tra gli italiani (compreso il loro comandante, il generale Antonio Gandin) potessero dirsi propriamente fascisti e quanti, tra i tedeschi, propriamente nazisti. Ma è certo che persino il riconoscersi come “fascisti” era diventato di colpo, e tragicamente, incompatibile con il riconoscersi alleati dei “nazisti”. Il conflitto era esploso nei termini di un’improvvisa ed elementare incompatibilità delle due “patrie”. E, nel caso degli italiani, l’idea di patria, data la sua fallace fondazione fascista, era entrata in contraddizione con se stessa. Si avvertiva l’impossibilità di essere dei “patrioti” continuando, nel contempo, ad ubbidire al fascismo, così come invece pretendevano i tedeschi ponendo, in concreto, il loro drastico aut-aut: “scegliete di passare dalla nostra parte , oppure affrontateci in combattimento da nemici”. Alla fine, bastò semplicemente aver salvato l’onore dell’essere “italiani” per subire il fuoco dei plotoni di esecuzione tedeschi, in una serie di sistematiche azioni criminali, con un bilancio di morti enorme, stimato in oltre 10.000 vittime (di cui 390 ufficiali e 9500 soldati).

Quei fatti sono arcinoti nelle loro cause e approfonditamente perlustrati nella loro dinamica militare dalla storiografia, per quanto sia ancora un problema soltanto parzialmente risolto quello della loro piena e “legittima” inclusione nella storia dell’antifascismo e della loro più corretta interpretazione nel quadro delle vicende della Resistenza e della guerra di Liberazione.
Alla risoluzione di questo problema offre un contributo decisivo il recente libro di Marco De Paolis ed Isabella Insolvibile (Cefalonia- Il processo, la storia, i documenti, edito da Viella, nella collana “I processi per crimini di guerra tedeschi in Italia”, diretta dal medesimo De Paolis e da Paolo Pezzino, per l’Istituto nazionale Ferruccio Parri). Il processo di cui lì si parla è quello, conclusosi con una condanna all’ergastolo in contumacia, a carico di un infame e poco pentito ex caporale di Kippnheim, l’arzillo ultranovantenne Alfred Stork, (nella vita civile del dopoguerra un oscuro portinaio) che era stato tra i fucilatori della “Casetta rossa”, la località dell’isola dove erano stati vilmente trucidati almeno 317 ufficiali.
L’Anpi-Palermo “Comandante Barbato” ‒ condividendo l’iniziativa del professore Antonio Scaglione (vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Militare) di presentare il libro nel corso di un convegno organizzato ad hoc nella sede della “Società di storia patria”, lo scorso 26 ottobre ‒ ha contribuito a fare emergere nuovi elementi di corretta interpretazione storica da un dibattito già pervenuto ad importanti risultati nel Convegno di Napoli promosso e animato dall’allora presidente dell’Anpi, ora presidente emerito, Carlo Smuraglia, nel gennaio 2015; un dibattito, sempre più criticamente consapevole dell’esigenza di rileggere anche dal Sud il processo resistenziale-antifascista per coglierne l’unitarietà di indivisibile fenomeno nazionale.
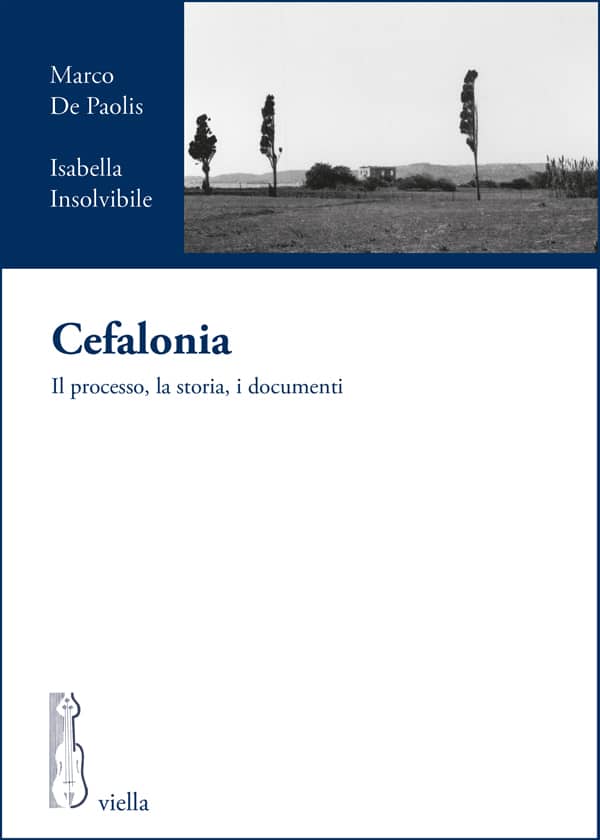 Il sottoscritto autore di questo articolo ha avuto l’onere di essere il presentatore ufficiale svolgendovi la “relazione storica”, cui ha fatto seguito quella del co-autore del libro, dottor Marco De Paolis (Procuratore militare della Repubblica a Roma), in un intenso e assai partecipato pomeriggio di riflessione inaugurato dagli interventi del prof. Gianni Puglisi (già rettore dello Iulm di Milano e presidente della Società siciliana di Storia Patria) e del citato prof. Antonio Scaglione e poi concluso dal vice presidente nazionale Anpi Ottavio Terranova.
Il sottoscritto autore di questo articolo ha avuto l’onere di essere il presentatore ufficiale svolgendovi la “relazione storica”, cui ha fatto seguito quella del co-autore del libro, dottor Marco De Paolis (Procuratore militare della Repubblica a Roma), in un intenso e assai partecipato pomeriggio di riflessione inaugurato dagli interventi del prof. Gianni Puglisi (già rettore dello Iulm di Milano e presidente della Società siciliana di Storia Patria) e del citato prof. Antonio Scaglione e poi concluso dal vice presidente nazionale Anpi Ottavio Terranova.
Questione dominante della “relazione storica”, al di là del bilancio storiografico della memoria sui fatti bene approntato nel libro da Isabella Insolvibile, è stata quella di una disamina critica dei fattori che hanno reso tardivo e non sempre scontato (almeno fino al determinante intervento risolutivo, il 1° marzo 2001, del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi) il riconoscimento del valore originario e fondante che i tragici fatti di Cefalonia assumono per la lotta guerreggiata antifascista, come per altri versi è accaduto anche per quanto riguarda la valutazione delle Quattro giornate di Napoli (27-30 settembre 1943).
Il fatto è che il processo resistenziale è stato a lungo interpretato soprattutto con una dominante considerazione dei suoi sviluppi ufficiali nella “guerra di Liberazione”, dopo la togliattiana “svolta di Salerno” del marzo 1944, sotto la guida dei partiti antifascisti: in tale interpretazione il valore “resistenziale” delle azioni di lotta è stato a lungo ancorato, fondamentalmente, alle visuali antifasciste dei partiti e alle loro proposte per la democrazia da ricostruire, subendone gli inevitabili condizionamenti ideologici. Non era facile coglierlo laddove tali azioni fossero insorte come pura opposizione all’arroganza, alla violenza e alla barbarie nazifasciste, in termini di elementare civismo e patriottismo, nonché di rivolta esistenziale. E, questo, ancor meno per Cefalonia, dove i soldati italiani, come si è già ricordato sopra, avevano deciso (a seguito di un informale “referendum” indetto tra le truppe dal generale Gandin) di affrontare i tedeschi in combattimento piuttosto che accettare l’umiliazione di “cedere le armi”, senza che nel loro comportamento, nel loro “orgoglio patriottico”, fosse individuabile una qualche evidente vocazione antifascista. Anzi ‒ giova ancora ripetere e sottolineare ‒ nel caso specifico quella scelta apparteneva ad una gioventù in armi che si era formata nel fascismo e che nell’immediato non pareva possedere, in genere, ben riconoscibili risorse culturali e idealità alternative per distanziarsene.
In quella situazione drammatica nella quale il crollo del fallimentare Stato del regno sabaudo verificatosi l’8 settembre (la sconfitta e la resa senza condizioni, il disonore del governo Badoglio, l’indecorosa fuga del re e dei comandi militari da Roma, la consegna della flotta agli ex nemici, lo sfacelo dell’amministrazione pubblica, il “tutti a casa” dell’esercito in rotta) aveva distrutto la “patria” della retorica enfatizzata dal fascismo, per le quiete ed isolate truppe dislocate a Cefalonia fu lo stesso patriottismo, sotto la spinta dell’onore militare da difendere, a diventare oggettivamente antifascismo.
Come riuscire ‒ ci si è chiesti nel prosieguo della “relazione storica” ‒ a far consistere in tale spinta patriottica, di per sé a-ideologica, il valore neo-risorgimentale antifascista del sacrificio della divisione “Acqui” quando il concetto stesso di “patria”, reso deforme dall’appropriazione indebita operatane dal fascismo, aveva subito un così evidente svilimento da renderne almeno diffidenti i partiti della rinascente democrazia antifascista? Lo si è appena detto sopra: era difficile, molto difficile sanare la frattura, superare gli effetti dell’“inimicizia”, che il fascismo aveva provocato tra una falsante, sciagurata e retorica idea di patria e l’idea di democrazia. Ci sarebbe voluto del tempo, al di là delle lacerazioni morali del corso stesso della guerra di Liberazione, per ristabilire e riconoscere una sintonia tra patriottismo e antifascismo; e, in proposito, fu merito assai precoce dell’Anpi l’avere aperto la strada giusta, con la significativa, e in un certo senso “coraggiosa”, decisione di chiamare Patria Indipendente il suo ufficiale organo di stampa.
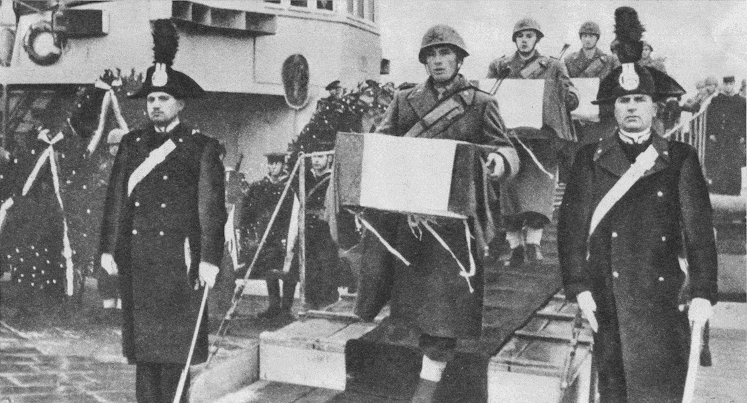
Intanto, per molti anni, il lutto dei pochi sopravvissuti a quella tragedia restò, per così dire, un lutto privato, estraniato dalla coscienza pubblica, non rielaborato dalla “memoria collettiva” in formazione nella repubblica democratica del dopoguerra. E a tale estraniamento, aggravandolo, corrispose la lunga impunità concessa ai responsabili della strage, ai criminali nazisti, per un intrecciato gioco di opportunità omertose e di fattori di realpolitik della magistratura tedesca e di quella italiana, alimentato da poco nobili intenti di reciproca autoassoluzione per le responsabilità condivise, nonché giustificato politicamente dalla comune preoccupazione anticomunista nel clima della “guerra fredda”.
Così il processo contro l’ex caporale Stork, dopo uno squallido percorso di occultamenti e di colpevoli omissioni, ovvero di “giustizia negata”, è stato l’unico istruito per i fatti di Cefalonia e conclusosi con un’esemplare sentenza di condanna, ma di un aguzzino ormai ultranovantenne. E, affinché venisse istruito, c’è voluta la casuale scoperta, nel 1995, da parte del procuratore militare Antonino Intelisano, di quell’“armadio della vergogna”‒ come lo definì il primo giornalista a parlarne, Franco Giustolisi ‒ nel quale erano stati archiviati ed occultati i fascicoli relativi ai crimini militari nazisti. E si sono resi necessari, per addivenire ad un atto di giustizia, il senso alto della giustizia e l’indefesso impegno professionale di un magistrato del livello di Marco De Paolis. Il libro di cui egli è co-autore raccoglie i preziosi materiali giudiziari prodottisi nel corso del suo tenace e meritorio lavoro e costituisce un approdo per la storiografia alla ricerca della verità. In esso, e nell’importante relazione svolta a Palermo, De Paolis ha ricostruito sia la dinamica di quel suo lavoro, sia l’intero corso di un’indecente vicenda che costituisce “l’ambito entro il quale la parola giustizia sembra proprio che manifesti meglio che in qualsiasi altro contesto la propria sostanziale inadeguatezza”. Un’inadeguatezza alla quale può porre rimedio ‒ come ha ben sottolineato Ottavio Terranova nell’intervento conclusivo del Convegno, riassumendone il senso e i risultati e richiamando particolarmente alcune esemplari testimonianze antifasciste meridionali da quelle sacrificali rese anche a Cefalonia a tutte le altre nel corso della guerra di Liberazione ‒ una memoria storica resa attiva per il presente e per il futuro, ben al di là, appunto, della stessa “giustizia” tardiva ed ormai quasi impossibile dei tribunali: la memoria che continua ancora a dettare la sua “lezione civile” contro la barbarie nazifascista e contro il pericolo di vederla riprodursi in altre, inedite forme.
Prof. Giuseppe Carlo Marino, storico, Presidente onorario dell’Anpi Palermo
Pubblicato lunedì 12 Novembre 2018
Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/ultime-news/perche-chi-ama-la-patria-e-antifascista/






