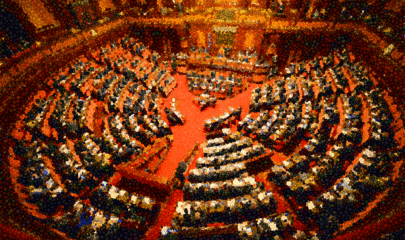«Se passa il Sì passa l’avventura di modifiche costituzionali al vento di tutte le possibili maggioranze politiche. Chi ha la maggioranza politica cambia le leggi elettorali e la Costituzione a suo uso e consumo. Con il No, invece, si apre la discussione sul modello costituzionale in cui dovrà vivere per i prossimi 50 anni e non per le prossime elezioni. Il No impedisce nell’immediato che maggioranze politiche artefatte, e quindi non rappresentative, abbiano il potere di cambiare in continuazione la Carta fondamentale». Rino Formica è una mente fine della prima Repubblica. L’ex esponente del Psi, più volte ministro nei governi Andreotti, Spadolini e De Mita, è il presidente onorario del Comitato socialista per il No al referendum costituzionale. E arrotando la erre ti spiega che votare Sì, di fatto, «apre la strada alla soppressione della prima parte della Costituzione». Perché se malauguratamente la cosiddetta riforma Renzi-Boschi dovesse passare nelle urne del 4 dicembre «avremmo un ritorno alla Costituzione flessibile dello Statuto albertino». Quella Costituzione docile a ogni arbitrio che consegnò l’Italia liberale allo squadrismo fascista.
La storia non si ripete mai allo stesso modo, certo, però guardando a ciò che si muove nel mondo, alle tendenze conservatrici trionfanti, al potere invasivo delle centrali economiche e finanziarie che considerano le costituzioni un fardello, per Formica «si pone con urgenza il problema di porre un argine alle spinte autoritarie. Parliamoci chiaro, c’è una logica perversa che tiene assieme riforma costituzionale, riforma della legge elettorale e riforma occulta del modello costituzionale di partecipazione democratica. Ecco perché è importante che il No – come io mi auguro e sono convinto – vinca. Sarà il primo passo per riguadagnare il terreno perduto dalla democrazia italiana».
Non è il primo attacco alla Carta del ’48. Tentativi per rendere flessibile la Costituzione ve ne sono stati molti anche nel passato. In cosa si differenzia quello dell’accoppiata Renzi-Boschi?

Ha ragione. Già durante la Costituente importanti settori della Dc e del fronte conservatore erano al lavoro per attenuare la garanzia data dalla sua rigidità. Basti pensare che nel dicembre del ’47 fu bocciato l’articolo 130 bis sostenuto dal Pci, dal Psi e dalla sinistra sociale della Dc. Articolo che recitava: “Le disposizioni della presente Costituzione che riconoscono o garantiscono i diritti di libertà e del lavoro, rappresentando l’inderogabile fondamento per l’esercizio della sovranità popolare, non possono essere oggetto di procedimenti di revisione costituzionale, tendenti a misconoscere o a limitare tali diritti, ovvero a diminuirne le guarentigie”. La proposta fu respinta con 191 voti contro 116, segno di un clima politico, interno e internazionale, mutato profondamente in senso moderato. Stessa sorte toccò al 2° comma dell’articolo 50 che, nella versione elaborata dalla Commissione dei 75 su impulso di Dossetti, prevedeva il diritto alla resistenza quando i pubblici poteri avessero violato le libertà fondamentali dei cittadini. Cassato. Nel ’53 poi, come ha recentemente ricordato Emanuele Macaluso, alle richieste di Scoccimarro, per conto del Pci, di temperare almeno il premio di maggioranza previsto dalla cosiddetta “legge truffa”, Andreotti rispose: “No, non è possibile. De Gasperi ha bisogno di quel premio per avere la maggioranza dei dei due terzi in parlamento per cambiare la Costituzione”. Ma – venendo all’oggi – col premier fiorentino c’è un salto di qualità pericolosissimo, che non è emerso chiaramente nel dibattito di queste settimane. Renzi vuole introdurre il principio che le modifiche costituzionali e le leggi elettorali ad essa collegate siano appannaggio di chi possiede la maggioranza politica in quel momento. In sostanza del governo. Punto. Sino al governo Letta le revisioni costituzionali di ampio respiro – soppressione di organi, modifiche di organi, modifica dell’ordinamento – non potevano essere azionate attraverso la semplice procedura dell’articolo 138. Tant’è vero che Letta, Quagliariello e Franceschini – rispettivamente presidente del Consiglio, ministro per le Riforme e ministro per i Rapporti col Parlamento – presentano nel 2013 un disegno di legge costituzionale per la costituzione di un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali composto di venti senatori e venti deputati per procedere alla riforma della Costituzione e alla modifica della legge elettorale. Quando Renzi si impossessa del partito attraverso le primarie, si garantisce l’accordo del Nazareno e infine assume il governo del Paese, abbandona il disegno di legge costituzionale che pure era giunto all’ultima lettura al Senato. Bastava un attimo per avere le tanto decantate riforme e invece il premier blocca tutto. Quello che intende cancellare, com’è ormai chiaro a tutti, non è il Senato elettivo o il Cnel; quello che gli preme davvero è minare l’impianto politico-ideologico che è al fondo della Costituzione del ’48. Renzi risponde al vento del tempo. È l’interprete nostrano della tendenza conservatrice oggi dominante nel mondo.
Non crede che gli interventi che si vogliono operare sulla seconda parte della Costituzione siano inevitabilmente destinati a impattare sulle regole e i principi enunciati nella prima parte?
 Certamente. La seconda parte è funzionale alla prima perché deve garantire che i principi sanciti nella Carta si affermino e i programmi si realizzino. Tra gli elementi essenziali perché l’armonia tra prima e seconda parte regga, c’è appunto la rigidità dei processi di revisione costituzionale oltre all’integrazione tra democrazia diretta e democrazia indiretta. Essendo venuta meno da ormai venti anni la rigidità costituzionale, l’ordinamento della seconda parte è diventato una groviera: minoranze elettorali nel Paese, che grazie a leggi disegnate su misura possono diventare maggioranze politiche, possono attuare vere e proprie scorribande nella Costituzione. La strada turca è aperta.
Certamente. La seconda parte è funzionale alla prima perché deve garantire che i principi sanciti nella Carta si affermino e i programmi si realizzino. Tra gli elementi essenziali perché l’armonia tra prima e seconda parte regga, c’è appunto la rigidità dei processi di revisione costituzionale oltre all’integrazione tra democrazia diretta e democrazia indiretta. Essendo venuta meno da ormai venti anni la rigidità costituzionale, l’ordinamento della seconda parte è diventato una groviera: minoranze elettorali nel Paese, che grazie a leggi disegnate su misura possono diventare maggioranze politiche, possono attuare vere e proprie scorribande nella Costituzione. La strada turca è aperta.
Una Carta Costituzionale dovrebbe essere un documento condiviso in cui si riconoscono le diverse forze politiche e gli italiani e non l’espressione di un governo o addirittura di alcuni membri del governo. Non è questione di galateo istituzionale, riguarda lo stesso spirito della Costituzione che non è, e non può essere, figlia di mutevoli maggioranze. A rendere sempre più marcato il processo di flessibilizzazione della Carta sono state le leggi maggioritarie introdotte in Italia dopo l’abbandono del sistema proporzionale.
 Invito tutti coloro che in buona fede sono per il Sì ad andarsi a leggere il disegno di legge costituzionale che porta le firme tra gli altri di Oscar Luigi Scalfaro e di Anna Finocchiaro, la stessa – en passant – che oggi sostiene le ragioni del Sì. Ebbene quel ddl chiedeva la modifica del quorum di garanzia previsto dall’articolo 138, perché con l’abbandono del sistema elettorale proporzionale era diventato “troppo facile cambiare le norme costituzionali”. Invece della maggioranza assoluta, ormai a portata di mano con i sistemi elettorali distorsivi della rappresentanza, si chiedeva l’elevazione della maggioranza ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera a partire dalla seconda votazione. E ancora si diceva che “il carattere rigido della Carta Costituzionale rappresenta, insieme all’indipendenza degli organi di garanzia il presidio più robusto per evitare che la Costituzione diventi uno strumento della politica della coalizione vincitrice nelle elezioni politiche. In quasi tutte le grandi democrazie si è ritenuto e si ritiene che le leggi di revisione costituzionale debbano essere il prodotto di larghe intese fra maggioranza e opposizione”. Insomma, concludeva quel testo, “un Paese non può vivere e crescere se le regole fondamentali della convivenza comune durano una sola legislatura e mutano a ogni cambio di maggioranza”. Come vede, in quel testo, c’era già scritto tutto. I rischi per la democrazia italiana erano chiaramente individuati. E, infatti, sino al governo Letta e con la benedizione di Giorgio Napolitano e di tutto il Pd era pacifico che il 138 non era utilizzabile per introdurre modifiche di vasta portata. Era un giudizio generale non solo dei vertici istituzionali italiani ma di tutto il pensiero costituzionale. L’uragano Renzi ha rotto lo schema.
Invito tutti coloro che in buona fede sono per il Sì ad andarsi a leggere il disegno di legge costituzionale che porta le firme tra gli altri di Oscar Luigi Scalfaro e di Anna Finocchiaro, la stessa – en passant – che oggi sostiene le ragioni del Sì. Ebbene quel ddl chiedeva la modifica del quorum di garanzia previsto dall’articolo 138, perché con l’abbandono del sistema elettorale proporzionale era diventato “troppo facile cambiare le norme costituzionali”. Invece della maggioranza assoluta, ormai a portata di mano con i sistemi elettorali distorsivi della rappresentanza, si chiedeva l’elevazione della maggioranza ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera a partire dalla seconda votazione. E ancora si diceva che “il carattere rigido della Carta Costituzionale rappresenta, insieme all’indipendenza degli organi di garanzia il presidio più robusto per evitare che la Costituzione diventi uno strumento della politica della coalizione vincitrice nelle elezioni politiche. In quasi tutte le grandi democrazie si è ritenuto e si ritiene che le leggi di revisione costituzionale debbano essere il prodotto di larghe intese fra maggioranza e opposizione”. Insomma, concludeva quel testo, “un Paese non può vivere e crescere se le regole fondamentali della convivenza comune durano una sola legislatura e mutano a ogni cambio di maggioranza”. Come vede, in quel testo, c’era già scritto tutto. I rischi per la democrazia italiana erano chiaramente individuati. E, infatti, sino al governo Letta e con la benedizione di Giorgio Napolitano e di tutto il Pd era pacifico che il 138 non era utilizzabile per introdurre modifiche di vasta portata. Era un giudizio generale non solo dei vertici istituzionali italiani ma di tutto il pensiero costituzionale. L’uragano Renzi ha rotto lo schema.

C’è un precedente di modifiche radicali, quello operato dal governo Berlusconi nel 2006. Con una riforma che prevedeva devolution, premierato forte e una riforma del Senato non dissimile dall’attuale.
È vero, ed è un precedente che prova molto, perché esattamente dieci anni fa, nel giugno del 2006 gli italiani chiamati ad esprimersi con il referendum costituzionale bocciarono sonoramente la riforma. A onor del vero – anche se con un esito diverso – a cambiare la Carta a colpi di maggioranza ci aveva pensato nel 2001 anche il centrosinistra con l’approvazione della riforma del titolo V.
Qual è la sua opinione sull’abolizione del bicameralismo paritario?
È una truffa bella e buona. Come ho fatto presente in un “appello dei socialisti del No alla Sinistra che sbaglia”, non solo il Senato sopravvive ma avrà competenza legislativa bicamerale piena in materia di tempi e di metodi dell’appartenenza dell’Italia all’Ue. Il Senato avrà inoltre, per la sua origine e per la sua composizione, natura asimmetrica rispetto alla maggioranza che si pensa di raggiungere nella Camera dei deputati per via della nuova legge elettorale, l’Italicum. Così si avrebbe una Camera politica con origine locale ma con competenza, insieme, sovranazionale ed irrazionale, tale da produrre l’effetto opposto a quello cui la riforma sarebbe mirata. Non, dunque, “la fine della confusione”, ma “una confusione senza fine”.
 Governo e Confindustria sostengono in coro – smentiti peraltro da osservatori attenti dell’ambiente economico e finanziario – che se vince il No il Paese torna nelle sabbie mobili. Facciamo chiarezza. Che succede davvero se vince il No?
Governo e Confindustria sostengono in coro – smentiti peraltro da osservatori attenti dell’ambiente economico e finanziario – che se vince il No il Paese torna nelle sabbie mobili. Facciamo chiarezza. Che succede davvero se vince il No?
Se vince il No, intanto, si ristabilisce il principio della supremazia della Costituzione e della sua rigidità rispetto alle leggi ordinarie. La strada da seguire è già tracciata, è il disegno di legge Scalfaro-Finoccharo che può essere ripreso e approvato in poche settimane. Ma non solo: il disegno di legge Letta-Franceschini-Quagliariello è in sonno. Si può riprenderlo e il giorno dopo insediare il Comitato per le riforme costituzionali. Altro risultato della vittoria del No dovrebbe essere l’impegno del governo a non assumere decisioni comunitarie che incidano sulla prima parte della Carta. Dirò di più: il serissimo rischio che corre oggi l’Italia, e non solo l’Italia, è che si possano cambiare le carte costituzionali secondo un dettato esterno non solo di entità sovranazionali ma anche di un grande investitore. È il subcolonialismo. Il No ripropone il problema della risistemazione del sistema politico e della nuova identificazione delle forze politiche prima che avvenga qualcosa che non ci consentirà più di farlo. L’Europa è a un bivio; nei prossimi due anni o c’è la spartizione dell’Europa – un impero franco-inglese, uno austro-ungarico-tedesco, uno ottomano – o c’è un sussulto unitario. Come intendiamo stare in questo processo? Con quale forza e quale progettualità?
Dentro al Pd tra minoranza e maggioranza si è assistito ad uno scontro aspro sulle modifiche all’Italicum. Scontro che si è concluso con la firma di Cuperlo su un documento che promette di modificare la legge elettorale nel senso indicato dalla sinistra dem. Ma quanto vale quel patto?
Sono dell’idea che la sinistra del Pd si sia fatta incastrare nel collegamento semplice tra legge elettorale e riforma costituzionale ignorando il punto fondamentale, e cioè che la legge elettorale è una legge ordinaria, modificabile quindi in qualsiasi momento. Se tu voti una legge costituzionale che crea le condizioni della flessibilità della Carta al posto della rigidità hai segato il ramo su cui sei seduto. Quel patto sull’Italicum sta in mano a un Parlamento che dall’inizio della legislatura ha avuto più di 200 cambi di casacca. Cosa ci vuole a manovrare un pezzo della propria maggioranza per fargli dire che quelle modifiche non vanno bene, che sono da archiviare? Non ci vuole nulla e Cuperlo stesso ne è consapevole. Altrimenti non avrebbe tirato fuori la categoria della “lealtà” che in politica vale quel che vale. Peraltro noto che, subito dopo aver siglato quel patto sulle modifiche all’Italicum, Renzi ha portato un affondo violentissimo nei confronti della minoranza. Non era mai successo che nel pieno di una campagna elettorale in cui si cerca il voto dei moderati si sputi in faccia al voto dei compagni di partito. Nella direzione del Pd Renzi ha quasi sorvolato sul patto sulla legge elettorale. E ha dimostrato le sue reali intenzioni quando ha detto che sì, si può pure togliere il ballottaggio ma trovando altre forme che garantiscano la governabilità. Insomma, vuole comunque una maggioranza, a prescindere dal corpo elettorale.
Il No è un fronte variegato. Questa disomogeneità è una debolezza o una forza?
Il pluralismo in democrazia è sempre una forza. Conta molto che dall’estrema destra all’estrema sinistra siano contrari alla riforma.
Pensa che in caso di sconfitta del Sì Renzi si dimetterà?
Di fatto si toglierà di torno. Nel Pd non rinascerà però la corrente umiliata del post comunismo. Rinascerà semmai il doroteismo cattocomunista. Se dovessimo identificare due personaggi di questo stile doroteo mi vengono in mente Delrio e Veltroni. È difficile, molto difficile, costruire una socialdemocrazia di massa in Italia perché è venuto meno il ceto medio. O, meglio, il ceto medio in questi ultimi anni si è andato radicalizzando come dimostra l’esperienza e il successo del Movimento 5 Stelle.
Giampiero Cazzato, giornalista professionista, ha lavorato a Liberazione e alla Rinascita della Sinistra; oggi collabora col Venerdì di Repubblica
Pubblicato venerdì 18 Novembre 2016
Stampato il 03/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/interviste/costituzione-col-si-si-apre-la-strada-a-cambiamenti-della-prima-parte/