Le premesse
 De Felice: c’è una crepa nel “consenso”
De Felice: c’è una crepa nel “consenso”
Nella sua sconfinata biografia mussoliniana Renzo De Felice si interroga sullo stato dell’opinione pubblica dopo la guerra d’Etiopia, nel periodo, cioè, in cui molti – e tra loro anche lo storico reatino – sostengono che si realizzò il maggiore consenso nei confronti del regime fascista: «A livello di massa – scrive De Felice – il coinvolgimento psicologico dei ceti popolari e soprattutto di quelli operai nella guerra d’Etiopia non equivaleva ad un pieno consenso politico verso il regime fascista: le riserve (come gli apprezzamenti) rimanevano e con esse le preoccupazioni e le insoddisfazioni connesse alle condizioni di vita e di lavoro, i timori per i sacrifici e i rischi che la politica estera mussoliniana poteva ancora provocare e le aspirazioni ad un diverso assetto politico » […] «E se lo si vede in questa prospettiva, si capisce come nel giro di pochi mesi – di fronte, prima alla vittoria del fronte popolare nelle elezioni francesi (che, confermando quella di pochi mesi prima del fronte popolare spagnolo, le diede una sorta di valore di tendenza) e poi, soprattutto, della guerra civile spagnola – i suoi termini cominciarono a subire alcuni mutamenti, non certo sconvolgenti, ma altrettanto certamente significativi, se non altro proprio perché essi dimostrano come la guerra d’Etiopia avesse inciso meno di quanto si fosse creduto e si potrebbe credere. E, in particolare, si capisce che esisteva ancora, sia pure latente o, se si preferisce, dormiente una serie di potenzialità antifasciste che in definitiva non attendevano altro che di essere rimesse in moto, ridestate, se appena vi fossero stati gli stimoli adatti e, ancor più, delle concrete prospettive per un’azione antifascista.

La documentazione di polizia è anche a questo proposito estremamente eloquente. I primi segni che qualche cosa si muoveva sotto le ceneri si ebbero subito dopo le elezioni francesi. Già prima della fine di giugno a Roma pervenivano da varie regioni, soprattutto del Nord, segnalazioni che si possono riassumere con le parole usate in una di esse inviata da Milano il 25 giugno (1936, ndr): “Le realizzazioni in senso socialista verificatesi in Francia, con l’avvento al potere del Governo del Fronte Popolare nonché la situazione politica creatasi nella Spagna, hanno indubbiamente determinato, negli ambienti sovversivi, la speranza, se non la convinzione, di una immancabile ripercussione, favorevole ai partiti sovversivi, sulla situazione politica interna italiana. Ciò risulta a quest’Ufficio da notizie fiduciarie e dal complesso degli elementi raccolti attraverso i vari servizi di investigazione. Gli avvenimenti politici sopraccennati hanno ridestato nel campo sovversivo in genere, ed in taluni circoli in specie, la illusione che il rafforzarsi nei vicini Stati europei del movimento di sinistra possa, presto o tardi, produrre in Italia le sue immancabili conseguenze, in danno del Regime Fascista”.
Con l’estate, parallelamente all’inizio e alle primissime fasi della guerra civile spagnola, il fenomeno prese via via maggiore consistenza, tanto è vero che nella relazione di fine anno redatta dal ministero dell’Interno si può leggere questa significativa affermazione: “Se l’impresa etiopica non ebbe alcun effetto in favore dei partiti politici antifascisti, ma anzi rafforzò lo spirito patriottico del popolo italiano e portò perfino ad un riesame di coscienza non pochi antifascisti, le vittorie dei fronti popolari nelle elezioni politiche francesi e spagnole prima e la guerra civile spagnola dopo hanno avuto una innegabile ripercussione in quella parte del popolo italiano che non ha aderito con pieno animo al Regime”.
Questi echi degli avvenimenti francesi e soprattutto spagnoli non vanno sopravvalutati. Essi riguardarono infatti ambienti limitati e non crearono certo difficoltà al regime. Essi – lo ripetiamo – indicano però bene come l’entusiasmo e l’esaltazione determinati dalla vittoria africana furono brevi e non tali da determinare un nuovo tipo di consenso tra i ceti popolari, nel senso, almeno, di un suo effettivo rafforzamento, sicché, in definitiva, questo uscì dalla guerra d’Etiopia, se non indebolito – che affermare ciò sarebbe, a livello di massa, eccessivo – per lo meno più minato di prima da motivi di insoddisfazione e da timori potenzialmente crescenti. Né questo fenomeno si verificò solo a livello dei ceti popolari. Sia pure con motivazioni parzialmente o totalmente diverse, lo stesso fenomeno si produsse infatti anche a quasi tutti gli altri livelli sociali. E in particolare tra i giovani, gli intellettuali, il mondo economico. Assai meno, invece, a livello piccolo e medio borghese, dove le motivazioni nazional-patriottiche (e spesso nazionaliste tout court), la retorica imperiale e l’esaltazione del duce furono – sempre generalizzando – più diffuse, più radicate e più durevoli. Particolarmente gravi per il regime furono le ripercussioni che la guerra ebbe tra i giovani e gli intellettuali». (Da Renzo De Felice “Mussolini il duce. Gli anni del consenso 1929-1936”, pp. 776-778).

Abbiamo mantenuto ampia la citazione dello storico reatino per non prestarci al rilievo di aver isolato qualche frase dal contesto, tradendone nella sostanza il contenuto.
Ci sembra innegabile che De Felice, pure impegnato in linea generale a sottolineare come i successi mussoliniani degli anni Trenta sul piano internazionale avessero portato a un rafforzamento del regime e del consenso degli italiani nei suoi confronti, si ponga e ponga una serie di interrogativi sugli atteggiamenti reali delle classi popolari e non solo di quelle. Classi popolari non soltanto non acquisite completamente alla causa fascista, ma descritte come pronte a cogliere qualunque sintomo di novità internazionali passibili di creare in qualche modo difficoltà al regime.
Analogo lo stato d’animo e l’atteggiamento dei giovani e degli intellettuali le cui inquietudini, se non ancora tradottesi in consapevole coscienza antifascista, significavano un inizio di presa di distanza dal mussolinismo e dalla sua propaganda. E tutto questo al di là della comprensione della stessa emigrazione antifascista, probabilmente e comprensibilmente delusa e sfiduciata per l’aspetto trionfale che il regime poteva presentare all’esterno.
Se la situazione tra il 1936 e il 1940 era connotata da queste caratteristiche, appare scontato che l’entrata in guerra e – dopo gli effimeri successi del primissimo periodo – le batoste militari che si succedevano implacabili l’una all’altra e i crescenti disagi che ne derivavano alla popolazione tendessero ad approfondire il solco tra fascismo e opinione pubblica in generale, e soprattutto tra fascismo, classe operaia, giovani e intellettuali, la cui fiducia nei confronti del regime era già in precedenza tutt’altro che “granitica”.
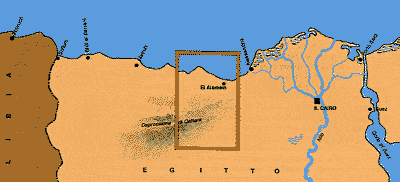 2) L’antifascismo torna a farsi sentire
2) L’antifascismo torna a farsi sentire
È noto che il 1942 fu un anno terribile per le sorti dell’Asse. Quasi in contemporanea, tra ottobre e novembre, le truppe italo-tedesche subirono le due sconfitte decisive di Stalingrado e di El Alamein.
La prima segnò la fine delle speranze di eliminare dalla guerra il colosso sovietico – e magari di fare una pace separata con Mosca, illusione nutrita a lungo dallo stesso Mussolini – e diede origine a una ritirata disastrosa soprattutto per il nostro corpo di spedizione, carente di mezzi motorizzati e abbandonato a se stesso dall’alleato tedesco; la seconda aprì la strada alla completa perdita dell’Africa settentrionale e avvicinò inevitabilmente la guerra al territorio italiano, con tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate.
Sul finire del 1942 si costituì a Torino il Comitato del “Fronte Nazionale d’Azione”. Stando alla testimonianza di Raimondo Luraghi (“Il movimento operaio torinese durante la Resistenza”), partecipavano alle riunioni: «Giorgio Caretto ed Egisto Cappellini per il Partito comunista; Luigi Carmagnola, Filippo Acciarini (e qualche volta, di sfuggita, Bruno Buozzi) per il Partito socialista; Mario Passoni e Renato Martorelli per il Mup; l’avvocato Allemandi (poi perito nei campi in Germania) e Luigi Salvatorelli per il Partito d’Azione, nato alla fine del 1942 dalla fusione tra il movimento “Giustizia e Libertà” e il movimento liberalsocialista dell’Italia centrale (nel gennaio del 1943 uscirà il primo numero del foglio clandestino L’Italia Libera, organo del PdA); Eugenio Libois e don Vincenzo Arcozzi-Masino per la Democrazia cristiana; Franco Antonicelli e Dante Coda per i liberali».
Ma già in precedenza, nel settembre 1941 in Francia si era giunti a un’intesa per l’unità d’azione tra comunisti, socialisti e Gl e, un anno dopo, sempre dalla Francia, il Comitato d’azione per l’unione del popolo italiano, che riuniva comunisti e socialisti, lanciò un manifesto con il quale si prospettava un ricorso alla lotta armata: «Italiani tutti! Per sviluppare vittoriosamente la lotta, organizzate dovunque dei gruppi d’azione che al linguaggio della forza rispondano con il linguaggio della forza! Italiani! È suonata per tutti l’ora dell’azione, l’ora del combattimento! Uniti e organizzati, possiamo vincere, dobbiamo vincere e vinceremo! Tutti in piedi! Tutti i cuori, tutte le volontà al servizio dell’Italia, della libertà e della pace!».
Già tra il giugno 1942 e l’inizio del 1943 c’erano stati scioperi sporadici in diverse regioni.
Alla vigilia dell’esplosione del marzo il Comitato d’azione per l’unione del popolo italiano rinnovò l’appello alla Resistenza: «È l’ora, per i più audaci, di prendere le armi e di organizzarsi in distaccamenti di partigiani per colpire dovunque è possibile gli occupanti hitleriani ed i loro agenti».
GLI SCIOPERI

Uno scritto di Umberto Massola
Per una prima ricostruzione degli avvenimenti del marzo 1943, ci avvaliamo del contributo di Umberto Massola, che fu uno dei maggiori organizzatori delle agitazioni, prima a Torino poi a Milano e che nel 1945 scrisse un prezioso opuscolo “Premesse e sviluppi degli scioperi di marzo-aprile 1943”. Eccone il testo quasi integrale, al quale era premessa una nota, che pure riportiamo:
«Gli scioperi del marzo 1943, insieme con la vittoria alleata, hanno ormai assunto nella comune considerazione storica, il ruolo di fattore determinante la crisi del 25 luglio. Essi rappresentano l’episodio più grandioso e significativo della tenace lotta che i partiti antifascisti hanno svolto contro la tirannide di Mussolini e la dimostrazione più eloquente del distacco che è sempre esistito fra il fascismo e le forze sane del nostro Paese.
Gli Italiani che non vissero direttamente a Torino ed a Milano quelle giornate, ne ebbero un’eco sbiadita e distante: la feroce censura fascista impedì che notizie esatte degli avvenimenti si propagassero per tutta la Penisola.
Lo scritto che qui pubblichiamo colma questa lacuna dandoci la cronaca particolareggiata e precisa di quelle vicende, fatta sulla base di una esperienza diretta».
E passiamo al testo vero e proprio del saggio di Massola: «Negli ultimi giorni del mese di aprile 1942, un gruppo di operai antifascisti della Fiat Mirafiori di Torino, in occasione del prossimo 1° maggio, decideva di offrire alla causa delle Nazioni Unite un primo grande e concreto aiuto. Dopo qualche giorno infatti alla Fiat Mirafiori un deposito pieno di caucciù, destinato alla produzione di guerra, veniva distrutto dalle fiamme.
I fascisti non fecero parola nei loro giornali di questa azione di sabotaggio. Ma la notizia si diffuse ugualmente. Ci pensarono a divulgarla i 16 mila operai della Fiat, e la popolazione torinese che aveva visto le fiamme innalzarsi al disopra dei recinti della fabbrica. L’organo dei comunisti torinesi, Il Grido di Spartaco portò la notizia fuori Torino, nel Piemonte, a Milano, nella Lombardia e altrove. I bagliori dell’incendio non erano ancora spenti che migliaia di operai occupati nella produzione di guerra, a Torino e Milano, si ponevano il compito di imitare l’esempio dei loro fratelli. Si sviluppò così un vasto movimento per la ricerca, la diffusione e l’applicazione di svariate forme e mezzi atti a ritardare, sabotare o distruggere la produzione bellica. Gli operai andavano a gara nel trasmettersi reciprocamente le proprie esperienze. Un gruppo di operai, della Grandi Motori di Torino, per esempio, comunicò a un gruppo di operai della Motomeccanica di Milano, che per “grippare” le bronzine senza lasciar traccia, in luogo del classico granellino di sabbia, era meglio utilizzare la tintura di iodio. Mentre si sviluppava questo movimento l’operaio nelle fabbriche cominciava a sentirsi meno solo, meno isolato, più fiducioso, più solidale verso i suoi compagni di lavoro. La classe operaia si riorganizzava, riprendeva fiducia nelle sue forze, si preparava a passare a forme di lotta più imponenti, agli scioperi, alle manifestazioni di strada, ponendosi così alla testa di tutto il popolo.
Da quando Mussolini aveva gettato l’Italia contro gli altri popoli, in Africa e in Europa e, in ultimo, contro l’Unione sovietica, il governo fascista non aveva cessato all’interno del Paese di prendere una serie di misure destinate ad alimentare, in mezzi ed uomini, la sua guerra criminale, aggravando sempre più le condizioni già difficili delle masse lavoratrici. Dopo oltre due anni di guerra, i salari e gli stipendi continuavano ad essere bloccati, mentre i prezzi dei generi di vario consumo aumentavano del 100%.
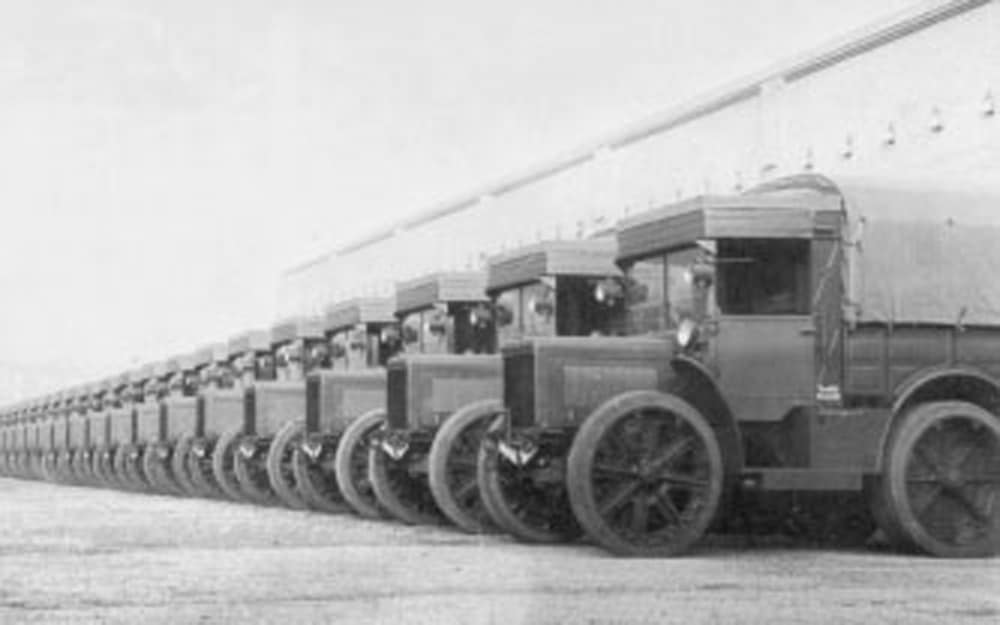
Si pesano gli operai torinesi
La razione-base del pane, della carne e dei grassi, benché fosse già insufficiente, subiva continue diminuzioni fino a raggiungere il più basso livello a confronto di tutti gli altri Paesi.
Nel mese di luglio 1942, i gerarchi fascisti stabilirono di far pesare gli operai di alcuni stabilimenti di Torino. Speravano di poter ottenere con i risultati di questa inchiesta, la possibilità di ridurre maggiormente il tenore di vita delle masse e nello stesso tempo di aumentare la quantità di derrate alimentari da inviare in Germania.
Alla Grandi Motori – stabilimento di 4 mila operai – l’iniziativa dei gerarchi fascisti rivelò che la maggioranza della maestranza nel corso della guerra aveva subito gravi perdite di peso. Risultava infatti che la perdita di peso di ogni operaio si aggirava dai 5 ai 14 chili: “operai che misuravano metri 1 e 70 ed oltre di altezza pesano soltanto 53-55 chili. La percentuale degli operai ammalati è in continuo aumento”, riferiva l’operaia C. nel luglio 1942. […]
Già verso la fine del mese di maggio 1942, in una fabbrica di Asti, gli operai si mettevano in agitazione e strappavano un aumento di paga di 3 lire al giorno. A partire dal mese di agosto gli scioperi e le manifestazioni di strada si affermarono con forza e continuità di sviluppo nel nostro Paese. Da agosto alla fine dell’anno, cioè in cinque mesi, si scatenarono dieci scioperi: alla Tedeschi e alla Fiat Mirafiori di Torino, all’Alfa Romeo, ILVA, Caproni, Isotta Fraschini e per tre volte alla Falk di Milano, alla Scari di Modena; e due manifestazioni di strada: a Grugliasco e a Melegnano. Risonanza notevole ebbe la sospensione del lavoro nel reparto aviazione della Fiat Mirafiori. Questo sciopero, indetto in occasione dell’introduzione della nuova lavorazione dei motori per gli Stukas, impedì una diminuzione del salario. Era la prima volta dopo tanti anni che gli operai di questo stabilimento si mettevano in sciopero. Con l’impedire la diminuzione del loro salario e paralizzando per 24 ore la produzione bellica di Hitler, come già in occasione del 1° maggio, essi servirono d’esempio ai lavoratori torinesi.
Nei primi due mesi del 1943, gennaio e febbraio, si scatenavano 11 grandi scioperi: alle Ferriere, Spa, Fiat Mirafiori, Fiat Lingotto e alla Diatto di Torino. Alla Caproni e alla Falk di Milano, alla Vai Assauto di Asti, alla Saffa in Toscana, in una fabbrica tessile nel Biellese e in una fabbrica di salumi a Fossano; una manifestazione di strada a Torino e una a Piacenza.
La media degli scioperi nell’anno precedente era di due per mese; nei primi due mesi del ’43 divenne di 5,5. Mentre durante gli scioperi degli ultimi cinque mesi del 1942, gli operai di fronte alla reazione fascista sovente si piegavano e cedevano, nel corso degli scioperi dei primi due mesi del 1943, essi dimostrarono maggiore esperienza, più decisione e minore arrendevolezza alle minacce e alle persecuzioni». […]

5 marzo 1943: Torino incrocia le braccia. 8 marzo: si muovono le donne
«Dovevano essere gli operai della Fiat Mirafiori a dare il segnale del grande sciopero del marzo-aprile.
Il 20 febbraio l’operaio L. riceveva direttive per scatenare lo sciopero. Le difficoltà per ottenere l’astensione totale dal lavoro da parte della maestranza sembravano insuperabili. In alcuni reparti dello stabilimento, oltre l’80% degli operai, provenendo dalla provincia, integravano il salario con lavori in campagna e sentivano meno i disagi alimentari. L’operaio L. e l’organizzazione, si mettevano subito al lavoro, in pochi giorni stampigliavano e diffondevano, in tutti gli stabilimenti e strade della città, migliaia e migliaia di manifestini minuscoli, composti di poche parole: “Per il pane, la pace e la libertà! W lo sciopero”.
La mattina del 5 marzo alla Fiat Mirafiori gli operai stavano in attesa del segnale-prova-d’allarme delle ore 10 per iniziare l’agitazione.
La Direzione dello stabilimento, preavvisata, dava ordine di non azionare il segnale. Nei reparti gli operai avevano “l’aria” di attendere qualche cosa. Le ore 10 erano già trascorse e il segnale non suonava. Gli operai cominciarono ad alzare la testa, guardavano i loro orologi, comprendevano l’inganno, e tutti assieme smettevano di lavorare. Si iniziava lo sciopero. In tutti i reparti il lavoro cessava e la maestranza si raggruppava. Accorrevano in fretta e furia i “pezzi grossi”: “Che succede? Che cosa volete?” e gli operai decisi e compatti rispondevano: “Vogliamo che le 192 ore siano pagate a tutti! Vogliamo il caro-vita! Vogliamo vivere in pace!”.
Oramai a Torino e dintorni ogni giorno alle ore 10 erano sempre più numerose le fabbriche, che sull’esempio della Fiat Mirafiori, arrestavano il lavoro. In poco più di una settimana i 100 mila operai della Fiat Mirafiori, della Westinghouse, della Nebiolo, Officine Savigliano, Ferriere Piemontesi, Microtecnica, Pirotecnica, Aeronautica, Riv, ecc. presero parte allo sciopero.
L’8 marzo si distinsero due manifestazioni fra tante che ce ne furono. In una gli operai dell’Aeronautica di corso Italia, chiusi a chiave nei loro reparti per aver iniziato lo sciopero, sfondavano le porte e si portavano in massa a reclamare di fronte alla Direzione. L’altra manifestazione si svolgeva in occasione della Giornata Internazionale della donna. Migliaia e migliaia di donne, convocate alcuni giorni prima con un manifestino, si recavano in piazza Castello a protestare contro la guerra e per la pace.
Uomini e donne che il fascismo credeva aver ridotto ad un branco di idioti affermavano così la loro volontà di pace e il loro diritto alla vita.
Nella giornata dell’11 marzo gli operai della Riv in via Nizza scatenavano lo sciopero. Mussolini ordinava di far intervenire i carabinieri e le guardie metropolitane per reprimerlo. “Ti ordino di lavorare!” – gridava il capo ad un operaio. “Date le 192 ore e il caro-vita!” gli veniva risposto. Lo sciopero iniziato alle ore 10 continuò nel pomeriggio. Gli operai e le operaie abbandonarono i loro reparti e seguitarono nel cortile dello stabilimento a manifestare. I gerarchi inviati dai sindacati fascisti, furono accolti da urli e da fischi e da grida: “Vogliamo il pane e la pace”. Alle ore 15 intervenivano i carabinieri e i metropolitani, i quali tentavano di percuotere e di arrestare alcuni manifestanti. Ma le operaie si mettevano a gridare: “Pane! Pace! Pane! Pace!” e gettandosi in avanti strappavano a viva forza dalle mani delle guardie i loro compagni di lavoro.
Al sesto giorno di sciopero, Mussolini, vedendo l’impossibilità di piegare la ferma decisione degli operai, non potendo rompere il solido legame che nella lotta univa i lavoratori di ogni tendenza politica e fede religiosa, non volendo far nessuna concessione alle giuste richieste delle maestranze, tentava, facendo intervenire la sbirraglia, di soffocare il movimento. Ma non ci riusciva.
In tutti gli operai e in tutti i ceti cittadini gli scioperi di Torino sollevavano grandi ondate di simpatie e di speranze: essi avevano l’appoggio di tutta la nazione che voleva farla finita con la guerra. Solo Mussolini e i gerarchi fascisti erano furibondi e si preparavano alle repressioni più feroci contro i coraggiosi lavoratori torinesi. In una tale situazione, urgeva sviluppare un vasto movimento per appoggiare lo sciopero di Torino, occorreva estendere l’agitazione agli altri centri industriali del Paese per costringere il governo fascista a cedere. Il comitato operaio creato a Torino per dirigere lo sciopero, la sera del 12 marzo lanciava un manifestino ai lavoratori della città e provincia per invitarli a proseguire e ad estendere il movimento e inviava un compagno a Milano per sollecitare l’intervento di quelle masse operaie.

E ora tocca a Milano
Il 14 marzo a Milano si riunivano i membri della Direzione del Pci là presenti i quali, accolta la proposta del Comitato operaio di Torino, lanciavano un manifestino ai lavoratori milanesi e prendevano una serie di misure per assicurare l’estensione del movimento. Il 15 marzo veniva diffusa a Torino, Milano e in molti altri centri industriali l’Unità. Grandi titoli annunciavano: “Lo sciopero di 100 mila operai torinesi”. La direttiva era chiara: “Tutto il Paese segua il loro esempio per conquistare il pane, la pace e la libertà”.
Dal 16 marzo ai primi di aprile lo sciopero si estese in tutti i principali centri industriali del Piemonte: a Pinerolo, Villar Perosa, Asti, Savigliano, Biella, nella valle d’Aosta, ecc., e nella Lombardia.
A Milano nei giorni 16, 17 e 18 marzo si riunirono i comitati di zona del Pci. Il 19 alla Caproni e in alcuni stabilimenti di Sesto San Giovanni si verificarono i primi scioperi. Nel corso della settimana successiva il movimento si estese in tutti i principali stabilimenti della città e della provincia, alla Pirelli, Breda, Motomeccanica, Borletti, Marelli, ecc. Alla fabbrica Innocenti la maestranza, composta in maggioranza di donne, scendeva in massa nel cortile della fabbrica e sosteneva violenti scontri con le guardie metropolitane inviate dai gerarchi fascisti. Alla Face in via Bovio, le operaie manifestavano al grido: “Abbasso la guerra!”. Le guardie spararono sulla folla uccidendo un’operaia e ferendone gravemente altre nove.
Alla Borletti ed alla Pirelli, i soldati inviati per reprimere lo sciopero fraternizzavano con gli operai. Ad Abbiategrasso un membro del Gran Consiglio fascista, Cianetti, tentava di parlare alle maestranze, ma veniva preso a sassate e messo in fuga. Alla Brown Roveri, alle ore 10 del 24 marzo, i giovani apprendisti del reparto n. 71 iniziavano per primi lo sciopero. Il direttore ing. Rolandi, accompagnato dai diversi capiservizio, si portava sul posto per reprimerlo. Gli operai del reparto n. 70, venuti a conoscenza dell’intervento del direttore, accorrevano in difesa dei giovani compagni di lavoro. Un operaio affrontava il direttore e in presenza della maestranza esponeva e difendeva i motivi dell’agitazione. Lo sciopero nel pomeriggio si estese in tutto lo stabilimento.
Malgrado la repressione ordinata da Mussolini, malgrado le centinaia e centinaia di operai arrestati a Torino, Asti, Biella, Pinerolo e a Milano e provincia, lo sciopero continuò ad estendersi.
La vittoria operaia
L’agitazione minacciava di svilupparsi nelle fabbriche della Liguria, Venezia Giulia e dell’Emilia. Nell’impossibilità di arrestare il movimento con i soliti mezzi repressivi a causa della possente e organizzata azione delle masse operaie, il governo fascista fu costretto a cedere.
Il 3 aprile, dopo un mese di scioperi, dopo l’interruzione di un mese nella produzione bellica, la classe operaia obbligava Mussolini a operare una prima grande “ritirata strategica”: i salari e gli stipendi furono aumentati.
Gli scioperi, iniziati il 5 marzo, terminarono nella prima quindicina del mese di aprile con una importante vittoria della classe operaia italiana. Il grande movimento, avendo colpito il governo fascista all’interno del Paese, rappresentò il primo grande contributo della popolazione italiana alla guerra di liberazione degli Alleati. Lo sciopero ebbe un’eco in tutto il mondo e i suoi effetti furono decisivi per lo sviluppo della vita politica del nostro Paese. I popoli progressivi accolsero e salutarono gli scioperi della classe operaia italiana come una grande manifestazione degli italiani contro la guerra nazifascista. L’apparato del governo e delle organizzazioni fasciste si sgretolò. Sotto la pressione delle sconfitte militari e sotto l’azione delle masse lavoratrici italiane il governo fascista precipitava verso la sua completa rovina.
Nel mese di aprile si sviluppò una grave crisi nel governo, nella Direzione del partito e nei sindacati fascisti. Vidussoni, segretario del Pnf e il presidente della Confederazione dei lavoratori dell’industria, Giuseppe Landi, venivano defenestrati e sostituiti. Nei mesi di maggio-giugno, nel tentativo di arginare l’impetuoso sviluppo del movimento delle masse e la crescente decomposizione dell’apparato fascista, numerosi ministri, sotto-segretari di Stato, prefetti e gerarchi dei sindacati e del Partito fascista venivano eliminati oppure sbalzati da un capo all’altro dell’organizzazione». […]

La ricostruzione di Oreste Lizzadri
“Quel dannato marzo 1943” è il titolo di uno scritto che dedicò alle agitazioni il socialista Oreste Lizzadri, il quale avrebbe guidato il sindacato unitario con Giuseppe Di Vittorio e Achille Grandi nel primo dopoguerra.
Ecco la sua testimonianza sugli avvenimenti: «14 marzo 1943. Per la prima volta, dopo anni di attese e di speranze, gl’italiani che pazientemente soppesavano, distillandole, le informazioni dei quotidiani fascisti, per trovarvi quel “qualche cosa” che ormai da tempo alimentava l’ius murmurandi e confermasse le notizie della radio clandestina ebbero, la mattina del 14 marzo 1943, di che rallegrarsi. La Gazzetta del popolo e La Stampa di Torino, in cronaca ma bene in evidenza, riportavano, con le stesse parole e lo stesso titolo, “i rapporti del federale ai dirigenti sindacali e alle gerarchie”. “Il federale” riferivano i due giornali “ritornato ieri mattina da Roma ha tenuto rapporto alle ore 11, nella sala delle riunioni a casa Littoria, ai dirigenti sindacali. Durante il rapporto sono stati trattati dal gerarca argomenti interessanti l’attuale situazione in tutti i settori”.
“Nel tardo pomeriggio il federale ha presieduto il rapporto dei componenti il direttorio federale del fascio di Torino e dei fiduciari dei gruppi rionali, impartendo ai presenti direttive per l’azione da svolgere”».
Tutto qui? Poteva sembrare ordinaria amministrazione; una delle tante manifestazioni che, specialmente dopo le notizie poco liete sull’andamento della guerra, si susseguivano a ripetizione in tutte le città per mantenere in piedi lo spirito guerriero del popolo italiano.
E, invece, no. La popolazione torinese già sapeva di che si trattava e in molte altre città italiane prendevano corpo le notizie diffuse da Radio Londra e quelle riportate da “viaggiatori occasionali” sulla grande lotta ingaggiata dagli operai della capitale piemontese contro il fascismo e la guerra. Che si trattasse di “cose serie” lo si vide con maggior chiarezza dopo il 15 marzo. Il consigliere nazionale Rocca, inviato a Torino di rinforzo al federale, in una grande riunione alle categorie industriali fece ricorso a parole grosse, riportate anch’esse con grande rilievo tipografico dai due giornali. “Guai a chi rallenta”, “Ogni officina è come una trincea”, “I doveri dei produttori verso la nazione in armi”. Parole grosse ma inefficaci – evidentemente – perché, a tre giorni di distanza, troviamo a Torino il vice segretario stesso del partito, Scorza. Alla Grandi Motori, all’Aeronautica, alla Spa, alla Mirafiori, alle Ferriere, nei rapporti alle gerarchie, nei colloqui coi capi reparto e capi squadra, nelle istruzioni ai dirigenti sindacali, il suo tono è ancora più allarmato. “Tutti al proprio posto di lavoro – ogni e qualsiasi movimento che non sia consono alle direttive di assoluta disciplina nazionale, deve essere considerato come un abbandono del posto di combattimento”.
I “fermi propositi” e le “imponenti adunate”
Minacce ed incitamenti non devono avere raggiunto lo scopo se il 22 marzo, entra nel giro il sottosegretario Cianetti, già dirigente sindacale a livello nazionale e ritenuto fra i pochi capaci di usare un linguaggio comprensibile per le masse operaie. Egli è a Torino, nei giorni seguenti, in fabbriche grandi e piccole, mobilita il federale e altri gerarchi di rango inferiore per stabilimenti più modesti come la Metalgas e la Rasetti e si sposta precipitosamente a Milano ove le notizie di Torino hanno incontrato pronta rispondenza fra le maestranze dei grandi complessi industriali.
“Cianetti parla ai lavoratori per il potenziamento dello sforzo produttivo”, “Due raduni presieduti dal sottosegretario”, “Resistere e vincere nel rapporto di Cianetti al fascio”, “Adunata di fiduciari dei sindacati dell’industria con l’intervento di Malusardi”, “Fermo proposito di lavorare e resistere”, “Imponente adunata dei lavoratori dell’industria presieduta dall’ecc. Cianetti”, “Rapporti agli industriali e alle gerarchie fasciste”. Questi sono i titoli del Corriere della Sera e del Popolo d’Italia nei giorni 28, 29 e 30 marzo. Cosa stava dunque maturando nelle due grandi città del nord in quel dannato marzo del 1943?
Ai mercatini rionali di ogni città d’Italia si parlava di grossi avvenimenti e le massaie che duravano tanta fatica a mettere qualche cosa nella borsa della spesa si consolavano a vicenda, trasmettendosi a cenni e a sussurri parole segrete.
Negli uffici, sui posti di lavoro era un ammiccar d’occhi; i rappresentanti di commercio vendevano notizie per invogliare ad acquistar merce e, la sera, in tutti una gran fretta di tornare a casa per apprendere dalla “bocca della verità” (Radio Londra) la reale portata degli avvenimenti.
Era proprio vero che il fuoco, per tanti anni covato sotto la cenere, ravvivato dalle privazioni, dalla sfiducia crescente nel regime, dall’oppressione sempre più pesante della polizia, dalle notizie dei fronti di guerra finalmente era divampato? Si era veramente al principio della fine? Questo si domandavano e speravano milioni di italiani di ogni classe sociale, uomini e donne, grandi e piccoli, in quell’inizio di primavera del 1943. E il regime, perduta ogni capacità di percepire lo stato d’animo del popolo, credette di porre rimedio alla inquietudine crescente stringendo i freni, diffondendo notizie false sull’andamento della guerra vantando vittorie inesistenti, imponendo lo slogan: “Qui non si parla di politica, si lavora”. Il quale slogan ebbe l’unico effetto di indurre anche quei pochi, che ancora nutrivano fiducia, a non averne più e a rendere loquaci persino coloro ai quali la paura aveva impresso sulle labbra il sigillo del fascio littorio.
La sirena non suona. È il principio della fine?
Qualche cosa infatti era accaduto. La mattina del 5 marzo 1943, alla Fiat Mirafiori di Torino, contrariamente all’uso introdotto nel corso della guerra, non venne dato il segnale – prova d’allarme delle ore 10 – “perché?”. Le autorità politiche e la polizia erano state informate che quel segnale, quel giorno, avrebbe significato un allarme di ben altra natura: l’inizio dello sciopero generale nel più grande stabilimento torinese. Ma il trucco, come tutti gli inganni che vanno contro una aspettativa fortemente diffusa e sentita, non riuscì. Pochi minuti dopo le 10 gli operai, intuita la ragione del mancato segnale, spontaneamente e passandosi la parola d’ordine da reparto a reparto, incrociarono le braccia. Dopo vent’anni, uno sciopero in pieno fascismo e in piena guerra?
Era veramente il principio della fine.
La notizia attesa e desiderata si diffuse, com’è ovvio, in un baleno. Solo la polizia stentava a credere nella riuscita dello sciopero. Ai militi fascisti, invece, mobilitati qualche giorno prima e accasermati sul piede di guerra, fecero credere trattarsi di uno sbarco alleato a Genova, per il secondo fronte.
Alla Fiat Mirafiori seguirono, solo poche ore dopo, le officine Savigliano, poi la Fiat Grandi motori, la Westinghouse, le ferriere piemontesi, la Pirotecnica ed altri stabilimenti di minore importanza.
Dopo una settimana, ripristinato l’allarme, salirono a centomila gli operai che, al segnale, arrestavano il lavoro per reclamare le 192 ore mensili, l’aumento della razione alimentare e la fine di quella guerra che il regime aveva voluto caratterizzare e monopolizzare come “guerra fascista”. Nei giorni seguenti le cose precipitarono. Lo sciopero dilagò negli altri centri industriali del Piemonte. Prima alla Riv di Villar Perosa, poi ad Asti, a Biella, Vercelli, Rivoli, Collegno, Avigliana, quindi ad Alessandria e in tutti i principali centri industriali del Piemonte.

La repressione
Frattanto le abitazioni degli scioperanti venivano invase di notte da gruppi di agenti dell’OVRA che, oltre ad intimidire le mogli, malmenavano e arrestavano quelli che, durante la giornata, si erano dimostrati più combattivi. Il primo bilancio degli arresti poté farsi soltanto il 12 marzo: risultarono fermati 164 operai dei quali 117 internati nelle carceri di Torino e 47 in quelle della provincia. In seguito le repressioni aumentarono. Il 13 ne venivano segnalati 15 alla Riv di Villar Perosa, due giorni dopo 21 alle officine di Savigliano. Malgrado ciò la lotta si estendeva aumentando di combattività. Il 16 marzo la Confederazione degli industriali faceva sue le direttive del sig. Funk presidente della Reichsbank: “blocco assoluto dei salari”.
Finché la mattina del 24 marzo, con le fabbriche Pirelli di via Fabio Filzi e della Bicocca, lo sciopero raggiunse Milano e, con Milano, quasi tutto il complesso industriale della grande città lombarda. Il 25 la Ercole Marelli e la Borletti, il 26 la Bovisa e la Caproni, nei giorni successivi altri stabilimenti di minore importanza. Anche a Milano, malgrado l’intervento ancora più minaccioso della polizia e del padronato, lo sciopero si estendeva in tale misura che la stampa non poté più ignorarlo. Ed ecco il Corriere della Sera del 30 marzo uscire col titolo vistoso “Cianetti parla ai lavoratori”, “Due raduni presieduti dal sottosegretario” e Il Popolo d’Italia, “Fermo proposito di lavorare e resistere”, “Imponente adunata di lavoratori dell’industria presieduta dall’eccellenza Cianetti”, ecc.
E il 31 marzo, quasi a preparare l’atmosfera della sconfitta, sul Popolo d’Italia si poteva leggere: “Tutti per la vittoria, il fascismo milanese blocco compatto di volontà”. Parole, parole, ultimi razzi della girandola.
Il 2 aprile il regime cedette. A nulla erano valsi arresti, minacce e intimidazioni poliziesche e padronali: diffide, licenziamenti, tentativi di corruzione, manovre disgregatrici per dividere i lavoratori. Perché? La lotta aveva perduto il carattere rivendicativo salariale per trasformarsi in movimento squisitamente politico. I capi fascisti che si recavano nelle fabbriche venivano accolti con le braccia incrociate e, spesso, con sonore fischiate e grida di “abbasso la guerra”, “abbasso il fascismo”.
In realtà non erano gli operai della Fiat e della Pirelli, come tali, a ribellarsi. Questi erano soltanto l’avanguardia di tutto il popolo che sentiva giunta l’ora di liberarsi da un regime di violenza, di sopraffazione, di tirannia, di slogan, di parole. Era la fine del “credere, obbedire, combattere”, “se avanzo seguitemi”, “il duce ha sempre ragione”, “dell’aratro che traccia il solco”. La fine delle aquile dorate, degli stivaloni, delle divise, delle occhiate truci, la fine dei galloni.
L’unità nazionale contro il fascismo
Gli scioperi del marzo del ’43, sviluppatisi unitariamente sul rifiuto del padronato e del regime di accogliere richieste di carattere economico e trasformatisi via via in movimento politico antifascista e contro la guerra, ratificarono, dopo un mese di lotta, non soltanto la vittoria dei lavoratori sul terreno salariale. Essi segnarono qualche cosa di più: la prima, grande vera sconfitta del fascismo nei suoi elementi ritenuti i più vitali, quali la potenza della forza repressiva poliziesca e di partito, il mito della sua organizzazione di ferro, la decantata adesione totalitaria dei lavoratori e del popolo italiano al regime. Per la prima volta, gli operai iscritti al partito si rifiutarono di presentarsi in fabbrica in camicia nera e gli stessi militi, mobilitati per stroncare lo sciopero, fecero causa comune con gli scioperanti.
Nei mercati, nei negozi e per le strade, sia pure sommessamente, si discuteva; ma i commenti che si riusciva a captare erano tutti di solidarietà con gli scioperanti e di esecrazione per la guerra e il fascismo. L’unità nazionale che il regime si sforzava di raggiungere, facendo perno sulla guerra, andava, sì, realizzandosi, ma in senso opposto: contro lo stesso regime. […].
Il valore dell’unità sindacale
Eppure, a considerarli a 18 anni di distanza e alla luce degli sviluppi che ne scaturirono, due conclusioni possono trarsi senza timore di violare la verità. La prima è che quegli scioperi, condotti e realizzatisi unitariamente, se da una parte rappresentarono il punto di arrivo di una situazione che faticosamente, ma costantemente andava maturando nel Paese, costituirono, dall’altra, la vera base di partenza dei successi futuri.
Dall’unità popolare ebbero origine, infatti, la caduta del fascismo, i Comitati di liberazione nazionale, la lotta partigiana. La seconda conclusione e, forse, la più interessante dal nostro punto di vista, fu la presa o la ripresa di coscienza da parte della classe operaia, nuova e vecchia generazione, della propria forza e delle sue enormi possibilità di ogni sua azione sul terreno unitario.
Da questa presa di coscienza nacque la Confederazione generale italiana del lavoro unitaria, e l’unità della Cgil rappresentò il fattore determinante della caduta della monarchia, della proclamazione della repubblica e della rinascita dell’Italia […]».

Una lettura attuale
Vincenzo Scudiere, già segretario generale della Cgil per il Piemonte, per Patria, interpreta il significato delle agitazioni operaie a 60 anni di distanza.
Ecco il suo articolo: «A Torino e in Piemonte, tra il marzo e l’aprile del 1943, vi fu una risposta senza precedenti degli operai delle principali fabbriche che segnò il destino del regime fascista.
Come spesso capita, gli scioperi non nascono dal nulla e anche in quegli anni le condizioni dell’Italia, nel contesto più generale, e quelle di milioni di persone, rappresentano la spinta da cui parte l’iniziativa del movimento operaio torinese.
II ’43 rappresentò un anno molto complicato: c’era la guerra e in essa andavano in crisi le certezze su cui si erano basate le sciagurate scelte nazifasciste, l’Asse (Germania, Italia e Giappone) che era accomunato dalle ideologie autoritarie e fasciste perdeva di giorno in giorno credibilità nei confronti dell’alleanza che legava l’Urss alle democrazie occidentali, soprattutto alle potenze rappresentate da Usa e Inghilterra. La svolta reale fu rappresentata dalla sconfitta di Hitler a Stalingrado. In quel contesto molti cominciano ad interpretare e a percepire la possibilità di un cambiamento.
II ’43 era l’anno in cui si concentravano molti avvenimenti: i pesanti bombardamenti alle nostre città, gli americani sbarcavano in Sicilia, cadeva il fascismo, con l’occupazione nazista e la ricostruzione di un nuovo regime fascista, nasceva la Resistenza, in un quadro economico difficile in cui la fame era ormai la condizione che colpiva le popolazioni meno abbienti. In quell’anno, dopo vent’anni di silenzio, dal 5 marzo a tutto aprile, gli scioperi segnarono e diedero un contributo straordinario alla caduta del regime fascista.
I vent’anni precedenti furono caratterizzati dalla cancellazione di qualsiasi diritto, dall’obbligo di obbedienza assoluta, dall’iscrizione obbligatoria al partito e al sindacato di regime. Ma tutto il sistema a nulla servì a fronte del peggioramento concreto delle condizioni materiali dei lavoratori. Era difficile sopravvivere con una condizione economica miserevole, era difficile continuare a vivere in disagio e in condizioni di sfruttamento continuo. Ma la guerra era considerata la causa principale del peggioramento delle loro condizioni.
E insieme ad essa la perdita delle libertà già avvenuta con l’avvento del regime assunse una caratteristica tale da fungere da humus sul terreno minato dagli altri problemi: gli scioperi segnavano una effettiva svolta.
A Torino e in Piemonte furono decine gli atti esemplari che anticiparono e accompagnarono la graduale adesione agli scioperi: dall’accoglienza silenziosa al discorso di Mussolini a Mirafiori fino ai primi tentativi falliti proprio a Mirafiori, ma grazie ai quali scattano le prime reazioni che registrarono qualche settimana dopo i primi scioperi realmente riusciti: la Microtecnica, le Ferriere, l’Aeronautica, fino alla stessa Mirafiori. Poi l’adesione si estende al Piemonte, ad Asti, a Biella, a Pinerolo. In breve Torino diventa riferimento importante per le altre città, a partire da Milano.
Anche allora, come oggi, fu la messa in discussione della condizione concreta dei lavoratori la molla che fece scattare la lotta. Riprendere l’iniziativa della condizione operaia anche oggi può servire a rimettere in campo una risposta che va al di là degli obiettivi immediati. Non può essere un paragone diretto tra quelle condizioni e quelle che oggi sono in discussione, a partire dai diritti. Ma quella storia, i suoi pregi e i suoi difetti, con le azioni convinte di quei militanti, può servirci oggi a costruire iniziative mirate alla missione principale di un sindacato: il miglioramento delle condizioni materiali delle persone che si rappresentano in un quadro di miglioramento delle condizioni generali. L’attacco ai diritti mira a peggiorare le condizioni dei lavoratori e del Paese, la cui situazione economica peggiora di giorno in giorno. L’iniziativa della Cgil acquisisce consenso perché è attenta alla difesa e all’allargamento dei diritti e nel contempo punta a migliorare le condizioni generali dell’Italia.
Già questo ci fa dire che la lezione del ’43 e tutto ciò che portò alla liberazione dell’Italia dal nazifascismo l’abbiamo ben interpretata e sarà difficile convincerci del contrario».

Sciopero economico o politico?
Quale significato attribuire a questa esplosione di malcontento popolare in una situazione in cui scioperare poteva significare essere arrestati, deferiti al tribunale speciale, andare in galera o al confino? Il regime si sforzò di sostenere che gli scioperi erano motivati da ragioni esclusivamente di carattere economico. Non soltanto per non ammettere che esistessero crepe e che gli italiani si stavano avvicinando al punto di non-sopportazione, ma anche perché, in questo modo, si finiva per attribuirne la responsabilità ai nemici che, con i bombardamenti e con le loro iniziative militari, imponevano al popolo italiano le restrizioni economiche di cui esso doveva soffrire.
Scese in campo lo stesso Mussolini, con una serie di dichiarazioni di tenore parzialmente diverso e non sempre coerenti tra loro. Il 10 marzo, in un discorso al Direttorio del Partito nazionale fascista, il duce ebbe a dire: «… in questi ultimi giorni c’è stato a Torino il primo fenomeno di un movimento di carattere operaio collettivo, dovuto a ragioni di questo genere: si è data l’indennità di sfollamento alle famiglie degli operai sfollati; a un certo punto s’è richiesto che anche quelli che erano rimasti avessero un’uguale indennità di sfollamento. In genere io ero sempre stato contrario a questo, ma adesso dichiaro nella maniera più esplicita che non darò neppure un centesimo. Noi non siamo lo Stato liberale che si fa ricattare da una fermata di un’ora di lavoro in un’officina. Considero questo come un tradimento vero e proprio». Il capo del fascismo, da un lato riconosceva il carattere “collettivo”, cioè di massa, delle agitazioni operaie. Dall’altro tentava di minimizzarne la portata, salvo a contraddirsi subito conferendo a quella che aveva appena definito “una fermata di un’ora di lavoro”, cioè qualcosa di completamente irrilevante, la dignità e il peso di “un vero e proprio tradimento”.
A distanza di qualche giorno, il 20 giugno, Mussolini tornò sulla questione, anche questa volta contraddicendosi: «Le masse operaie. Le sospensioni, talune di brevissima durata, del lavoro del marzo scorso furono sporadiche e a sfondo economico. Ogni tentativo di tramutarle in “politiche” fallì nella maniera più ridicola e pietosa. All’invito “clandestino” di dimostrazioni in piazza, nessuno, dico nessuno, rispose. Le classi operaie sono in linea col resto della nazione. Credo che un nuovo impulso alla vita sindacale convincerà gli operai che veramente il regime fascista è il miglior regime che essi si possono attendere in qualsiasi parte del mondo. A tal proposito è bene che i dirigenti dei sindacati vivano fra gli operai, non “sopra” gli operai, bensì “tra” gli operai, non disdegnando i più frequenti contatti con gli operai. I quali, del resto, quando non siano viziati dalle chimere bolsceviche, sono delle brave persone, educate, tranquille e che chiedono soltanto di essere apprezzate nella loro fatica e informate». In un contesto di mondo del lavoro completamente allineato e coperto, persino ben educato, che significato aveva il riferimento alle “chimere bolsceviche”?

Una verità scomoda
Come si vede, nelle maglie dei ragionamenti, ogni tanto faceva capolino, in modo incontrollabile, un’altra verità molto più scomoda per Mussolini e i suoi seguaci. Gli stessi curatori dell’«Opera omnia» del duce, Edoardo e Duilio Susmel, di tutto sospettabili tranne che di simpatie antifasciste, si resero conto evidentemente che qualcosa non quadrava e, nel presentare la riunione del Consiglio dei ministri del 14 marzo, scrissero: «Si notava una certa attività dei partiti clandestini, specialmente dei comunisti, che facevano breccia fra operai e studenti, particolarmente a Firenze e a Padova, ed anche all’interno di reparti militari. Venivano diffusi giornali alla macchia, con la parola d’ordine “Morte al fascismo, pace a ogni costo”. Durante il mese di marzo, inoltre, col pretesto di rivendicazioni d’ordine economico, si erano verificati per la prima volta, dopo moltissimi anni, alcuni scioperi di industrie nell’Italia settentrionale; scioperi cui avevano partecipato lavoratori dei sindacati fascisti, anche tesserati del Pnf e perfino militi. Particolarmente accentuato era stato il movimento a Torino, in stabilimenti adibiti a produzioni belliche. Eseguiti con la parola d’ordine “sacco vuoto non sta in piedi”, quegli scioperi erano intesi al fine di miglioramenti economici, ma nascostamente alimentati da propaganda sovversiva. Avevano avuto però durata ed estensioni limitate».
È difficile non definire patetici questi tentativi di dire e non dire, di ammettere e smentire. Anche Carmine Senise, il capo della polizia che fu silurato proprio in quei giorni, pure allineandosi alla versione ufficiale sulle motivazioni economiche e salariali, non poté ignorare l’esistenza di «finalità politiche, specialmente pel fatto che gli stabilimenti nei quali gli operai incrociarono le braccia erano tutti di produzione bellica». Un altro esponente di rilievo del regime, il sindacalista Edoardo Malusardi, finì per sconfessare apertamente la versione ufficiale, affermando: «È inutile che ce lo nascondiamo, quello che sta succedendo nelle fabbriche non è semplicemente un’agitazione per rivendicazioni economiche, ma risponde ad un chiaro obiettivo politico. È evidente che le masse sono guidate dalle forze oscure dei nemici della patria». E il “sindacalista” Malusardi che, secondo le indicazioni del capo, avrebbe dovuto vivere tra i lavoratori, non esitava ad invocare strumenti estremi di repressione: «È bene che si sappia che in Germania si agisce ben diversamente. Quando gli operai incrociano le braccia, i nostri grandi alleati procedono alla decimazione come si usa al fronte. Nello stesso modo si colpiscono quelli che osano raccogliere denaro per aiutare le famiglie dei fucilati». È un notevole esempio di come in regime fascista fossero tutelate le ragioni dei lavoratori da parte dei loro stessi sedicenti rappresentanti. Ma soprattutto è la rivelazione di quanto le agitazioni operaie terrorizzassero gli uomini del regime, per i quali si trattava di cose addirittura inconcepibili.
D’altra parte, più di ogni parola, ragionamento o ammissione, contano i fatti. A pochi giorni dallo svolgimento degli scioperi ci fu un vero e proprio terremoto ai vertici del regime, con il cambio della guardia alla segreteria del Pnf (dimissioni di Vidussoni e nomina di Scorza) e la sostituzione del capo della polizia Carmine Senise con Renzo Chierici.

Parri: senza classi lavoratrici, nessuna rivoluzione
Ma gli scioperi del marzo 1943 ebbero grande importanza anche nei confronti dei partiti antifascisti.
Sulle reali motivazioni e sul loro valore ha scritto Ferruccio Parri: «Le causali dello sciopero sono modeste: motivi di carattere principalmente annonario che riguardano la tessera, le razioni, i rifornimenti, soprattutto dei grassi. Ma la loro natura, il loro valore, è quello di un atto politico. È una ribellione, è la prima delle aperte e dichiarate ribellioni del popolo italiano nei riguardi di questo regime».
“Maurizio” proseguiva sottolineando come dall’esperienza del marzo 1943 fosse emersa una forte lezione per tutto lo schieramento antifascista: «Chi di noi non sarebbe stato colpito, e non avrebbe sentito l’interesse e il valore di una lezione che acquistava ora ancor più chiara evidenza? Senza classi lavoratrici niente rivoluzione seria, ed era una lezione, per me e direi per i gruppi idealmente vicini, soprattutto gli intellettuali, la lezione fondamentale delle forze con le quali si fa la storia, con le quali si deve fare una certa storia; con le quali si doveva fare la lotta contro il fascismo. In questo Paese tarato da una tradizione, voi sapete quanto antica, che oscilla tra servilismo e ribellismo, una insurrezione nazionale non poteva esser tale se non aveva il concorso di queste forze popolari. Era allora, nel 1943, che la possibilità di una insurrezione emergeva di nuovo dopo una lunga esperienza negativa che aveva preso fine, forse, nel 1930 quando era parso che a Milano fosse ancora possibile organizzare uno sciopero generale, poi rivelatosi impossibile. Questa è l’importanza storica degli scioperi del 1943, sintomo peraltro anche di fatti politici di notevole interesse».
E quale può essere stata l’influenza delle agitazioni operaie nel crollo del regime? Gli storici in gran parte sono propensi a considerare la crisi del 25 luglio 1943 originata dallo sbarco alleato in Sicilia e giocata tutta all’interno dei palazzi del potere, tra monarchia, fascismo, dissidenza fascista.
Nulla da dire, ovviamente, sulla prima motivazione, che è ben reale, ma la seconda interpretazione riflette una visione un po’ angusta ed anche superficiale. Non c’è dubbio che sull’atteggiamento di un Vittorio Emanuele III molto recalcitrante ad intervenire abbiano influito anche le condizioni del cosiddetto “fronte interno”, cioè lo stato d’animo e il modo di sentire dell’opinione pubblica.
Una conferma indiretta proviene dal diario del generale Paolo Puntoni, osservatore in genere attento e perspicace. L’aiutante di campo del sovrano parla degli scioperi in una sola occasione, il 15 aprile, a proposito della destituzione di Senise da capo della polizia, attribuendola anche alla «debolezza manifestata da Senise nella repressione dei moti operai in Alta Italia ». Puntoni parla di “moti” e non di scioperi e forse il termine da lui usato è il più adeguato a definire l’esplosione popolare del marzo 1943 ed a coglierne la portata in certa misura rivoluzionaria.

Ma in modo esplicito fece riferimento ai fatti di cui ci stiamo occupando il presidente del Consiglio dei ministri Alcide De Gasperi alla Conferenza della pace. L’allora capo del governo italiano, il 10 agosto 1946, a Parigi, in quel memorabile discorso che si apriva con la notazione che tutto, tranne la cortesia personale di chi lo ascoltava, era in quel momento contro di lui e contro il nostro Paese, nel rivendicare il contributo della Resistenza alla sconfitta del nazismo e del fascismo, ebbe a dire: «Ora non v’ha dubbio che il rovesciamento del regime fascista non fu possibile che in seguito agli avvenimenti militari, ma il rivolgimento non sarebbe stato così profondo, se non fosse stato preceduto dalla lunga cospirazione dei patrioti che in Patria e fuori agirono a prezzo di immensi sacrifici, senza l’intervento degli scioperi politici nelle industrie del Nord, senza l’abile azione clandestina degli uomini dell’opposizione parlamentare antifascista … che spinsero al colpo di Stato».
Poco più avanti aggiunse: «… si tratta di tutta la Marina da guerra, di centinaia di migliaia di militari per i servizi di retrovia, del Corpo Italiano di Liberazione, trasformatosi poi nelle divisioni combattenti e … dei partigiani, autori soprattutto dell’insurrezione del Nord. Le perdite nella Resistenza contro i tedeschi, prima e dopo la dichiarazione di guerra, furono di oltre 100 mila tra morti e dispersi, senza contare i militari e civili vittime dei nazisti nei campi di concentramento ed i 50 mila patrioti caduti nella lotta partigiana. Diciotto mesi durò questa seconda guerra, durante i quali i tedeschi indietreggiarono lentamente verso Nord spogliando, devastando, distruggendo quello che gli aerei non avevano abbattuto».
Gli scioperi del ’43 furono chiara premessa ad una maturazione antifascista di larga parte degli italiani e all’inizio della Resistenza.
(“Gli speciali di Patria” da Patria Indipendente n. 3 del 30 marzo 2003)
Pubblicato domenica 5 Aprile 2020
Stampato il 06/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/longform/1943-gli-scioperi-di-marzo-e-aprile/








