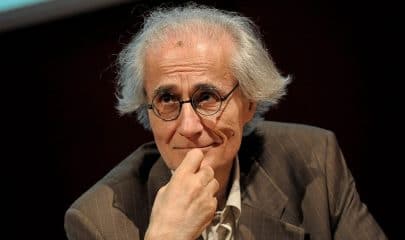Che la rivoluzione non fosse un pranzo di gala, né un ricamo, lo si sapeva già: tuttavia, sarebbe ingenuo negare la capacità della moda di incarnare e, spesso, intercettare i cambiamenti (anche) sociali. Lo si è visto in molteplici occasioni nel corso della storia, con una particolare concentrazione durante il Novecento, attraversato da mode, modi, ondate culturali, musicali e la precisa volontà di rompere con il passato e sovvertire gli stilemi. E questa necessità di travalicare il passato e l’uso comune per veicolare un messaggio, non di rado si è trasformata in una vera e propria scossa tellurica di protesta. Così, diritti civili e politici si sono ritrovati al centro di lotte che, sempre più frequentemente, hanno iniziato a richiedere un elemento capace di rappresentare uniformità e adesione. E cosa meglio di un dress code (ndr: codice di abbigliamento in certi contesti e situazioni, un insieme di regole tacite o espressamente indicate)? Non esattamente quello di una serata di gala, ça va sans dire, ma un capo d’abbigliamento o un colore capaci di rendere immediatamente visibile e riconoscibile la contestazione.
Che la rivoluzione non fosse un pranzo di gala, né un ricamo, lo si sapeva già: tuttavia, sarebbe ingenuo negare la capacità della moda di incarnare e, spesso, intercettare i cambiamenti (anche) sociali. Lo si è visto in molteplici occasioni nel corso della storia, con una particolare concentrazione durante il Novecento, attraversato da mode, modi, ondate culturali, musicali e la precisa volontà di rompere con il passato e sovvertire gli stilemi. E questa necessità di travalicare il passato e l’uso comune per veicolare un messaggio, non di rado si è trasformata in una vera e propria scossa tellurica di protesta. Così, diritti civili e politici si sono ritrovati al centro di lotte che, sempre più frequentemente, hanno iniziato a richiedere un elemento capace di rappresentare uniformità e adesione. E cosa meglio di un dress code (ndr: codice di abbigliamento in certi contesti e situazioni, un insieme di regole tacite o espressamente indicate)? Non esattamente quello di una serata di gala, ça va sans dire, ma un capo d’abbigliamento o un colore capaci di rendere immediatamente visibile e riconoscibile la contestazione.

Uno degli esempi più recenti è rappresentato dai gilet gialli, il movimento di protesta nato in Francia a fine del 2018 e diffusosi a macchia d’olio per protestare contro l’aumento del prezzo del carburante. Negli ultimi mesi, venuta meno la dialettica con gli organi istituzionali e, soprattutto, evidenziatasi l’assenza di coesione, l’eco delle proteste pare essersi spenta, ma il simbolo scelto – il gilet catarifrangente – resta come drappo listato a lutto, sacrificato sull’altare di una totale assenza programmatica. Tuttavia, sarebbe inutile negare quelle leve che hanno decretato la rapida diffusione e memorizzazione, tanto del movimento, quanto del suo simbolo. Innanzitutto, la scelta di un oggetto comune, economico, il cui possesso è imposto per legge a tutti gli automobilisti rappresenta l’architrave su cui poggia l’idea popolare (o populista?) di un movimento che abbraccia tutti. In pratica, un partito dell’uomo comune in piena regola, con addosso un colore sgargiante, evidente, capace di rimanere impresso nella memoria e di evocare, attraverso un’associazione mentale piuttosto elementare, l’identità e la comunanza. E così, come due specchi posti l’uno di fronte all’altro e che si riflettono all’infinito, proponendo centinaia di volte la stessa immagine, così l’effetto domino dei… neuroni specchio dei gilet gialli fa altrettanto, dicendo quasi “Sono un automobilista. Se incontro un altro automobilista, non posso che trovare un mio simile”, volendo parafrasare in modo approssimativo il Terenzio dell’Heautontimorùmenos.
 Questa dei gilet gialli risulta essere solo una delle fasi più recenti nella storia articolata del potere muto dell’abbigliamento, ma per risalire a quell’episodio primordiale e identificativo che cuce insieme proteste e abbigliamento, bisogna volgere lo sguardo sempre Oltralpe, ma sul finire del XVIII secolo, alla Francia rivoluzionaria. La corrente dei sanculotti altro non fece che traslare la propria ferrea volontà di rottura con l’Ancien Régime su un capo di abbigliamento: i pantaloni. Gli ideali erano già esplicitati nel nome, summa del rifiuto delle convenzioni: i sans culottes non indossavano quei pantaloni al ginocchio emblema di un retaggio nobiliare e alto-borghese e, insieme, segno distintivo di ciò che era da combattere. Così, gli uomini iniziarono a tagliare i capelli e a portarli del proprio colore naturale e i decori militari videro il loro declino: ma, nonostante una innegabile maggiore libertà generalmente diffusa, la Rivoluzione ritenne opportuno individuare un proprio codice estetico che racchiuse nel dipinto di Louis Léopold Boilly, “Ritratto dell’attore Chenard come sanculotto”.
Questa dei gilet gialli risulta essere solo una delle fasi più recenti nella storia articolata del potere muto dell’abbigliamento, ma per risalire a quell’episodio primordiale e identificativo che cuce insieme proteste e abbigliamento, bisogna volgere lo sguardo sempre Oltralpe, ma sul finire del XVIII secolo, alla Francia rivoluzionaria. La corrente dei sanculotti altro non fece che traslare la propria ferrea volontà di rottura con l’Ancien Régime su un capo di abbigliamento: i pantaloni. Gli ideali erano già esplicitati nel nome, summa del rifiuto delle convenzioni: i sans culottes non indossavano quei pantaloni al ginocchio emblema di un retaggio nobiliare e alto-borghese e, insieme, segno distintivo di ciò che era da combattere. Così, gli uomini iniziarono a tagliare i capelli e a portarli del proprio colore naturale e i decori militari videro il loro declino: ma, nonostante una innegabile maggiore libertà generalmente diffusa, la Rivoluzione ritenne opportuno individuare un proprio codice estetico che racchiuse nel dipinto di Louis Léopold Boilly, “Ritratto dell’attore Chenard come sanculotto”.

Uno stile che dimostrava grande empatia verso le classi sociali meno abbienti e i nuovi attori politici, e che, al tempo stesso, rappresentava una posizione politica esplicita tanto quanto la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino. I sanculotti resero le scelte estetiche anche etiche, associando a ciascun elemento e colore un significato politico ben preciso: trassero grande ispirazione dall’abbigliamento dei lavoratori, al punto da individuare la propria divisa che si componeva di una giacca corta, un berretto con coccarda tricolore, un gilet – dei colori della rivoluzione, in contrapposizione a quello giallo, indossato (sic!) dei monarchici -, i pantaloni lunghi sostenuti da bretelle, ormai emblema dell’uomo del popolo e i tradizionali zoccoli da contadino. Le fibbie e i ricami, ormai banditi in quanto orpelli monarchici, cedettero il passo a semplici nastri, cordoni e fazzoletti al collo.
Individuati i prodromi che annodano e inchiodano proteste e abbigliamento, la situazione diventò molto più sfaccettata nel corso dei decenni, per arrivare alla fine del XX secolo, quando si iniziò ad assistere all’emergere dei primi gruppi di sensibilizzazione alle tematiche Lgbt (e dei suoi successivi riverberi Lgbt+ e Lgbtiq).
 Un movimento che, al momento della sua nascita, puntò molto sullo shock visivo per creare un effetto dissonante e aprire il dibattito sull’acquisizione dei diritti civili per le coppie omosessuali, accompagnandosi ai colori dell’arcobaleno impressi sulla rainbow flag, appunto. Come ogni bandiera che si rispetti, quella concepita a San Francisco nel 1978 da Gilbert Baker, racchiude tutti i capisaldi Lgbt, con un’incursione nella sfera spirituale e new age. Da quel momento, la sequenza di colori scelta da Baker (ad eccezione di due che, difficilmente reperibili, vennero eliminati dalla bandiera che arrivò così a sei bande colorate) diventò il marchio di fabbrica delle proteste per i diritti omosessuali e, dalla California, si diffuse molto rapidamente in ogni parte del mondo. Allora, perché considerarla una “divisa”? Semplice: perché non può essere unicamente intesa come una bandiera. Non viene issata, né calata con fare solenne durante le cerimonie ufficiali ma è, da sempre, parte integrante delle manifestazioni e dei manifestanti stessi. Viene indossata, sfoggiata, esibita e diventa materia viva, non un ambasciatore formale e inerte.
Un movimento che, al momento della sua nascita, puntò molto sullo shock visivo per creare un effetto dissonante e aprire il dibattito sull’acquisizione dei diritti civili per le coppie omosessuali, accompagnandosi ai colori dell’arcobaleno impressi sulla rainbow flag, appunto. Come ogni bandiera che si rispetti, quella concepita a San Francisco nel 1978 da Gilbert Baker, racchiude tutti i capisaldi Lgbt, con un’incursione nella sfera spirituale e new age. Da quel momento, la sequenza di colori scelta da Baker (ad eccezione di due che, difficilmente reperibili, vennero eliminati dalla bandiera che arrivò così a sei bande colorate) diventò il marchio di fabbrica delle proteste per i diritti omosessuali e, dalla California, si diffuse molto rapidamente in ogni parte del mondo. Allora, perché considerarla una “divisa”? Semplice: perché non può essere unicamente intesa come una bandiera. Non viene issata, né calata con fare solenne durante le cerimonie ufficiali ma è, da sempre, parte integrante delle manifestazioni e dei manifestanti stessi. Viene indossata, sfoggiata, esibita e diventa materia viva, non un ambasciatore formale e inerte.
Distinguersi è, in qualsiasi caso, la prerogativa di tutti i movimenti di protesta, sia che si tratti di minoranza, sia che si stia parlando di un’adesione a un sentire comune e molto diffuso. Lo dimostrano alcuni tra i più noti episodi, riconducibili, in modo particolare, alla condizione femminile: un abisso che spazia dalle proteste per il diritto di voto in Europa alle discriminazioni di genere e che, percorrendo i secoli, porta con sé colori diversi. Se a inizi Novecento era il bianco il colore identificativo e, insieme, provocatorio della prima generazione di suffragette che ostentava un colore intrinsecamente legato alla purezza, alla verginità e a numerosi concetti e precetti religiosi, i primi vent’anni del XXI secolo, invece, hanno individuato una varietà cromatica più ampia.
 Grande risonanza ha avuto lo sciopero femminista dello scorso 14 giugno in Svizzera, in cui le donne hanno reclamato un trattamento equo sul posto di lavoro e una retribuzione pari a quella dei colleghi uomini. La protesta – un evento più unico che raro, visto che non si vedeva uno sciopero in Svizzera dal 1991, proprio il 14 giugno – ha portato con sé un tratto distintivo, un colore che desse la possibilità ai partecipanti (uomini o donne che decidevano di aderire alla causa) di rendersi immediatamente riconoscibili: il viola. Un colore che cela una profondità interpretativa non indifferente: ereditato dalla seconda generazione di femministe degli anni Sessanta e Settanta, appartenenti al Mlf, Mouvement de libération des femmes, nei decenni successivi è passato a rappresentare la condizione dei migranti e, più in generale, le discriminazioni subite dalle minoranze, sulla falsariga del film di Steven Spielberg del 1985, “Il colore viola”, appunto. E se, durante lo sciopero del 1991, in Svizzera si diffuse molto l’alternativa fucsia come colore di adesione alla protesta per via delle mode del periodo, che vedevano una maggiore diffusione e una più facile reperibilità di quella nuance, oggi la scelta del viola ha un significato ben preciso. Si ottiene mescolando rosa e blu, i due colori archetipici della distinzione di gender: e la loro fusione altro non è che l’auspicabile superamento dei ruoli e delle differenze tra donne e uomini.
Grande risonanza ha avuto lo sciopero femminista dello scorso 14 giugno in Svizzera, in cui le donne hanno reclamato un trattamento equo sul posto di lavoro e una retribuzione pari a quella dei colleghi uomini. La protesta – un evento più unico che raro, visto che non si vedeva uno sciopero in Svizzera dal 1991, proprio il 14 giugno – ha portato con sé un tratto distintivo, un colore che desse la possibilità ai partecipanti (uomini o donne che decidevano di aderire alla causa) di rendersi immediatamente riconoscibili: il viola. Un colore che cela una profondità interpretativa non indifferente: ereditato dalla seconda generazione di femministe degli anni Sessanta e Settanta, appartenenti al Mlf, Mouvement de libération des femmes, nei decenni successivi è passato a rappresentare la condizione dei migranti e, più in generale, le discriminazioni subite dalle minoranze, sulla falsariga del film di Steven Spielberg del 1985, “Il colore viola”, appunto. E se, durante lo sciopero del 1991, in Svizzera si diffuse molto l’alternativa fucsia come colore di adesione alla protesta per via delle mode del periodo, che vedevano una maggiore diffusione e una più facile reperibilità di quella nuance, oggi la scelta del viola ha un significato ben preciso. Si ottiene mescolando rosa e blu, i due colori archetipici della distinzione di gender: e la loro fusione altro non è che l’auspicabile superamento dei ruoli e delle differenze tra donne e uomini.

Ma le interpretazioni e le valenze dei colori legati alle proteste, in modo particolare dei movimenti femminili e femministi, è una materia molto complessa (soprattutto perché si rivela essere in continua evoluzione) che può far percorrere strade molto diverse, per perseguire un unico fine. Infatti, se la Svizzera si tinge di viola sull’onda della parità di genere, qualche anno fa, gli Stati Uniti dell’allora neoeletto Trump optarono per un’altra nuance: il fucsia. Questo colore sgargiante, legato quasi unicamente al guardaroba femminile (se non addirittura infantile) fece da sfondo alle pussyhats, le manifestanti che protestavano a gran voce contro il presidente e le sue dichiarazioni misogine indossando dei cappelli realizzati all’uncinetto con delle orecchie da gattina. La necessità – appare evidente – era proprio quella di provocare, facendo riferimento al colore delle Barbie e a quell’appellativo molto volgare (pussy, appunto) che Trump aveva più volte utilizzato nel tempo durante i suoi dibattiti televisi e discorsi pubblici. E se la Women’s March tinse di fucsia le strade e inondò le città di manifestanti il giorno dopo l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, la Hollywood degli scandali dell’epoca Weinstein indossò, invece, due colori stendhaliani: il rosso e il nero. Il movimento #metoo, infatti, dapprima allineato al colore rosso contro le discriminazioni di genere, virò, poi, verso il nero, che diventò il protagonista dell’edizione 2018 dei Golden Globe, quando un numero molto alto di attrici partecipò indossando abiti neri, non per semplice eleganza da serata di gala, ma per la precisa intenzione di uniformarsi e inviare un messaggio coeso a sostegno delle vittime di molestie e abusi. Del resto, quell’edizione vide le donne protagoniste anche al momento delle premiazioni: una su tutte, Frances McDormand a cui andò il riconoscimento come migliore attrice per il ruolo molto forte interpretato in “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”. Come già intravisto con le neofemministe di #metoo, la lotta alle discriminazioni e alle violenze di genere si è arricchita di un altro, inequivocabile, colore: il rosso.

La sua valenza civile in relazione alla condizione della donna è emersa nel 2009, quando l’artista messicana Elina Chauvet realizzò l’opera “Zapatos Rojos”, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del femminicidio e lo fece con un’installazione di forte impatto visivo, in cui decine di paia di scarpe rosse femminili si posizionavano ordinatamente nelle strade e nelle piazze, stagliandosi come lapidi in memoria di troppe vittime inghiottite dal silenzio. L’opera ebbe così tanta risonanza al punto da essere scelta come simbolo della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1999) ed eleggere il rosso come colore-simbolo, così come accaduto lo scorso anno con l’iniziativa “Non è normale che sia normale”, protesta contro la violenza sulle donne trainata da un tratto di rossetto sotto l’occhio.
Ma la grande eloquenza del rosso, è evidente, non può vedere questo colore vincolato a un unico movimento. Il 7 luglio dello scorso anno diventò protagonista, sotto forma di t-shirt, della protesta promossa dall’associazione Libera, dall’Anpi e dall’Arci – contro tutte le mafie per criticare le politiche del governo nei confronti delle rotte migratorie e delle stragi del Mediterraneo. Il rosso rappresentava l’invito a fermarsi – proprio come davanti a un semaforo – per riflettere sulla situazione umana e umanitaria, sulle politiche adottate dalle nazioni che sembrano andare a braccetto con la disumanità dei trafficanti. Ma non solo: la scelta di una maglietta rossa era legata proprio alla similitudine con una delle vittime-icone delle stragi del Mediterraneo degli ultimi anni, Aylan Kurdî, il bambino siriano di due anni giunto, nel 2015, senza vita sulla spiaggia di Bodrum, in Turchia. Del resto, la scelta delle madri di vestire i figli di rosso prima di imbarcarsi è una pratica tristemente comune, per far sì che siano più visibili sui gommoni durante le traversate dell’ignoto.
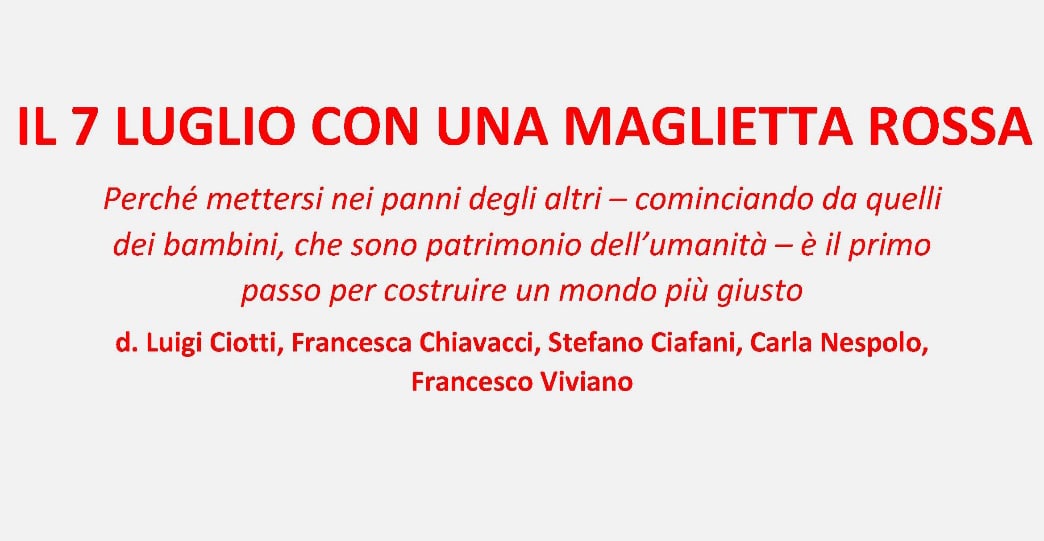 Le proteste, si è visto, sono diverse per genesi, modalità di attuazione, periodo di nascita e area di diffusione: sono diverse le ragioni che le animano – diritti civili, politici, talvolta anche diritti inalienabili (o che almeno ci si aspetta siano tali). Nonostante molte delle proteste che hanno caratterizzato – e che, con buona possibilità di approssimazione, caratterizzeranno – i decenni non abbiano quasi affatto punti di contatto tra di loro, sono tutte accomunate dall’utilizzo di alcuni canoni estetici come elemento aggregante: un colore o un capo d’abbigliamento, da quelli di utilizzo quotidiano a quelli molto eccentrici. Per quella funzione denotativa, innanzitutto, che porta a riconoscere e riconoscersi immediatamente come accomunati dallo stesso obiettivo, esplorando la forte valenza identitaria presente tanto nell’abbigliamento, quanto nella politica (intesa non come schieramento precostituito, ma come coscienza e consapevolezza in merito a determinati temi). Ma, allo stesso tempo, per quel meccanismo che delega al colore o al capo di vestiario una forza trainante all’interno di ciascun movimento, poiché è spesso sgargiante, riconoscibile, memorizzabile e, soprattutto, facilmente riconducibile a valori e stati d’animo fondativi delle singole proteste, ma condivisi da tutti.
Le proteste, si è visto, sono diverse per genesi, modalità di attuazione, periodo di nascita e area di diffusione: sono diverse le ragioni che le animano – diritti civili, politici, talvolta anche diritti inalienabili (o che almeno ci si aspetta siano tali). Nonostante molte delle proteste che hanno caratterizzato – e che, con buona possibilità di approssimazione, caratterizzeranno – i decenni non abbiano quasi affatto punti di contatto tra di loro, sono tutte accomunate dall’utilizzo di alcuni canoni estetici come elemento aggregante: un colore o un capo d’abbigliamento, da quelli di utilizzo quotidiano a quelli molto eccentrici. Per quella funzione denotativa, innanzitutto, che porta a riconoscere e riconoscersi immediatamente come accomunati dallo stesso obiettivo, esplorando la forte valenza identitaria presente tanto nell’abbigliamento, quanto nella politica (intesa non come schieramento precostituito, ma come coscienza e consapevolezza in merito a determinati temi). Ma, allo stesso tempo, per quel meccanismo che delega al colore o al capo di vestiario una forza trainante all’interno di ciascun movimento, poiché è spesso sgargiante, riconoscibile, memorizzabile e, soprattutto, facilmente riconducibile a valori e stati d’animo fondativi delle singole proteste, ma condivisi da tutti.
Letizia Annamaria Dabramo
Pubblicato venerdì 12 Luglio 2019
Stampato il 14/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/primo-piano/quando-ago-e-filo-cambiano-il-mondo/