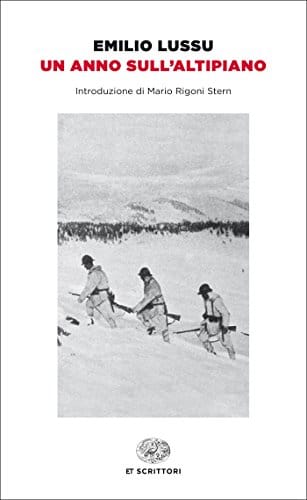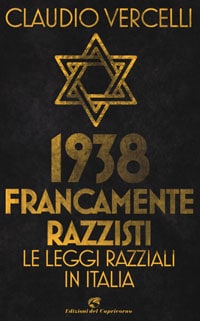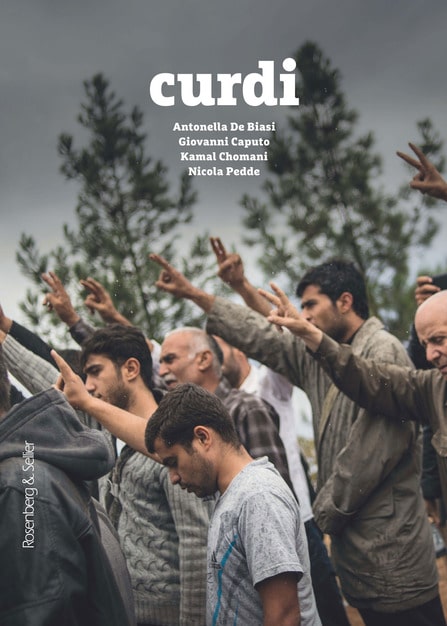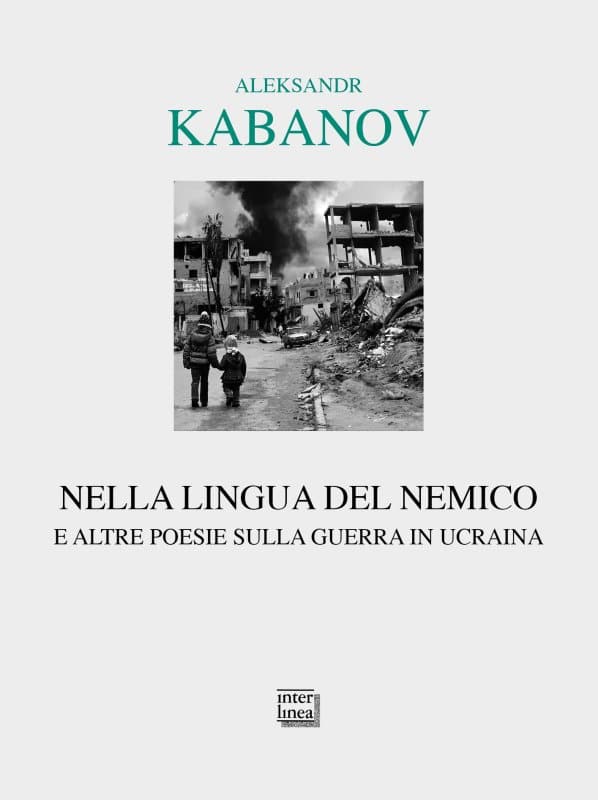 “Io scrivo versi invece di sbronzarmi,
“Io scrivo versi invece di sbronzarmi,
ma alla vita in pace no non dico,
nell’Ucraina credo, no alla guerra,
e aiuto i nostri, faccio quel che posso”.
Sono tra i versi di ‘Una poesia recente’ la lirica che, scritta il 26 giugno 2022, chiude la plaquette “Nella lingua del nemico” di Aleksandr Michajlovic Kabanov, ora tradotta in italiano, con cura e attenzione, da Alessandro Achilli per i tipi di Interlinea.
Una prima volta in italiano per un poeta ucraino di madre lingua russa che, oltre a essere un editore e un traduttore, è soprattutto un attivista politico e civile: quindici le antologie pubblicate e tradotte in molte lingue fino ad oggi. Molti i premi illustri, tra i quali, nel 2010, il premio internazionale “Antologia” per i suoi meriti nella poesia di lingua russa.
 Anche l’occasione per questa traduzione in italiano arriva dal conferimento di un Premio: il XVIII Festival internazionale di Poesia Civile città di Vercelli, ammesso alla UNESCO’s World Poetry Directory, gli conferisce il 27 ottobre scorso il premio alla carriera e, come sempre accaduto con i poeti precedentemente premiati – Luciano Erba, Juan Gelman, Evgenij Evtushenko, Adonis, Titos Patrikios, Alda Merini (in memoria), Maria Luisa Spaziani, Ryszard Krynicki, Lambert Schlechter, Tony Harrison, Márcia Theóphilo, Katherine Larson, Faraj Bayrakdar, Giampiero Neri, Adam Zagajewski, Jesper Svenbro, Maurizio Cucchi – pubblica la sua speciale plaquette di inediti lirici che, espressamente pensati dal poeta per il Festival, viene edita da Interlinea nella collana ‘Lyra’ diretta da Roberto Cicala.
Anche l’occasione per questa traduzione in italiano arriva dal conferimento di un Premio: il XVIII Festival internazionale di Poesia Civile città di Vercelli, ammesso alla UNESCO’s World Poetry Directory, gli conferisce il 27 ottobre scorso il premio alla carriera e, come sempre accaduto con i poeti precedentemente premiati – Luciano Erba, Juan Gelman, Evgenij Evtushenko, Adonis, Titos Patrikios, Alda Merini (in memoria), Maria Luisa Spaziani, Ryszard Krynicki, Lambert Schlechter, Tony Harrison, Márcia Theóphilo, Katherine Larson, Faraj Bayrakdar, Giampiero Neri, Adam Zagajewski, Jesper Svenbro, Maurizio Cucchi – pubblica la sua speciale plaquette di inediti lirici che, espressamente pensati dal poeta per il Festival, viene edita da Interlinea nella collana ‘Lyra’ diretta da Roberto Cicala.

Toccante e fortemente educativo l’incontro che il poeta ha avuto in streaming con alcuni studenti dei licei vercellesi Lagrangia e Avogardo. In diretta Zoom la guerra si è materializzata nella pace di una mattinata a scuola: mentre i ragazzi e il poeta dialogavano come amici di sempre, il terribile risuonare degli allarmi su Kiev e le vicine bombe sulle centrali elettriche, che hanno spesso interrotto la linea telefonica, hanno materializzato nell’aria l’idea stessa di pericolo, guerra, distruzione descritta nelle liriche. Una lezione di vita indimenticabile per chi vi ha assistito. Merce rara, i poeti vivi, a scuola, dove troppo spesso si associa l’arte all’antico e si dimentica il presente. Di questo nostro tragico presente storico Kabanov è testimone umano e lirico e mai come ora la sua poesia si fa pungente e cogente.
E mai come ora la frattura tra la cultura russa e quella ucraina sembra una delle inevitabili conseguenze di un conflitto che sembra non avere fine.
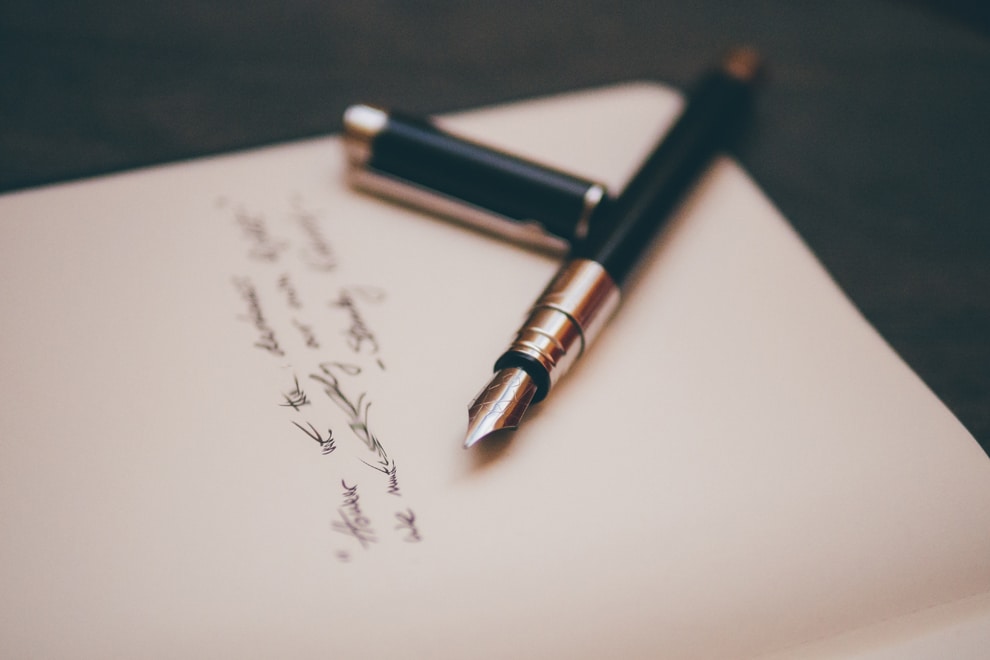 “Mi hanno chiesto di scrivere qualche parola su di me in quanto autore di questo libro – la mia prima raccolta in traduzione italiana. Scrivendo queste parole provo due cose. La prima è un sentimento di gioia per il fatto che le mie poesie verranno lette nella lingua di un Paese che amo da molto tempo, che sognavo di visitare già quand’ero bambino, quando la mia generazione viveva sotto il totalitarismo dell’Unione Sovietica, e lasciare il Paese era impossibile. (…) Il secondo sentimento che provo è quello del dolore per la mia patria, l’Ucraina. Perché mentre scrivo queste righe l’esercito russo sta bombardando le città del mio Paese, uccidendo i suoi cittadini e devastando tutto ciò che incontra, tutto ciò che per ogni ucraino è vicino e importante. Al dolore si somma la repulsione verso l’aggressore, l’assassino del mio popolo. Inoltre, questi assassini pensano, leggono, parlano e ordinano di distruggere cose per me sacre nella mia lingua madre, il russo. La lingua dei miei genitori, la lingua in cui scrivo le mie poesie e in cui mi rivolgo anche al lettore italiano che la conosce. Perché questo libro è bilingue, italiano e russo’’: è con queste parole tanto chiare quanto struggenti che Kabanov introduce, nella ‘Nota al lettore’ in apertura, il tema centrale della sua poetica.
“Mi hanno chiesto di scrivere qualche parola su di me in quanto autore di questo libro – la mia prima raccolta in traduzione italiana. Scrivendo queste parole provo due cose. La prima è un sentimento di gioia per il fatto che le mie poesie verranno lette nella lingua di un Paese che amo da molto tempo, che sognavo di visitare già quand’ero bambino, quando la mia generazione viveva sotto il totalitarismo dell’Unione Sovietica, e lasciare il Paese era impossibile. (…) Il secondo sentimento che provo è quello del dolore per la mia patria, l’Ucraina. Perché mentre scrivo queste righe l’esercito russo sta bombardando le città del mio Paese, uccidendo i suoi cittadini e devastando tutto ciò che incontra, tutto ciò che per ogni ucraino è vicino e importante. Al dolore si somma la repulsione verso l’aggressore, l’assassino del mio popolo. Inoltre, questi assassini pensano, leggono, parlano e ordinano di distruggere cose per me sacre nella mia lingua madre, il russo. La lingua dei miei genitori, la lingua in cui scrivo le mie poesie e in cui mi rivolgo anche al lettore italiano che la conosce. Perché questo libro è bilingue, italiano e russo’’: è con queste parole tanto chiare quanto struggenti che Kabanov introduce, nella ‘Nota al lettore’ in apertura, il tema centrale della sua poetica.
L’amata lingua russa, la lingua del primo pensiero, del latte materno, della musicalità del suo verso fin dalle origini, è ora la lingua del nemico.

Possono le lingue degli uomini caricarsi sulle spalle il peso delle azioni di chi le parla? Possono essere, le parole, la causa di tanti delitti, crimini e misfatti? Ancora il poeta ci aiuta a capire: “Ora in Ucraina si cerca di dare al russo lo status di lingua nemica, di lingua del nemico. E proprio così, infatti, si chiama il libro che state leggendo, Nella lingua del nemico. Alcuni di questi versi li ho scritti decenni prima della guerra russo-ucraina, altri sono molto recenti. Parlano tutti della guerra, dell’amore e del mondo che verrà, un mondo in cui finalmente le persone capiranno una volta per tutte che una lingua, a qualsiasi cultura o nazione appartenga, non è mai colpevole. La colpa è sempre delle persone, dei parlanti di quella lingua. E quelle persone hanno dei nomi e dei cognomi ben precisi”.
 Eccole, le parole poetiche di Kabanov, talmente chiare da illuminare la notte di tenebra. Eccole nella lirica K.A., non a caso le sue iniziali, manifesto poetico dell’intera raccolta.
Eccole, le parole poetiche di Kabanov, talmente chiare da illuminare la notte di tenebra. Eccole nella lirica K.A., non a caso le sue iniziali, manifesto poetico dell’intera raccolta.
Sognavo di morire,
son morto e ho fatto un sogno:
qualcuno piange al vento,
un cuore si è fermato.
Le rive tu hai confuso,
come due corde marce:
la lingua del nemico
impara e taci in russo.
Di paglia è questo fuoco,
il sole all’orizzonte:
la lingua del nemico
impara e statti zitto.
Da bravo l’ho studiata
perché ne faccio parte,
si arrabbiano i ceceni,
arrivano i buriati.
Ed ecco Ilovajs’k,
paesaggio di rovine:
la lingua del nemico,
morir per l’Ucraina.

Aleksanrd Kabanov è un poeta ‘civile’, un soldato armato di sole parole. Parole come scelta, suono, segno e fierezza. Gesto di solidale civiltà sempre e comunque, la poesia civile, in ogni sua forma, fiaba, poema o leggenda, concretizza il bisogno umano di dichiarare, denunciare, condividere. Strada di difficile percorrenza, genere che fa della libertà del canto, della musicalità di versi e parole, strumento di impegno, lotta, consapevolezza e, appunto, condividere.
Invisa ai tiranni, amata dagli eroi, talmente efficace da obbligare dittatori di tutti i luoghi e di tutti i tempi, e soprattutto in guerra, a imbavagliare menti, mani e cuori: ecco prigioni, esilii, torture e condanne per chi osa alzare la testa dal silenzio.
Oggi come ieri. Come domani, si teme.
La poesia, lo sappiamo, la colpa
ce l’ha. Se ne va in giro losca,
le tasche senza fondo, è sacra
come un tempio e timore non ha.
Lei deve, lei deve, e cieca si dà,
ma poi dell’uomo che cosa rimane?
Un vagoncino, un piccolo carretto,
e tra le gambe una chiavetta circoncisa.
Che sia una piaga o un’onorificenza,
io vivo solo e fretta non ne ho.
D’autunno ho voglia di sfogliare Puškin:
e che ci posso fare, è un africano.
Non ce l’ho fatta, mi sono vestito
con le pellicce calde e le otri vecchie,
che maledetto sia chi ha dubitato
e chi ha affermato che io – scrivo versi.
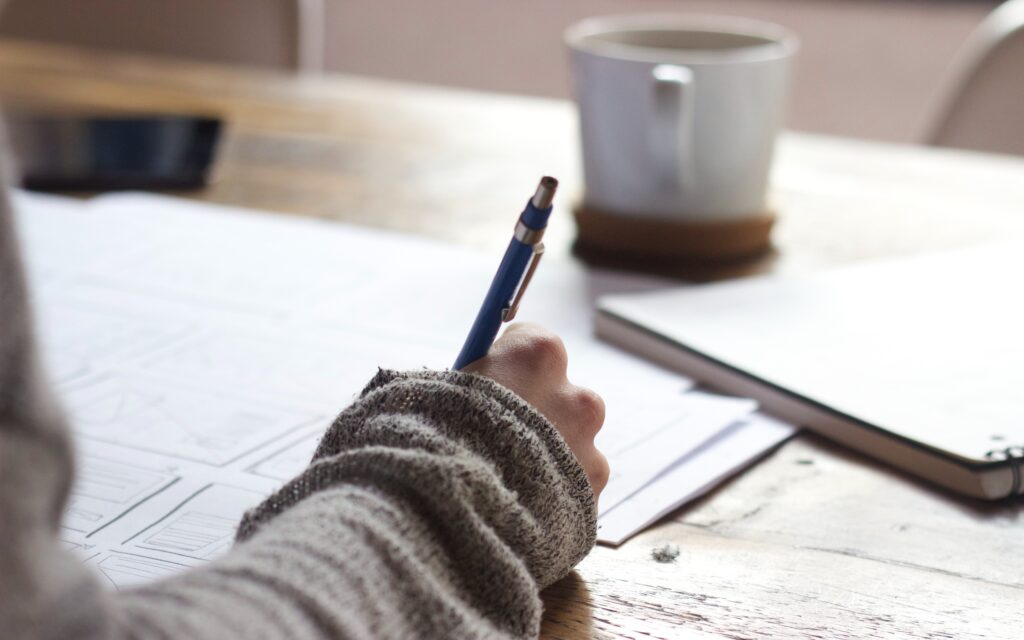 ‘Scrivo versi’: tra i miracoli che ancora accadono, l’incontro tra il poeta e il suo traduttore. Se c’è arte complessa, perché di arte si tratta e delle più pure, sta nel riuscire a donare al lettore di altra lingua, tra le mille difficoltà che ciò comporta, non solo gli stessi contenuti ma anche la stessa energia, la forza, la musicalità, la passione del testo originale. Credo che prima di tutto si tratti di magia, dell’incontro tra sinergie che devono scattare tra l’opera originale, e il suo autore, e chi ne deve rendere, fedelmente e al meglio, ma in una lingua differente per suoni, metrica, ritmi e accenti, l’essenza primaria.
‘Scrivo versi’: tra i miracoli che ancora accadono, l’incontro tra il poeta e il suo traduttore. Se c’è arte complessa, perché di arte si tratta e delle più pure, sta nel riuscire a donare al lettore di altra lingua, tra le mille difficoltà che ciò comporta, non solo gli stessi contenuti ma anche la stessa energia, la forza, la musicalità, la passione del testo originale. Credo che prima di tutto si tratti di magia, dell’incontro tra sinergie che devono scattare tra l’opera originale, e il suo autore, e chi ne deve rendere, fedelmente e al meglio, ma in una lingua differente per suoni, metrica, ritmi e accenti, l’essenza primaria.
 E nella prefazione del volumetto scrive Alessandro Achilli, assumendo un ruolo che va ben oltre la pura traduzione: “Per il traduttore, l’inarrestabile vitalità immaginativa della penna di Kabanov, aperta a suggestioni dalla cultura di tutto il mondo ma al contempo decisamente radicata nel contesto ucraino e russofono, significa la necessità di ricercare un equilibrio tra il mondo dell’originale e quello del lettore italiano particolarmente impegnativo da mantenere. Un ruolo decisamente importante nella sua poetica è giocato dalla rima e dall’attaccamento al tradizionale sillabotonismo della poesia slava orientale, basato sul modello tedesco e inglese. Le scelte del traduttore a questo proposito possono essere molteplici. Il mio approccio, più spontaneo che guidato da una decisione teorica antecedente al lavoro concreto con i testi, si è fondato sulla volontà di aderire quanto più possibile all’imagery originale di Kabanov, ancorandola alla versificazione italiana, ma senza rimanerne schiavo”. Sottolinea il traduttore che “l’utopia della scrittura poetica è sempre uno degli strumenti più forti per (cercare di) arginare la violenza della storia”.
E nella prefazione del volumetto scrive Alessandro Achilli, assumendo un ruolo che va ben oltre la pura traduzione: “Per il traduttore, l’inarrestabile vitalità immaginativa della penna di Kabanov, aperta a suggestioni dalla cultura di tutto il mondo ma al contempo decisamente radicata nel contesto ucraino e russofono, significa la necessità di ricercare un equilibrio tra il mondo dell’originale e quello del lettore italiano particolarmente impegnativo da mantenere. Un ruolo decisamente importante nella sua poetica è giocato dalla rima e dall’attaccamento al tradizionale sillabotonismo della poesia slava orientale, basato sul modello tedesco e inglese. Le scelte del traduttore a questo proposito possono essere molteplici. Il mio approccio, più spontaneo che guidato da una decisione teorica antecedente al lavoro concreto con i testi, si è fondato sulla volontà di aderire quanto più possibile all’imagery originale di Kabanov, ancorandola alla versificazione italiana, ma senza rimanerne schiavo”. Sottolinea il traduttore che “l’utopia della scrittura poetica è sempre uno degli strumenti più forti per (cercare di) arginare la violenza della storia”.
 Eccola, la strada. Il poeta può, e deve, con la sua leggerezza solo apparente, con la sua purezza ideologica e la sua potenza simbolica, ‘arginare la violenza della storia’, incanalare il male che ci circonda in modo che nuoccia meno, possa scorrere via, lontano, scivolando sulla pelle della terra.
Eccola, la strada. Il poeta può, e deve, con la sua leggerezza solo apparente, con la sua purezza ideologica e la sua potenza simbolica, ‘arginare la violenza della storia’, incanalare il male che ci circonda in modo che nuoccia meno, possa scorrere via, lontano, scivolando sulla pelle della terra.
E noi, in attesa che torni la giusta pace, non possiamo che saziarci della bellezza di queste liriche che, colme di lacrime e sorrisi, lasciano intravedere un futuro diverso, si spera migliore.
Elisabetta Dellavalle, giornalista, collabora anche con La Stampa
Pubblicato venerdì 24 Febbraio 2023
Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/ce-la-guerra-e-io-scrivo-versi-invece-di-sbronzarmi/