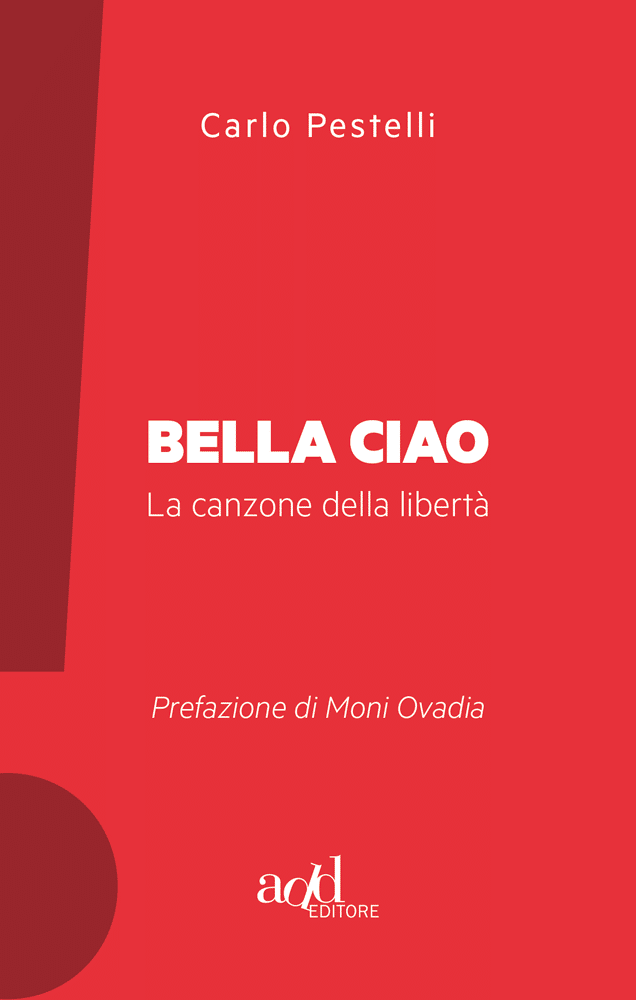Di lui il primo libro che ho letto fu La frontiera scomparsa. Era il 1997, i racconti, magistralmente tradotti dalla sua fedele voce italiana, Ilide Carmignani, erano usciti da un annetto, credo nel luglio del novantasei, e Sepúlveda concorreva per il Bancarella in compagnia di Cathleen Schine, Giampaolo Pansa, Sebastian Faulks, Sergio Astrologo e David Baldacci, che allora era alla sua prima opera, Il potere assoluto, e ancora si faceva chiamare David B. Ford.
Di lui il primo libro che ho letto fu La frontiera scomparsa. Era il 1997, i racconti, magistralmente tradotti dalla sua fedele voce italiana, Ilide Carmignani, erano usciti da un annetto, credo nel luglio del novantasei, e Sepúlveda concorreva per il Bancarella in compagnia di Cathleen Schine, Giampaolo Pansa, Sebastian Faulks, Sergio Astrologo e David Baldacci, che allora era alla sua prima opera, Il potere assoluto, e ancora si faceva chiamare David B. Ford.
Avevo diciotto anni e non ero un attento lettore, così percorsi velocemente le pagine della Frontiera scomparsa più che altro perché c’era in ballo un concorso, collegato al premio Bancarella, sei borse di studio di ottocentomila lire messe in palio dalla Fondazione della Cassa di risparmio di Vercelli per gli studenti delle scuole superiori della provincia che avessero prodotto le migliori recensioni dei sei libri in lizza. Assieme a un compagno di classe ne scrissi una per il volume di Sepúlveda – non vincemmo – e così il 16 maggio mi recai a Biella dove i librai pontremolesi, in collaborazione con la libreria Giovannacci, avrebbero presentato i finalisti, e Sergio Zavoli avrebbe commentato e premiato i vincitori del concorso riservato agli studenti.

Di ciò che avvenne all’interno del Teatro Sociale della città non ricordo un bel niente, nulla di ciò che dissero gli organizzatori né di quanto uscì dalla bocca degli scrittori. Probabilmente fu un pomeriggio uggioso e quando tutto finì c’era una gran calca sotto i portici del teatro, gente che temporeggiava in attesa che gli autori uscissero, qualcuno che si era infilato al bar, altri che facevano quattro chiacchiere.
Sepúlveda si mischiò lì in mezzo e appena poté accese una sigaretta. Le persone gli si avvicinavano per un autografo col libro già aperto alla pagina del frontespizio. Io avevo la mia copia e mi misi in fila. Ma quando fu il mio turno, invece di allungargli il libro, gli dissi: Non voglio l’autografo. Però mi piacerebbe avere una sua sigaretta. Credo che lui, a quel punto, avesse sorriso, e poi cacciò la mano nella tasca della giacca, prese il pacchetto – se non ricordo male era uno di quelli morbidi – e ci batté con le dita per farne uscire una. Io dissi grazie, e me ne andai.

Fu un atteggiamento stupido, il mio, forse anche presuntuoso; un piglio da tardoadolescente desideroso di farsi notare con modi che credevo di schietta originalità riuscendo invece strampalati. Un errore, insomma, anche e soprattutto perché il libro di Sepúlveda l’avevo scorso davvero superficialmente. Tanto che ieri, riprendendolo in mano (e mi riprometto di leggere anche i tanti altri titoli che di lui mi mancano), ho realizzato che non ricordavo nulla. Perciò, seduto in poltrona, mi sono immerso tra i fogli ingialliti. E ora vorrei dire quanto quelle storie – che da più di vent’anni non frequentavo – mi abbiano magneticamente incollato alla pagina. Forse non è uno dei suoi libri più celebri ma sa narrare in maniera leggera e precisa la militanza politica, sul filo di un’autobiografia che rende l’esistenza dell’uomo Sepúlveda così picarescamente vivida da parere uscita da un dipinto di Mario Tapia Radic.
Bellissimo è il racconto d’apertura, intitolato Un viaggio da nessuna parte. “Il biglietto per andare da nessuna parte fu un regalo di mio nonno”. Ecco le radici, quelle famigliari, quelle culturali, quelle politiche, farsi avanti tra le righe. Il nonno era un tipo bizzarro e terribile, un mozzicone di sigaro perennemente penzolante tra le labbra e la smania di fare del piccolo Luis un uomo libero. Di domenica gli riempiva la pancia con mezze dozzine di gassose e altrettanti gelati per poi portarlo a pisciare sulla porta di una chiesa, “piccolo complice delle sue bricconate di anarchico in pensione”. Finché accadde che il prete, stufo di trovare il sagrato cambiato in latrina, si mise di guardia e attese di coglierli in flagrante. Sono pagine di una spavalda ironia, colme di voglia di vivere. “La domenica precedente mi ero alleggerito la vescica contro la porta centenaria della chiesa di San Marcos. Non era la prima volta che le vetuste assi mi servivano da vespasiano, ma quel giorno evidentemente il prete era all’erta, perché mi sorprese nel momento migliore della pisciata, quando ormai è impossibile trattenere il getto, e tirandomi per un braccio mi obbligò a girarmi verso il nonno. Poi, indicando il mio pisello zampillante con un dito profetico, il prete sbraitò: «Si vede che è tuo nipote! Si nota la piccolezza della vostra razza!»”.

D’accordo: il nonno non era uno stinco di santo ma ciò che voleva trasmettere al nipote era un invito. L’invito a intraprendere un grande viaggio. Quale? Quello che non ti porta da nessuna parte. Già, detta così sembra la stupida sentenza di un vecchio suonato, ma in realtà credo sia una di quelle frasi che meglio riassumono l’intera opera di Sepúlveda, assieme ai tanti fili colorati che intrecciano la storia della sua straordinaria vita. Una vita rocambolesca, come ce ne sono poche tra quelle degli scrittori ancora viventi (e basterebbero a renderla straordinaria le disavventure vissute nelle carceri di Pinochet; e poi le fughe, i viaggi da un capo all’altro dell’America latina sulle tracce del Che – e non solo –, e più tardi sulle navi di Greenpeace).
Ecco dunque il suo straordinario modo di guardare le cose splendidamente esemplato in queste pagine ripassate or ora. Leggo: “Una nota canzone cilena dice: due estremi ha la strada e a tutte e due qualcuno mi aspetta. La fregatura è che questi due estremi non delimitano una strada lineare, ma piena di curve, meandri, buche e deviazioni che invariabilmente ti portano da nessuna parte”.
 Perché è essere lungo la via ciò che conta, è continuare a sognare come ha fatto il piccolo Luis da quel giorno in cui il nonno gli mise tra le mani un classico del realismo socialista sovietico, il Come fu temprato l’acciaio di Nicolaj Ostrovskij.
Perché è essere lungo la via ciò che conta, è continuare a sognare come ha fatto il piccolo Luis da quel giorno in cui il nonno gli mise tra le mani un classico del realismo socialista sovietico, il Come fu temprato l’acciaio di Nicolaj Ostrovskij.
Un sogno che è durato settant’anni, che lo ha portato a diventare un militante delle Juventades Comunistas cilene, a correre per il mondo intero, e a raccontare infaticabilmente le storie in eterna trasformazione degli uomini. Il segreto? “Stare in piedi sulla vita”. “Tutti i miei amici d’infanzia avevano rotte ben definite: alcuni sarebbero andati a studiare negli Stati Uniti, altri in Uruguay, altri in Europa, altri sarebbero entrati nel mondo del lavoro. Io aspiravo a non muovermi dal mio posto di combattimento”.
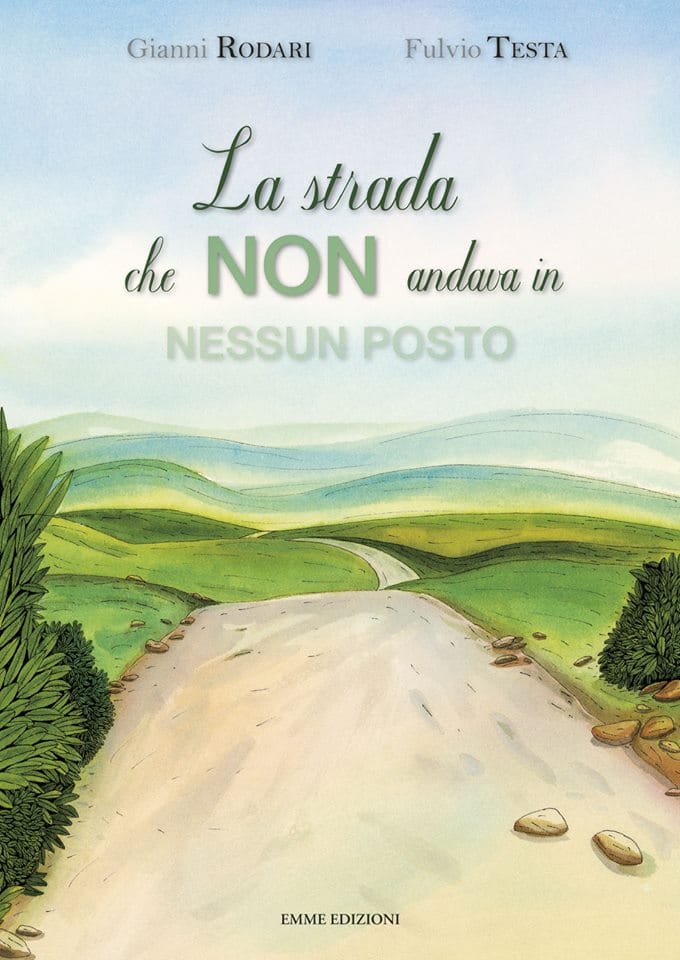 Il che significa, in altre parole, coltivare la tenacia di guardare la via che non porterà da nessuna parte, l’unica che ti consente di essere disponibile a cambiare, a tentare il nuovo, a nutrire la cocciuta speranza che ci sia qualcosa per cui vale la pena combattere, sempre. Così, Sepúlveda anche quando faceva autobiografia parlava con la grammatica della fantasia – sì, sto citando Rodari – perché proprio La frontiera scomparsa mi ha fatto tornare alla mente una fiaba dello scrittore italiano che spesso ho letto assieme ai miei bambini fino a pochi anni fa, La strada che non andava in nessun posto (è del 1962, e chissà se Sepúlveda l’aveva mai letta). Il protagonista, Martino Testadura, è per me un piccolo e tenace Luis: entrambi vedevano ciò che agli occhi degli altri risultava invisibile. Vedevano la multiforme possibilità insita nella vita e nelle storie, quella possibilità che non ha binari assegnati e che non tollera limiti né facili soluzioni. Per questo, più ci penso, più mi pare che la mia plateale richiesta a quel Sepúlveda quasi cinquantenne – prima ancora di aver colto almeno una briciola del significato del suo pensiero – sia stato il gesto acerbo di un ragazzo che non aveva capito la lezione, che aveva troppa fretta di arrivare in fondo senza godersi il viaggio lungo la strada che non ci porta da nessuna parte.
Il che significa, in altre parole, coltivare la tenacia di guardare la via che non porterà da nessuna parte, l’unica che ti consente di essere disponibile a cambiare, a tentare il nuovo, a nutrire la cocciuta speranza che ci sia qualcosa per cui vale la pena combattere, sempre. Così, Sepúlveda anche quando faceva autobiografia parlava con la grammatica della fantasia – sì, sto citando Rodari – perché proprio La frontiera scomparsa mi ha fatto tornare alla mente una fiaba dello scrittore italiano che spesso ho letto assieme ai miei bambini fino a pochi anni fa, La strada che non andava in nessun posto (è del 1962, e chissà se Sepúlveda l’aveva mai letta). Il protagonista, Martino Testadura, è per me un piccolo e tenace Luis: entrambi vedevano ciò che agli occhi degli altri risultava invisibile. Vedevano la multiforme possibilità insita nella vita e nelle storie, quella possibilità che non ha binari assegnati e che non tollera limiti né facili soluzioni. Per questo, più ci penso, più mi pare che la mia plateale richiesta a quel Sepúlveda quasi cinquantenne – prima ancora di aver colto almeno una briciola del significato del suo pensiero – sia stato il gesto acerbo di un ragazzo che non aveva capito la lezione, che aveva troppa fretta di arrivare in fondo senza godersi il viaggio lungo la strada che non ci porta da nessuna parte.
Giacomo Verri, scrittore
Pubblicato domenica 19 Aprile 2020
Stampato il 01/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/cio-che-conta-godersi-il-viaggio/