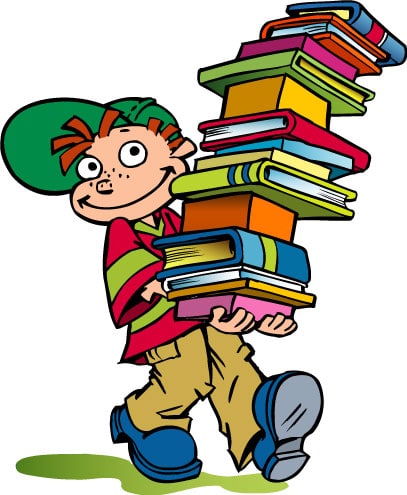
Quarantena, quaresime e voglia di “liberazione”. Sono queste le parole che ci avvolgono, strette, come le mura di casa che poche volte, come oggi, abbiamo sentite premere tanto forte sul nostro desiderio d’affrancamento. Facciamoci dunque accompagnare, in questo frangente difficile, da un pugno di libri che hanno a che fare con la ricerca di un senso, con ciò in cui crediamo o non crediamo, con la sete di salvezza, con la tensione dell’attesa e con la voglia di ricominciare.
Marieke Lucas Rijneveld, Il disagio della sera, trad. di Stefano Musilli, Nutrimenti, pp. 251, € 18
Jas Mulder è una ragazzina olandese. Suo fratello maggiore Matthies è appena morto inghiottito tra le lastre di un ghiaccio insidioso, e nella famiglia di Jas, una stirpe di protestanti riformati che vivono a formaggio, Vangelo e mucche, si apre una voragine che li trascina in un caleidoscopio di immagini, di storie e di fanciullesche inquietudini, parenti del peccato, del dolore e del senso di colpa, e vicine alla caoticità dei quadri di Bosch traslati nella realtà quotidiana di una bambina che vive in una gelida fattoria di campagna.
Un soqquadro dello spirito che trabocca dalla mente bambina di Jas e si riversa sui genitori, sui fratelli e sulle sorelle che vivono tutti come superstiti la loro mancanza di direzione, i loro progetti senza futuro, gli schiaffi di un’esistenza umana – intrinsecamente limitata – e perciò segnata dai limiti di un peccato potenzialmente infinito. Così Jas ci fa paura e tenerezza assieme, scopriamo con lei le naturali malizie della bambina che non si accorge di diventare una piccola adulta ed è abbandonata a se stessa nell’interpretazione delle cose del mondo, della vita, della morte, dell’istinto: «La mia attrazione per i piselli deve essere nata con gli angioletti nudi, quando avevo dieci anni e li toglievo dall’albero di Natale per poi tastare la porcellana fredda tra le loro gambette come un frammento di conchiglia in mezzo alla ghiaia dei polli, e ci mettevo la mano sopra come un ramoscello di vischio, allora per protezione e adesso per un desiderio irresistibile che mi si è annidato soprattutto nel ventre, dove continua a crescere».
Perciò Jas, fino all’epilogo surreale e tragico del romanzo, non vuole più togliersi di dosso il proprio giaccone, perché si sente diversa, vulnerabile ma cattiva, e perché è rimasto solo quell’indumento a spaziarla da tutto e da tutti, in un mondo che va a rotoli, dove i fratelli muoiono o sono crudeli, dove i genitori lavorano come bestie assenti e tristi perché «non si mettono più uno sopra l’altro». E la bambina allora parla coi suoi rospi, parla con loro di Dio e del fango, del padre e della madre, in un dialogo blasfemo e sacro a un tempo, in cu il cuore di tutto è il disagio di ognuno – della sera e non solo – sotto un cielo piatto in cui ormai «fa paurissima guardare in faccia le persone, come se gli occhi degli altri fossero biglie che puoi vincere o perdere».
 Nickolas Butler, Uomini di poca fede, trad. di Fabio Cremonesi, Marsilio, pp. 271, € 17 e-book € 9,90
Nickolas Butler, Uomini di poca fede, trad. di Fabio Cremonesi, Marsilio, pp. 271, € 17 e-book € 9,90
La religione dei pazzi non può guarire tutti, anzi non riesce a guarire nessuno. Lo scopre poco alla volta il vecchio Lyle Hovde, che adora il nipotino Isaac, e, quando può, se lo porta appresso sulle strade del Wisconsis, lungo le rive del Mississippi, al frutteto di Otis dove ancora lavora benché in pensione, e addirittura al piccolo cimitero di duecento tombe di Redford, dove spolvera la lapide del proprio figlio morto a nove mesi e gioca col nipote a nascondino.
Per una vita intera Lyle ha fatto consegne e installazioni di elettrodomestici con l’inseparabile Hoot, che ora non è messo bene, un cancro lo sta divorando e quel vecchio testone non fa altro che fumare e bere birra. Lyle è preoccupato per lui, lo è anche sua moglie Peg, e la coppia di anziani si trova, tutt’a un tratto, ad avere un sacco di grattacapi e a gestire le strane traiettorie prese dalle esistenze delle persone più care, prima fra tutte quella della loro figlia adottiva Shiloh, una ragazza particolare – ormai una donna – la mamma del piccolo Isaac: lei ha quella cosa che non va giù a Lyle, è entrata in uno strano gruppo religioso, di quelli che si riuniscono nei centri commerciali e nei ristoranti falliti, e perdono la testa per i vaneggiamenti di un predicatore.
Il tutto reso ancora più tragico dal fatto che «Lyle non crede in Dio, o per lo meno non è sicuro di crederci» sebbene sia disposto a sentire l’accorata fede nel soprannaturale di un altro essere umano, e sebbene tra gli amici più stretti abbia Charlie, il pastore della chiesa luterana di Redford.
Ma la vera e propria tragedia sboccia quando Lyle si rende conto che la figlia ha intrapreso una storia con Steven, il pastore di quella bizzarra congregazione, e che i due, assieme, si sono convinti che il piccolo Isaac abbia improbabili doti taumaturgiche. È un meccanismo perverso, perché una chiesa come quella di Steven fa la guerra al mondo: «pensano che tutti cerchino di fregarli. Quindi la loro fede si fa ancora più forte» e il piccolo Isaac, che infine si scopre malato pure lui, diventa loro “prigioniero”.
Un romanzo fatto di attese e di tensioni – proprio come in questo periodo di quarantena – in cui si fanno i conti con la propria fragilità, coi rapporti che ci legano agli altri – anche quando sono lontani – e con la nostra disponibilità a piegarci di fronte agli eventi.
 Claudio Lagomarsini, Ai sopravvissuti spareremo ancora, Fazi, pp. 206, € 16 e-book € 8,99
Claudio Lagomarsini, Ai sopravvissuti spareremo ancora, Fazi, pp. 206, € 16 e-book € 8,99
Chiusi dentro una scatola, ci sono cinque quaderni-monocromo che racchiudono, vergata a mano, la storia di un “pasticciaccio brutto” accaduto in un’afosa estate di quindici anni prima. L’estensore dei diari è Marcello: di lui conosciamo, a poco a poco, il carattere, le inclinazioni, le passioni, gli amori svelati dalle pagine sbiadite, che ora corrono sotto gli occhi di un lettore prima disattento e poi famelico, il fratello di Marcello, che da anni vive lontano, di là dall’Oceano, e ora è tornato al paese d’origine per vendere la casa di famiglia.
Marcello nutriva velleità da scrittore e forse quei quaderni rappresentavano l’abbozzo d’un romanzo, che s’intride via via di biografia facendosi più inquieto, più acre, più spietato. E a partire da quella pagina, finalmente il fratello più grande, che sembrava aver voluto dimenticare gli affetti e tutto quanto, coglie l’urgenza d’ascoltare la voce perduta di Marcello e di rivivere attraverso «il racconto ora realistico ora allucinato» ciò che era successo in quell’estate lontana «a partire dalla rapina nella casa di Carlo, il nostro vicino».
Il manoscritto custodisce una galleria di personaggi, attori dell’esistenza vera che Marcello aveva cercato di fissare nella memoria: c’è la loro madre alle prese con un nuovo compagno soprannominato Wayne, c’è l’ex marito, lontano, in Brasile a fare l’agronomo, col quale ci si sente solo per telefono, e c’è la nonna, una vecchietta di ottant’anni, ardita e a volte brilla, che si è innamorata del vicino di casa, il vecchio spaccone che ha subito la rapina, e il cui nome di battaglia è Tordo. Ci sono pranzi pantagruelici nella calura estiva, con litri di vino scadente, e ci sono i litigi nell’orto tra il Tordo e Wayne, e il rapporto conflittuale tra madre e nonna, e ci sono i figli di Wayne, Diego e Ramona, lui un piccolo delinquente e spacciatore di droga, lei una ragazzina innamorata del leader di una band emergente. E ancora, ci sono la moglie moribonda del Tordo, e Nicholas, il nipote gay che viene a casa del nonno solo per scroccare qualche euro.
Mescolando in un piccolo gioiello postmoderno i cliché della nostra letteratura più prossima (ma non solo), Claudio Lagomarsini crea un romanzo quasi opprimente, tragico e surreale, ove covano l’uno a fianco dell’altro le avventure boccaccesche del Tordo, le scazzottate da saloon dei racconti di Wayne, una ridda di «chiacchiere oziose, sporche, sconnesse, insensate» (incredibilmente simili alla fiumana di pettegolezzi che inonda i social in questi giorni di quarantena) durante interminabili banchetti da gazebo che sembrano preludere alla fine di tutto – di lì a poco l’epilogo tragico – come una lunga ed estenuata consunzione in cui riecheggiano Gadda (che guarda caso fa capolino tra le letture di Marcello), “La grande abbuffata”, la “Coena Cypriani” e il “Satyricon”, uniti assieme in uno “gnommero” (groviglio, in gergo romanesco, ndr) d’ingravalliana memoria.
 Cristò, La meravigliosa lampada di Paolo Lunare, Terrarossa edizioni, pp. 97, € 13
Cristò, La meravigliosa lampada di Paolo Lunare, Terrarossa edizioni, pp. 97, € 13
Se la quarantena genera stati d’ansia, forse è meglio affidarsi a una narrazione breve e alle evocazioni magiche di Cristò. L’ultimo suo libro, un romanzo breve o forse, meglio, un racconto lungo, è “La meravigliosa lampada di Paolo Lunare”. Un titolo di velluto per una narrazione che mentre cerca la luce sporge i protagonisti e il lettore stesso in un buio tenero e spietato, a un tempo, nei territori di un sogno, tutto umano, di vedere cosa c’è al di là della vita su questa terra.
Tutto ha inizio con Paolo, chiuso nel garage di casa a trafficare con cavi e collegamenti elettrici: «stava lavorando a quella lampada da tre anni perché fosse pronta in tempo per il loro quindicesimo anniversario di matrimonio. Doveva essere il suo regalo e a quel giorno mancava poco più di un mese». Lei è Petra, donna malinconia e sofferente, porta un carico di segreti che non ha mai voluto svelare a Paolo. Che vita è, quella, colma di cose non dette? Eppure sono, a loro modo, affiatati e lui le vuole fare il più bel regalo di sempre, una lampada in grado di riprodurre la luce del sole. Paolo, che grande uomo! Così sembra. Se non che, per inseguire questa chimera, lui trascura lei. E lei, che è così fragile e che in fondo teme più di tutto se stessa e il proprio passato, continua a mentirgli, perfino sulla potenzialità più grande che una famiglia possa nutrire, la facoltà di ampliarla, di fare dei figli, di aprirsi al futuro.
In Cristò la vita sembra una bolla di sapone, così fragile, tanto esposta ai soffi corrosivi delle menzogne e, ancor più, delle omissioni o delle inconsce incurie di fronte alle quali nessuno è innocente, anche quando cerca di fare il bene dell’altro.
Così Paolo non riuscirà a regalarle il sole. La sua lampada mostrerà tutt’altro, un barbaglio lanciato nel buio della notte per scovare il mistero più grande dell’esserci su questa terra. Ciò che vedrà sarà fonte di un’enorme sofferenza per Paolo, sarà per entrambi la scoperta del non detto dei loro precedenti vissuti, prima e dopo l’amore, di là e di qua dall’affetto.
Prima della notte in cui Petra avrebbe rincontrato sua madre dopo tanti anni, non conosceva ancora le straordinarie proprietà di illuminazione e svelamento della meravigliosa lampada che suo marito aveva inventato per puro caso, ma era ugualmente turbata quando si sedette sul portapacchi posteriore della bicicletta e, cingendo i fianchi di suo marito che stava dando la prima pedalata, pensò che lo stesse abbracciando per l’ultima volta.
Non si può svelare troppo di questo racconto magico, va assaporato nei suoi addii silenziosi, nelle sue epifanie, nelle agnizioni oniriche che collocano la prosa di Cristò nell’alveo dei Landolfi e dei Buzzati e di una scrittura dimessa, elegantemente comune, ma tutta volta alla cattura emozionale del lettore lungo le strade della verità dell’immaginario.
 Pier Luigi Vercesi, La notte in cui Mussolini perse la testa. 24-25 luglio 1943, Neri Pozza, pp. 219, € 13,00
Pier Luigi Vercesi, La notte in cui Mussolini perse la testa. 24-25 luglio 1943, Neri Pozza, pp. 219, € 13,00
La sala del Mappamondo di Palazzo Venezia fu per anni lo scenario delle udienze del Duce. A seconda di chi era al di là della porta, Mussolini decideva la durata dell’anticamera, e anche i gerarchi, prima di affrontarlo – scrive Vercesi – s’informavano «sullo stato d’animo del dittatore. Ettore Muti, il più sfrontato: “Di che umore è l’omaccio?”. Galeazzo Ciano: “C’è l’amica?”. Balbo, il più sarcastico: “Disturberei se parlassi con il fondatore dell’impero?”». Battute, certo, voci di corridoio riportate qua e là dall’uno e dall’altro, primo fra tutti il cameriere privato del Duce, Quinto Navarra. Ma sono tutti atteggiamenti che dicono quanto il “regno” di Benito non fosse solido come si potrebbe pensare, se a due passi dall’uomo del destino ci si permetteva di burlarsi di lui.
Così l’agilissimo saggio-reportage di Vercesi – da anni inviato del Corriere della sera – ricostruisce le ore cruciali a cavallo tra il 24 e il 25 luglio. Il Gran Consiglio non veniva riunito dal 1939 e ora, d’improvviso, alle 17,15 di un sabato di luglio, doveva esprimersi sul futuro dell’Italia. Che fare di Mussolini? Tenerlo o buttarlo? Continuare sulla stessa barca, col medesimo nocchiere, o lasciarlo annegare da solo? “Tutti cacciatori, tutti prede” titola Vercesi al secondo capitolo; a tramare nell’ombra erano in molti: il «conte diabolico», ad esempio, Dino Grandi, concorrente di Ciano, doppiogiochista, «percepito come una soluzione al disastro militare italiano», invocava a un tempo la cacciata di Mussolini e sollecitava «il suo aiuto per ottenere il collare dell’Annunziata». Fu lui, si sa, a proporre la mozione di sfiducia al capo del fascismo. Ma non era l’unico a ordire: c’erano gli ambienti dell’esercito, quelli monarchici e quelli del Vaticano, il vecchio maresciallo Caviglia e l’altro, Cavallero, e poi il conte d’Aquarone, ministro della Real casa dal 1938, e Galeazzo Ciano, gli antifascisti coagulati attorno a Bonomi e gli ambienti dell’alta borghesia industriale e finanziaria… Eppure, «se erano congiure, lo erano a compartimenti stagni, tra loro scollegate», ove a ognuno era concessa una breve specola sulla situazione politica ma a nessuno il panorama intero. Ci furono tentativi di negoziato, sotterfugi, incontri segreti, congiure finite male, sforzi per scindere le responsabilità italiane da quelle tedesche in una girandola di intrighi che saprebbero di commedia se non fossero stati, nella realtà, una tragedia immane per il nostro Paese, il quale per anni, sui campi di battaglia, aveva vestito i panni del gregario.
E mentre l’ulcera del capo s’infiammava, accompagnati da Vercesi, s’arriva di volata alla notte del giudizio, quella del 25 luglio, quella delle speranze nutrire da anni e rese vane dai concitati avvenimenti dei quaranta giorni successivi. “La notte in cui Mussolini perse la testa” è un saggio per tutti e fa luce sui tanti sentieri biforcati che condussero alla destituzione di un duce che, in fondo, fa proprio la figura del fantoccio in balìa di chi, purtroppo, fu più grande di lui, come un don Rodrigo al cospetto di un Innominato, però per sempre irredimibile:
Un mese dopo, il 31 agosto, Mussolini scrisse una lettera alla sorella Edvige: «Per quanto mi riguarda, io mi considero per tre quarti defunto… Del passato non una parola: anch’esso è morto. Non rimpiango niente. Parlo ora del presente. Poche ore dopo la mia caduta, con un messaggio personale, il maresciallo Badoglio chiese quale residenza scegliessi. Risposi che la più conveniente era la Rocca… Credo che con questo mese le mie peregrinazioni finiranno e che, placate le ire delle mie genti di Romagna, mi sarà concesso di andare alla Rocca e ivi aspettare la fine, che mi auguro sollecita, dei miei giorni. […] La storia di Benito Mussolini sarebbe potuta finire qui».
Ma, si sa, le cose andarono diversamente. Perché non si sa mai, davvero, quanto a lungo le catene di un incubo possano resistere.
Neppure in queste nostre terribili ore.
Giacomo Verri, scrittore
Pubblicato venerdì 27 Marzo 2020
Stampato il 02/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/da-leggere-nellattesa/








