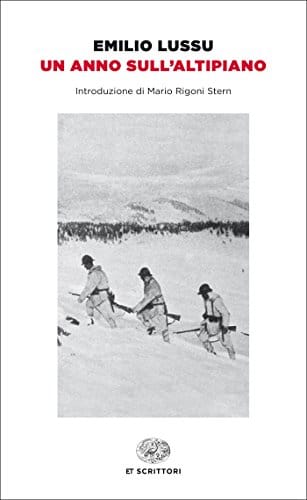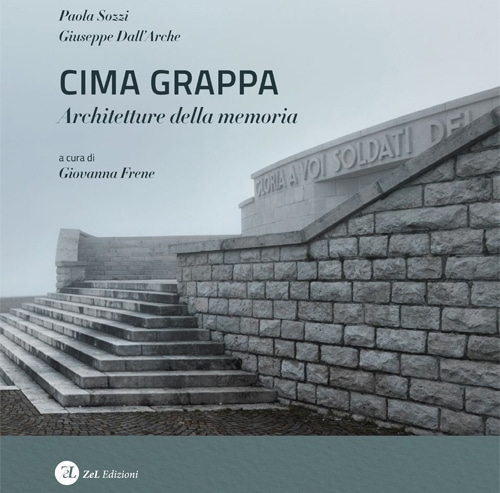Che la grande storia sia la somma di coincidenze urtanti la volontà di chi la storia cerca di forgiarla con le proprie mani è una faccenda che non andrebbe mai dimenticata; se poi ci capita di leggere questo straordinario romanzo (ma anche reportage, ma anche saggio storico) di Miljenko Jergović, L’attentato (trad. di Ljiljana Avirović, Nutrimenti, pp. 185, € 18), ecco che la cosa si fa più evidente.
Che la grande storia sia la somma di coincidenze urtanti la volontà di chi la storia cerca di forgiarla con le proprie mani è una faccenda che non andrebbe mai dimenticata; se poi ci capita di leggere questo straordinario romanzo (ma anche reportage, ma anche saggio storico) di Miljenko Jergović, L’attentato (trad. di Ljiljana Avirović, Nutrimenti, pp. 185, € 18), ecco che la cosa si fa più evidente.
 Si parla qui dell’attentato per antonomasia, quello di Sarajevo del 28 giugno 1914, quello insomma che ha dato il via alla storia del secolo breve e che – se lo guardiamo da vicino come fa Jergović – ci fa tremare le vene nei polsi tanti sono i minuscoli ingredienti che la sorte ci ha gettato dentro. L’autore, infatti, ricostruisce le biografie di chi quel giorno c’era, a partire da Gavrilo Princip e Francesco Ferdinando, insistendo sui più remoti aneddoti, sugli incontri fortuiti, sulle fatali coincidenze che hanno portato l’austriaco e il bosniaco a incrociare – forse – i loro sguardi in quei cruciali e fascinosi tre secondi di una calda mattina sarajevese.
Si parla qui dell’attentato per antonomasia, quello di Sarajevo del 28 giugno 1914, quello insomma che ha dato il via alla storia del secolo breve e che – se lo guardiamo da vicino come fa Jergović – ci fa tremare le vene nei polsi tanti sono i minuscoli ingredienti che la sorte ci ha gettato dentro. L’autore, infatti, ricostruisce le biografie di chi quel giorno c’era, a partire da Gavrilo Princip e Francesco Ferdinando, insistendo sui più remoti aneddoti, sugli incontri fortuiti, sulle fatali coincidenze che hanno portato l’austriaco e il bosniaco a incrociare – forse – i loro sguardi in quei cruciali e fascinosi tre secondi di una calda mattina sarajevese.

Ottimo giocatore di carambola e discreto poeta, Gavrilo Princip “faceva parte della prima generazione di slavi del Sud che si sarebbe formata sull’esempio della cultura popolare americana. Tra il biliardo e i romanzi gialli nasceva un mondo molto lontano da quell’eroico ragazzo ossessionato dall’epica che non voleva dormire con i turchi”; e sarà proprio questo fanciullo dagli occhi magnetici, malato di tubercolosi, gracile e di bassa statura, a uccidere l’erede al trono d’Austria, anch’egli tubercolotico, ma così opposto al primo per la stolida visione politica (“austriaco e viennese, orgoglioso della sua patria ristretta, un uomo con la mentalità di un tifoso di calcio”) e per l’impuntatura testarda che lo portò a sposare con un matrimonio morganatico Sofia Chotek, donna di rango inferiore.

Fu dunque Princip a sparare, a uccidere e a determinare la storia di un secolo intero. Ma il libro di Jergović sembra bruciarci tra le mani proprio perché a ogni svolta di ciò che accadde insinua l’apertura di un abisso controfattuale, di un malinconico mondo alternativo che sarebbe potuto fiorire se solo le cose fossero andate diversamente.

Come sarebbe stata la nostra storia se Mehmedbašić non fosse trasalito alla vista del corteo solenne? […] Se Muhamed Mehmedbašić avesse lanciato la bomba contro il samovoz di Francesco Ferdinando, forse saremmo stati diversi anche noi che siamo nati dopo a Sarajevo […] Invece, è stato Čabrinović a lanciare la bomba.

Eppure neanche il suo gesto fu quello buono; la bomba rotolò sul tettuccio dell’auto, cadde a terra ed esplose ferendo una donna che guardava il corteo della finestra di casa sua; a quella donna si ruppero i timpani e rimase sorda per tutta la vita, mentre Nedeljko Čabrinović neppure riuscirà a sottrarsi all’arresto dandosi la morte poiché la fialetta di cianuro che voleva ingoiare gli rimase impigliata tra i denti e quel poco di veleno che gli andò dentro non provocò che una crisi di vomito e nausea in preda al quale si raggomitolò come un ragno in punto di morte, mentre i devoti cittadini dell’Impero lo linciavano prima di consegnarlo alle autorità cittadine. “Nedeljko Čabrinović non aveva una gran voglia di vivere. Era un suicida, malinconico, triste e negletto. […] Lanciò la bomba come se lanciasse una rosa”.

Così la palla passò nelle mani di Princip (“il primo bosniaco non credente” in una Bosnia dove non si era mai sentito che un essere umano non potesse credere in Dio), ultimo grano di un rosario di tentativi per mettere in moto un evento che forse non voleva accadere o forse voleva accadere a tutti i costi nonostante gli ostacoli del caso. Ipotesi, quest’ultima, che apre lo scenario su un labirinto di eroi, di guerre e di chimere che hanno travagliato i Balcani per tutto il XX secolo, mescolando assieme con tanta, troppa confusione – per chi guarda distrattamente da Occidente – quel prezioso crogiolo di etnie e culture che stanno al di là del mar Adriatico.

E Jergović ci accompagna proprio tra le pieghe di questa confusione, sulle tracce di chi l’ha fatto e di chi l’ha subito, quell’attentato, in una babelica ridda di sguardi incrociati dove non ci sono vinti e vincitori definitivi, né è mai certo chi siano né se ci siano stati vittime e carnefici accertati.

Certo è che quel che scorgiamo è un disegno frantumato e complesso all’interno del quale l’autore urla con un’antica passione, fiaccata dalla fatalità, il suo lamento contro ogni semplice e brutale – e cronicamente indelebile – equiparazione del concetto di jugoslavismo con la Grande Serbia. La differenza tra la leggenda sull’attentato della Giovane Bosnia e quella degli austrofili sta nel fatto che i giovani bosniaci insistevano sui propri ideali jugoslavi, mentre gli austrofili attribuivano loro l’ideologia della Grande Serbia.
Austrofili peraltro rappresentati, in questa storia, dal loro arciduca, il cui “gusto estetico e sociale è paragonabile a quello di un viennese della piccola borghesia”, arido, di vedute ristrette, potenziale guerrafondaio e incapace di cogliere l’anima dei popoli che l’impero dello zio sottometteva da secoli: “Francesco Ferdinando disprezzava i serbi così come in un altro modo disprezzava gli ungheresi. Con la differenza che i serbi non li conosceva, e per lui non rappresentavano nulla”.
 Quelle che narra L’attentato sono esistenze fatte di periodi ipotetici dell’irrealtà, sono tanti “flussi paralleli che iniziano con la primavera e l’estate del 1914 e continuano per tutto il ventesimo secolo”; sono vite che solo per un caso tra un milione hanno voltato il loro corso in anacoluti improvvisi; e non si parla solo di Princip e del cinico Francesco Ferdinando (“con il cinismo colma la mancanza d’istruzione, con il cinismo si difende dall’immaginazione dei suoi interlocutori”), ma di una generazione intera (Trifko Grabež, Nedeljko Čabrinović, Ivo Andrić, Danilo Ilić, Dragutin Dimitrijević, il colonnello Apis, Simo Miliuš, Dragutin Mras, ecc…) di “congiurati, poeti, scrittori, storici, attori, registi teatrali, la giovane élite di una città europea smarrita che pareva essersi appena destata dal sonno senza sapere cosa scegliere per il proprio futuro”; un futuro che, purtroppo, a cent’anni dall’attentato, lascia Sarajevo sommersa dallo stesso odio e dalla stessa dinamica di esodo e oblio il cui colpevole senso sta “nell’eterna semplificazione della vita quotidiana e della società”.
Quelle che narra L’attentato sono esistenze fatte di periodi ipotetici dell’irrealtà, sono tanti “flussi paralleli che iniziano con la primavera e l’estate del 1914 e continuano per tutto il ventesimo secolo”; sono vite che solo per un caso tra un milione hanno voltato il loro corso in anacoluti improvvisi; e non si parla solo di Princip e del cinico Francesco Ferdinando (“con il cinismo colma la mancanza d’istruzione, con il cinismo si difende dall’immaginazione dei suoi interlocutori”), ma di una generazione intera (Trifko Grabež, Nedeljko Čabrinović, Ivo Andrić, Danilo Ilić, Dragutin Dimitrijević, il colonnello Apis, Simo Miliuš, Dragutin Mras, ecc…) di “congiurati, poeti, scrittori, storici, attori, registi teatrali, la giovane élite di una città europea smarrita che pareva essersi appena destata dal sonno senza sapere cosa scegliere per il proprio futuro”; un futuro che, purtroppo, a cent’anni dall’attentato, lascia Sarajevo sommersa dallo stesso odio e dalla stessa dinamica di esodo e oblio il cui colpevole senso sta “nell’eterna semplificazione della vita quotidiana e della società”.
 Così Miljenko Jergović, vergando tra le pagine chiose e annotazioni che sembrano risalire la schiena di un’antica e sventurata saggezza, cerca di fare pulizia delle concrezioni più ottuse e delle teorie meno fondate sulla “distribuzione della colpa per l’inizio della Grande Guerra”, e – a mo’ di sunto di un secolo di conflitti – raccoglie nel palmo della propria mano di scrittore sarajevese un grumo di polvere di ciò che negli ultimi sessant’anni, laggiù, si chiamava raja (fino al 1992) e che sostituiva il più “povero e disprezzato” rajetin ottomano (il popolino, il poveraccio tra i nobili, il cristiano tra i musulmani ortodossi). Raja era nella Sarajevo degli anni ottanta chiunque fosse accettato.
Così Miljenko Jergović, vergando tra le pagine chiose e annotazioni che sembrano risalire la schiena di un’antica e sventurata saggezza, cerca di fare pulizia delle concrezioni più ottuse e delle teorie meno fondate sulla “distribuzione della colpa per l’inizio della Grande Guerra”, e – a mo’ di sunto di un secolo di conflitti – raccoglie nel palmo della propria mano di scrittore sarajevese un grumo di polvere di ciò che negli ultimi sessant’anni, laggiù, si chiamava raja (fino al 1992) e che sostituiva il più “povero e disprezzato” rajetin ottomano (il popolino, il poveraccio tra i nobili, il cristiano tra i musulmani ortodossi). Raja era nella Sarajevo degli anni ottanta chiunque fosse accettato.
 Tuttavia, “per essere raja bisognava ignorare tutto ciò che si era stati. E ignorare è effettivamente facile. Molto più facile che, diciamo, dimenticare”. Peccato che l’oblio sia stato, anche, la base della tragedia delle guerre jugoslave, un disastro in cui scomparve la Sarajevo prebellica (con la sua orda di persone senza documenti proiettate ai quattro angoli del mondo, “nell’agonia e nell’orrore della non appartenenza”) e nacque quella successiva: una città dove la ex raja ripete nei propri sogni quel fatidico giorno di san Vito del 1914, una città dove ogni giorno e ogni notte Gavrilo Princip tira fuori la sua pistola e ripercorre il suo gesto di ribellione.
Tuttavia, “per essere raja bisognava ignorare tutto ciò che si era stati. E ignorare è effettivamente facile. Molto più facile che, diciamo, dimenticare”. Peccato che l’oblio sia stato, anche, la base della tragedia delle guerre jugoslave, un disastro in cui scomparve la Sarajevo prebellica (con la sua orda di persone senza documenti proiettate ai quattro angoli del mondo, “nell’agonia e nell’orrore della non appartenenza”) e nacque quella successiva: una città dove la ex raja ripete nei propri sogni quel fatidico giorno di san Vito del 1914, una città dove ogni giorno e ogni notte Gavrilo Princip tira fuori la sua pistola e ripercorre il suo gesto di ribellione.
Ma quando il sogno finisce, nel luogo in cui una volta si trovava Sarajevo, oggi c’è una città omonima, quasi la stessa, benché con edifici già fatiscenti, ma non è la stessa città, né vi è un ritorno possibile per chi in quella città non è mai stato. Non c’è Paese straniero più lontano di quella Sarajevo, nessun altro luogo, né malinteso più profondo.
Pubblicato lunedì 28 Giugno 2021
Stampato il 05/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/due-colpi-di-pistola-cosi-comincio-il-secolo-breve/