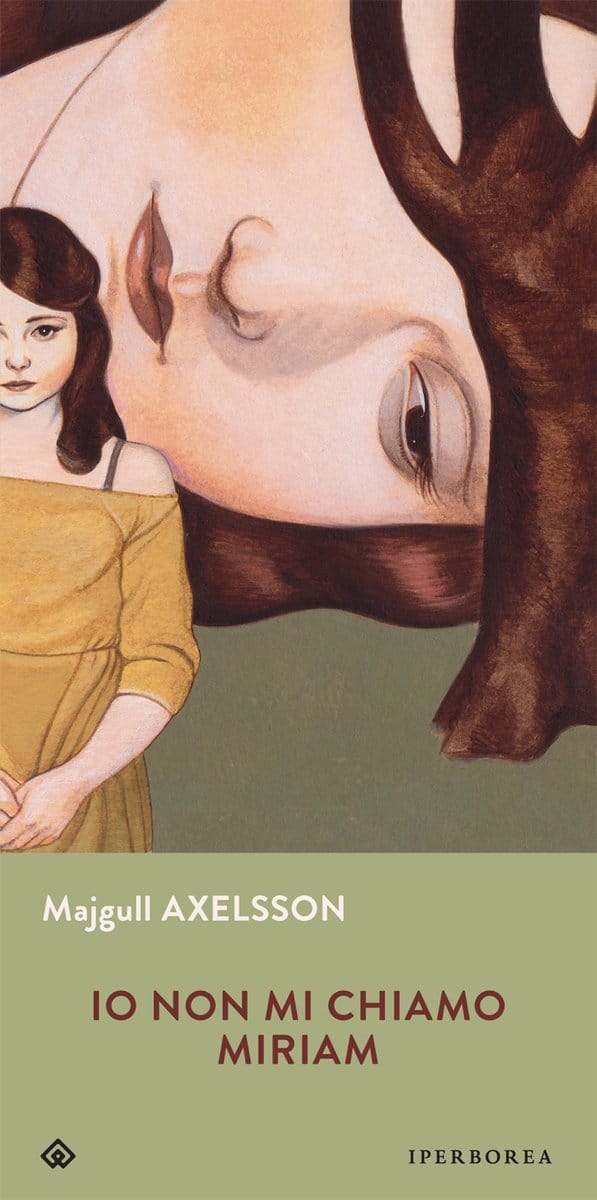«Quante storie/ son passate di lì./ Mamme abbracciate a bambini/ uomini giovani/ già vecchi cadenti sono finiti/ in un fumo tremendo./ Chi conosce/ la mappa dei lager?/ Terra di Germania./ Suolo tedesco/ impregnato di cenere bianca,/ di ossa spezzate./ Saranno anche/ belli i giardini/ da quella terra spunteranno dei fiori/ Il mondo diviso:/ chi vuole testimonianza/ chi desidera/ silenzio assoluto./ Mi arrivano spesso/ questionari, inviti./ Aborriamo la rabbia/ ma forse è giusto/ che chi ha vissuto/ quel tempo porti il suo…/ granello di sabbia». Maria Musso, l’autrice di questa dolorosa poesia, era nata a Diano Arentino, un piccolo paese del ponente ligure. Aveva appena vent’anni e splendidi capelli neri e ricci, raccolti con un nastro rosso quando la presero. Chissà, forse i fascisti che l’arrestarono, su quel nastro rosso appuntarono il loro ghigno di sgherri.
«Quante storie/ son passate di lì./ Mamme abbracciate a bambini/ uomini giovani/ già vecchi cadenti sono finiti/ in un fumo tremendo./ Chi conosce/ la mappa dei lager?/ Terra di Germania./ Suolo tedesco/ impregnato di cenere bianca,/ di ossa spezzate./ Saranno anche/ belli i giardini/ da quella terra spunteranno dei fiori/ Il mondo diviso:/ chi vuole testimonianza/ chi desidera/ silenzio assoluto./ Mi arrivano spesso/ questionari, inviti./ Aborriamo la rabbia/ ma forse è giusto/ che chi ha vissuto/ quel tempo porti il suo…/ granello di sabbia». Maria Musso, l’autrice di questa dolorosa poesia, era nata a Diano Arentino, un piccolo paese del ponente ligure. Aveva appena vent’anni e splendidi capelli neri e ricci, raccolti con un nastro rosso quando la presero. Chissà, forse i fascisti che l’arrestarono, su quel nastro rosso appuntarono il loro ghigno di sgherri.
Maria Musso fu deportata nel campo di concentramento di Ravensbrück il 2 settembre del 1944. Riuscì a tornare a casa, a raccontare e a scrivere l’orrore che aveva vissuto, il suo granello di sabbia, a spiegare ai giovani l’abominio del nazifascismo. Maria è mancata nel 2011.

La sua storia – e quella delle altre deportate – è raccontata in “Destinazione Ravensbrück. L’orrore e la bellezza nel lager delle donne”, libro edito dalla casa editrice All Around, che ha avuto il patrocinio di Aned, Anpi, e degli istituti storici della Resistenza Ilsrec, Isrecim, Isr e Isrec. A scriverlo tre donne, Donatella Alfondo, Laura Amoretti e Raffaella Ranise. E soprattutto di donne parla il volume. Ne parla e le fa parlare, avendo recuperato i loro ricordi, le loro testimonianze. La loro storia. Mille tra le deportate italiane che finirono nel lager non tornarono a casa.
Situato a circa 80 km a nord di Berlino – in un luogo a prima vista ameno, su un terreno circondato da un bosco di conifere e betulle e un lago idilliaco a poche centinaia di metri – il campo di Ravensbrück (letteralmente “il ponte dei corvi”), fu prevalentemente femminile. Negli anni in cui fu attivo vi passarono più di 140mila donne. Novantamila quelle che non ce l’hanno fatta a tornare.

Nel lager nazista fu internata e morì anche la giornalista Milena Jesenská, che era stata la moglie di Ernst Pollak e aveva avuto una intensa e tormentata relazione con Franz Kafka. E per il campo passò pure Geneviéve De Gaulle, figlia del fratello del generale a capo del Movimento Francia Libera, che fino alla sua morte, avvenuta nel 2002, fu sempre impegnata a denunciare con la sua testimonianza gli orrori che aveva vissuto. Eppure rispetto agli altri campi dell’universo concentrazionario nazista – Auschwitz, Dachau, Buchenwald, solo per citare i più conosciuti – quello di Ravensbrück per lungo tempo è stato come dimenticato, nonostante a volerlo fosse stato Heinrich Himmler in persona. Inizialmente il campo doveva essere funzionale al lavoro servile per le grandi imprese del Reich, come la Siemens (che aveva una fabbrica proprio nei pressi del campo e dove non pochi furono gli atti di sabotaggio da parte delle prigioniere), poi man mano che il conflitto pendeva a favore degli Alleati, venne “riconvertito” in un vero e proprio campo di sterminio per accelerare la “soluzione finale”.

Le ragioni di questo oblio della memoria sono molteplici: intanto perché il lager si trovava nella regione del Brandeburgo, in quella che poi divenne la Repubblica democratica tedesca, dove, fino alla caduta del Muro di Berlino, erano ancora acquartieratele truppe sovietiche di stanza sul territorio tedesco. Si poteva visitare solo l’esterno. Ma questa ipotesi da sola non basta, spiegano le autrici: c’erano tanti altri campi di sterminio nella ex Germania dell’Est, e sono noti e conosciuti. Ravensbrück era sostanzialmente un campo femminile e questo, probabilmente, l’ha consegnato all’oblio per lungo tempo, almeno fino all’inizio degli anni 90.

Della deportazione femminile si è sempre parlato poco. La spezzina Bianca Paganini, arrestata dalla Gestapo assieme alla madre e alla sorella, ricordava che per alcuni aspetti «il peggio fu il ritorno»: velatamente, quando non proprio apertamente, le donne che tornarono a casa furono tacciate di essere prostitute.

E le considerazioni di Ambra Laurenzi, figlia di Mirella Stanzione, una delle ultime sopravvissute passate per il campo, confermano la durezza inaspettata del ritorno a casa: «Alle staffette partigiane dicevano: perché ti sei impicciata? Sei una donna, cosa ti importava di quanto accadeva? E ancora: se sei tornata cosa ha fatto per tornare? Come ti sei comportata con i tedeschi? Quando sono tornate si sono trovate prive di ogni sostegno e riferimento. Così ti può capitare che te ne stai al lavello a lavare i piatti, viene la Gestapo e ti porta via, e quando ritorni, riprendi a lavare i piatti». Laurenzi dal 2017 è presidente del Cir, il Comitato internazionale Ravensbrück. E insiste con forza sulla necessita di ridare voce a quelle donne. Di raccontare la violenza, il sadismo di capi e kapò, le sterilizzazioni forzate, gli esperimenti di tanti dottori Mengele, quelli dell’infermeria di Ravensbrück si chiamavano Walter Sonntag e Karl Genhardt, che non esitarono ad iniettare nei corpi femminili nitrato d’argento, benzina o massicce dosi di virus e batteri per esperimenti pseudo scientifici (di cui furono vittime soprattutto le prigioniere polacche).

Non fu solo violenza di uomini su corpi di donne. Fu anche violenza di donne su altre donne. Un capitolo del libro è dedicato alle Aufseherinnen, le guardiane naziste del campo, addette alla sorveglianza dei block femminili. «Le guardiane – scrivono Alfonso, Amoretti e Ranise – erano in prevalenza giovani, perfettamente “ariane” secondo i dettami nazisti, curatissime nell’aspetto e nell’abbigliamento, fino nella biancheria intima. Violente, arroganti, pur essendo semplici ausiliarie delle SS e mere esecutrici dei loro ordini – approfondiscono le autrici – aggredivano fisicamente e verbalmente in modo costante le prigioniere. Molte di loro si servivano dei loro amati e inseparabili cani, addestrati a riconoscere la veste a righe delle prigioniere per poterle attaccare a un semplice ordine. Hanno la possibilità di dimettersi ma a quanto pare, nessuna lo farà». Fa orrore il modo banale con cui venivano reclutate: bastava rispondere ad un annuncio sul giornale, giurare fedeltà al Reich e insieme al vitto, all’alloggio e allo stipendio si offriva l’ebbrezza del male assoluto.

Tra il 1942 e il 1945 a Ravensbrück vennero “formate” almeno 3.500 ausiliarie per inviarle poi negli altri lager nazisti (come Irma Grese, soprannominata la iena di Auschwitz, che iniziò la sua carriera proprio a Ravensbrück nel 1942 ad appena 19 anni. Condannata alla pena capitale al processo di Norimberga, trascorse la sua ultima notte cantando inni nazisti). Tra le aguzzine citate dal libro anche di Herta Oberheuser, dottoressa specializzata in dermatologia, arrivata nel campo a 29 anni: «Camminava disinvolta tra le corsie dell’ospedale, dove si respirava il fetore nauseabondo prodotto dalle ferite infette per la cancrena» e sottoponeva «anche senza motivo, le prigioniere a prelievi e a dolorosissime medicazioni».
Ma non c’è solo violenza. Non c’è solo il male. C’è anche la forza dell’amore, la solidarietà, gli affetti che si saldarono nel fango e tra il filo spinato. E che resisteranno per tutta una vita. Come il legame tra le liguri Mirella Stanzione e Bianca Paganini, insieme in carcere, poi sul treno per Bolzano e infine Ravensbrück con la sorella di Bianca e le rispettive madri («Piangevamo e ridevamo nello stesso tempo, insieme. E c’era mia mamma che diceva: “dove vi porto a ballare stasera?”. C’era una bella unione tra noi», ricorda nel libro Mirella). Come il sentimento che ha legato Maria Musso a Ida Desandrè fino ai loro ultimi giorni («ce la siamo sempre cavata, perché una aiutava l’altra» raccontava Ida settant’anni dopo).

Prima di piombare nell’inferno di Ravensbrück molte prigioniere italiane, in particolare le liguri, passarono per un piccolo e quasi dimenticato centro di detenzione nell’estremo ponente, a Vallecrosia. E già, perché sulla presenza di campi di concentramento in Italia ha prevalso per tanti anni un desiderio di rimozione. “Campo dimenticato” lo chiamano le autrici in un capitolo del loro libro. Vallecrosia: dopo la fine della guerra e fino al 2010 in questo angolo di Liguria c’era la sede dell’Istituto biochimico-farmaceutico Fassi, quelle delle famose pastiglie, ma quella grande caserma, tra gennaio e agosto del 1944, fu un campo di prigionia repubblichino dove ebrei, prigionieri politici, renitenti alla leva della Rsi, venivano raccolti prima di essere inviati in Germania o in Polonia. Solo nel 2005, grazie all’impegno di ex partigiani e di storici locali, la polvere del tempo che l’aveva quasi cancellato dalla memoria venne rimossa. Anche se l’assenza «assoluta di fonti», come spiega lo storico Paolo Veziano nel libro, «ci costringe a ricostruire, in modo quanto mai approssimativo» quella pagina triste della persecuzione antiebraica. Tra il 1943 e il 1945 l’Italia della Rsi avvia alla deportazione circa 7.500 ebrei italiani che persero la vita nei lager nazisti. In Liguria – dove oltre a Vallecrosia fu attivo come campo di raccolta quello di Pian di Coreglia-Calvari, in Val Fontanabuona, oltre ai “trasporti” di arrestati in partenza dal cercare genovese di Marassi – furono deportate 261 persone. Ne sono sopravvissute una ventina. Dall’imperiese partono in 53, solo sei riuscirono a tornare».

Descrivere l’orrore è difficile. Descriverlo dopo averlo vissuto è difficile e penoso assieme. Si avrebbe voglia di ritrarsi dall’abisso in cui si è precipitati. Ecco perché la memoria di queste donne è un valore inestimabile, da conservare e custodire. È una memoria costruita sulle loro carni vive. «Ho visto scheletri/larve, feriti./ Ho visto uomini/ che eran stati tali./ Ho visto belve/ con volti umani/ ho visto troppo per dimenticare», scrive Maria Musso in una sua altra poesia. Noi che non abbiamo visto, se non attraverso i loro occhi, anche noi dovremmo essere capaci di non dimenticare.
Pubblicato venerdì 11 Settembre 2020
Stampato il 15/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/io-donna-nel-campo-della-memoria-taciuta/