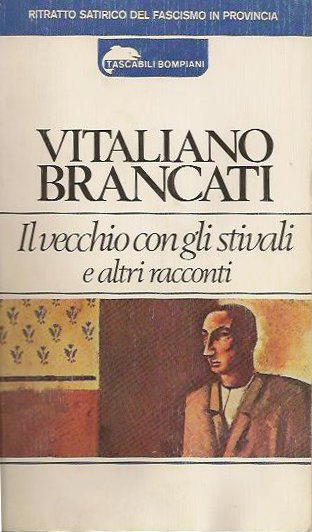Se la Storia offende persone e luoghi, la letteratura può provare a risarcirne l’umanità. È quello che fa Marco Balzano col suo quarto romanzo, “Resto qui” (Einaudi, 2018), raccontando le storie di un paese, Curon, e di una donna, Trina, sommersi – anche letteralmente – dalla storia e dal progresso. Ma non senza lottare: contro l’italianizzazione forzata che il fascismo impose in Alto Adige; contro i dittatori, Mussolini e Hitler, che strinsero a morsa quelle valli e le precipitarono nella guerra; contro il lucro ingordo travestito da progresso. Trina insegna, spara, denuncia, modi diversi per dire “sono io, sono qui, resto qui”. Un romanzo storico, a suo modo, un romanzo civile che chiede anche anoi, oggi, di presidiare, sorvegliare, resistere.
Se la Storia offende persone e luoghi, la letteratura può provare a risarcirne l’umanità. È quello che fa Marco Balzano col suo quarto romanzo, “Resto qui” (Einaudi, 2018), raccontando le storie di un paese, Curon, e di una donna, Trina, sommersi – anche letteralmente – dalla storia e dal progresso. Ma non senza lottare: contro l’italianizzazione forzata che il fascismo impose in Alto Adige; contro i dittatori, Mussolini e Hitler, che strinsero a morsa quelle valli e le precipitarono nella guerra; contro il lucro ingordo travestito da progresso. Trina insegna, spara, denuncia, modi diversi per dire “sono io, sono qui, resto qui”. Un romanzo storico, a suo modo, un romanzo civile che chiede anche anoi, oggi, di presidiare, sorvegliare, resistere.
La punta di un campanile che emerge dal lago: cosa ti ha spinto a raccontarne la storia? Quale esigenza dello scrittore è stata sollecitata e quale esigenza dell’uomo?
Se una storia non mi sembra metaforica, capace cioè di raccontare anche altre storie, non valuto nemmeno la possibilità di imbastire un romanzo. Non credo che in letteratura ci possa interessare l’aneddoto, per quanto emblematico, drammatico, evocativo esso sia. La storia di Curon, questo paese altoatesino distrutto dalla Montecatini con l’approvazione della Repubblica italiana per farci una diga di breve durata, mi sembrava che raccontasse molte altre storie: quella di un progresso non sempre progressivo, ma spesso scellerato e antidemocratico; quella dei molti distratti che non presidiano i propri luoghi e non sorvegliano i propri diritti; quella dei pochi che puntano i piedi fino alla fine, anche quando sotto non c’è più terra ma solo l’acqua.

È sufficiente una “buona causa” civile a fare una buona opera letteraria?
Assolutamente no. Un solo elemento non è mai sufficiente. A ben guardare, nemmeno una sola storia è sufficiente per scrivere un buon romanzo, ce ne vogliono almeno due. Più in generale credo che non sia una questione di ingredienti, non esiste un elemento che, una volta acquisito, garantisca dell’esito finale. E poi alla letteratura non interessano le buone cause, né il politicamente corretto, né uno spettro preciso di valori. Niente di tutto ciò. Credo che alla letteratura interessi ciò che è umano: la prima dimensione di un racconto, se ci fai caso, è sempre quella psicologica e relazionale, dunque emotiva e soggettiva dell’individuo. Questo accade perché la Storia, quella che studiamo a scuola, quella dei manuali, è la materia meno umana di tutte. La Storia è una brutale selezione di fatti e di personaggi (per lo più quelli che hanno avuto a che fare col potere), scarnificati della loro umanità. Joyce diceva che per sfuggire alla dittatura della Storia si è messo a scrivere storie. È così: il riscatto che la letteratura può offrire a questa brutalità non è una riscrittura di quanto accaduto, ma un risarcimento di umanità.
Come hai ricostruito la storia di Curon e Resia? Quali testimoni hai cercato e sentito? Quali sono state le loro reazioni di fronte alla tua volontà di scrivere un romanzo su questi fatti e di fronte al libro ultimato?
Ho trovato un mondo chiuso, non è stato facile rompere il ghiaccio. Ma uno scrittore deve necessariamente essere un maieuta, uno che sa tirar fuori le parole altrui. Ancor prima che uno che sa scrivere è uno che sa ascoltare quello che gli altri hanno da dire, che sa andare a rompere le scatole, che reputa imprescindibile possedere la parola viva dei testimoni. Ho studiato tutto quello che ho potuto, ho parlato con storici e politici, ingegneri e insegnanti, e alla fine ho intervistato cinque testimoni, oggi anziani, di quegli anni. Alcune loro parole sono state così importanti che le ho fatte dire a Trina, la protagonista.
Uno dei cardini di questo romanzo è la parola, la sua importanza e la sua impotenza: ma come è stato narrare con voce femminile? Come hai scelto la lingua, le parole di Trina?
Volevo farlo da tanto. Volevo da molto tempo dire “io” e essere donna. Sapevo che mi avrebbe regalato un cambio di prospettiva. E infatti tutto si è rivelato diverso: più ancestrale, materno, viscerale. Un’esperienza potente. Quando ho saputo che durante il fascismo sono esistite le maestre clandestine, che insegnavano il tedesco ai bambini obbligati ad andare nella scuola fascista, mi son detto che era la volta buona. Poi ho visto una fotografia di una donna arrampicata sul tavolo e poi sul tetto di casa sua: una vecchia signora che si chiamava Trina e che è stata l’ultima a lasciare il paese ormai sommerso. Volevo una donna così, fragile e forte, due aggettivi che non ho mai considerato in contrapposizione.

“Italia agli italiani” è uno slogan che probabilmente Trina avrà sentito più di settant’anni fa, quando il fascismo cercò di italianizzare forzosamente gli altoatesini; le stesse parole erano scritte su un simbolo elettorale alle elezioni del 4 marzo scorso. Di cosa sono sintomo, secondo te? Qualcosa non ha funzionato, in Italia, dalla Resistenza in poi?
Su un manifesto una volta ho letto che il fascismo si cura studiando e il razzismo viaggiando. Sono due atti che ti mettono per forza in una condizione esplorativa e relativa. Il fascismo, invece, è sempre aprioristico e gerarchico, rifiuta la discussione perché è la discussione stessa che esplora e mette in crisi le nostre convinzioni. Cosa non ha funzionato in Italia? Beh, non abbiamo mai fatto i conti con quello che è stato il Ventennio. Pochi giorni fa ero a Berlino, in aeroporto c’erano volantini che pubblicizzavano tour turistici nella Berlino hitleriana. Per strada l’architettura e i musei fanno vedere ovunque quello che è successo: nessuno nasconde l’orrore che si è consumato. Anzi, lo si mette a portata di tutti e così facendo si ammette, si discute, si riflette, si prende gradualmente coscienza. In Italia – guarda appunto quanto poco si conosce la storia dell’Alto Adige, che molto ha avuto a che fare col fascismo prima e dopo la guerra – tutto questo non è mai accaduto. Tutto è stato sempre silenziato, insabbiato, in fretta riciclato sotto mentite spoglie (spesso nemmeno troppo mentite).
L’identitarismo è uno dei cavalli di Troia del fascismo del terzo millennio; su cosa si basa secondo te e perché ha tanta presa sui più giovani?
Ha presa su quei giovani che, appunto, non viaggiano e non studiano. Per quelli che viaggiano e studiano non dico l’identitarismo, ma la stessa identità è un concetto sostanzialmente superato o comunque di retroguardia. Era forse un valore che poteva calzare per società più antiche e più chiuse, ma oggi qualsiasi battaglia in difesa di una presunta identità è destinata al fallimento. La nostra società, lo sappiamo, non è solo liquida, ma anche aerea, fluida, iperconnessa. Siamo aperti a centinaia di stimoli che vengono da ogni parte del pianeta. Li abbiamo sottomano in ogni momento, basta accendere lo smartphone. Nulla fa più in tempo a cristallizzarsi, tutto si muove e si mescola. Che senso può avere, alla luce di tutto ciò, l’identità, che per sua natura è un concetto rigido, per un adolescente di oggi? Identità è una parola monolitica, riguarda insiemi difficilmente circoscrivibili: quello che conta è la nostra capacità di interazione con l’altro.
Ma non sarà proprio l’eccesso di fluidità e di stimoli a generare, per contro, nei ragazzi il bisogno di stabilità e identità, che poi il fascismo promette loro?
Il fascismo interviene dove si creano vuoti educativi, culturali e relazionali. L’affiliazione di un giovane a formazioni di questo genere è sempre il risultato di un fallimento che la politica e la società devono prendere in carico e analizzare attentamente. La causa di queste adesioni non sta, a mio avviso, nella troppa fluidità dei meccanismi socio-relazionali, o non è comunque quella la ragione principale. Questi avvicinamenti avvengono quando la famiglia di provenienza si sente abbandonata o versa in condizioni di disagio; quando la scuola non riesce ad avere una presa sufficiente; quando la politica è distante o propone un’immagine odiosa di sé; quando si resta in balia del web senza strumenti adeguati, eccetera. Insomma, quando un ragazzo si ritrova solo e con un bisogno di socialità insoddisfatto. Il fascismo, in conclusione, si combatte con istituzioni forti e inclusive.
La resistenza della protagonista del tuo romanzo, Trina, è prima insegnamento del tedesco in clandestinità, poi diserzione col marito sulle montagne e infine parola di denuncia: quali sono, a tuo avviso, i modi in cui possiamo resistere oggi alla cultura neofascista e a certo progresso che distrugge? Quali i tuoi personali modi di farlo?
Presidiare i nostri spazi, reali o metaforici; connettersi con gli altri (non solo sul web); concepire la politica non come un’entità a cui demandare, ma come un contesto in cui intervenire (anche quando e anche se la classe politica fa di tutto per deprimere questo slancio); donare una parte del proprio tempo e del proprio sapere in contesti di disagio e di sofferenza. I miei modi di farlo sono questi che ti ho elencato, e so che posso fare di più.
Pubblicato lunedì 16 Aprile 2018
Stampato il 02/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/la-terapia-del-romanzo-e-il-borgo-sommerso/