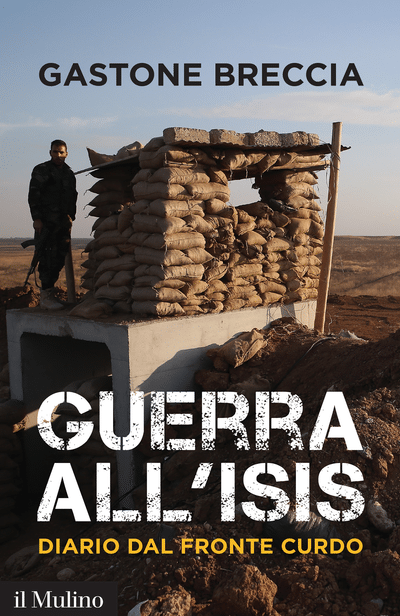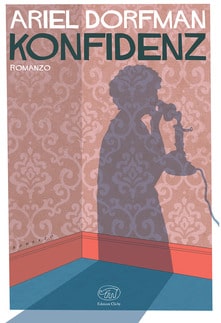 Basterebbe quanto vissuto sulla propria pelle a fare di Ariel Dorfman un “pezzo vivente di storia del Ventesimo secolo”, come scrive il suo traduttore italiano Fabio Cremonesi: nato a Buenos Aires nel maggio del 1942, Dorfman vive la fanciullezza negli States per poi trasferirsi in Cile negli anni del governo Allende, di cui diviene consigliere culturale. Nella terribile notte del golpe di Pinochet, Dorfman solo per caso non si trova al fianco del presidente, riesce a fuggire e trascorre alcuni anni prima a Parigi, poi ad Amsterdam, e infine fa ritorno negli USA, stabilendosi nella Carolina del Nord dove diventa professore di letteratura latinoamericana alla Duke University di Durham.
Basterebbe quanto vissuto sulla propria pelle a fare di Ariel Dorfman un “pezzo vivente di storia del Ventesimo secolo”, come scrive il suo traduttore italiano Fabio Cremonesi: nato a Buenos Aires nel maggio del 1942, Dorfman vive la fanciullezza negli States per poi trasferirsi in Cile negli anni del governo Allende, di cui diviene consigliere culturale. Nella terribile notte del golpe di Pinochet, Dorfman solo per caso non si trova al fianco del presidente, riesce a fuggire e trascorre alcuni anni prima a Parigi, poi ad Amsterdam, e infine fa ritorno negli USA, stabilendosi nella Carolina del Nord dove diventa professore di letteratura latinoamericana alla Duke University di Durham.
Un romanziere (che scrive impeccabilmente in inglese ma la trama del cui pensiero mostra sotto traccia l’ossatura spagnola), un saggista, un drammaturgo di cui dovremmo conoscere qualcosa in più. Il 14 luglio scorso è ad esempio uscito, per i tipi delle Edizioni Clichy, il romanzo “Konfidenz”, un lavoro del 1994 che purtroppo arriva solo oggi al pubblico italiano. La storia, apparentemente semplice nella sua genialità, si svolge a Parigi nelle drammatiche ore in cui sta per avere inizio la Seconda guerra mondiale; ma come avviene quando si percepisce da lontano un incendio attraverso l’esile traccia di un odore, così la storia di “Konfidenz” è quella di avvenimenti sinistri che sono sul punto di accadere ma che ancora non sono avvenuti, ed essendo in potenza e non in atto se ne percepisce la foia, l’eccitazione libidinosa che preme nei pensieri prima di farsi carne. Attenzione, però, non è un romanzo di guerra e neppure è subito chiaro quando e dove la vicenda sia ambientata. Il lettore lo scopre un poco alla volta perché chi narra lo fa con la sagacia, a volte sadica, di chi ha il coltello dalla parte del manico.
In questo senso Dorfman è un virtuoso di quel particolare sentimento di incertezza che domina chi non conosce quale sarà la propria sorte; e, aggiungiamo, la storia narrata in “Konfidenz” è, in fondo, la mise en abyme di ciò che potrebbe accadere al lettore se, una volta smesso il ruolo di fruitore del testo, si trovasse lui medesimo nella situazione narrata. Una circostanza paradossale, che attinge al teatro dell’assurdo: in una camera d’albergo parigina, una donna appena giunta nella capitale francese da Berlino riceve una telefonata.
 All’altro capo del filo un uomo – forse il suo vero nome è Leon, forse Max – approccia un dialogo che durerà nove ore (il romanzo è per tre quarti dominato da questa lunghissima telefonata). Lei non sa nulla di lui, lui sembra sapere tutto di lei, ciò che le passa per la testa, le pieghe dei suoi abiti, la forma del suo seno, i sogni, le paure. Forse quelle cose che lui conosce sul conto della ragazza – si chiama Barbara, ma lui sovrappone all’identità della fanciulla quella di un’altra presenza femminile, Susanna, una donna che per decenni gli è apparsa in sogno – le ha apprese da Martin, il legittimo fidanzato di quella che a tutti gli effetti sembra la preda di un esperto cacciatore. Sembra. Perché in Dorfman “non è ancora detta la parola ultima” – io direi mai, e non a caso di Bertold Brecht, in esergo, si cita proprio questa sentenza –; il narratore gioca con se stesso, con il lettore e con i propri personaggi; lo fa con la malizia di un consumato postmodernismo senza mai però apparire gratuito. Il suo, cioè, non è un gioco per il gioco, non è un trucco per saggiare le potenzialità combinatorie della letteratura, quanto, piuttosto, una strategia molto seria per farci sentire in pericolo. Il lettore di “Konfidenz” (un’ironica “fiducia”?) percepisce, come i suoi personaggi, che non ci si può fidare di nessuno, che ognuno può passare dal ruolo di vittima a quello di carnefice senza soluzione di continuità, perché gli avvenimenti mutano di continuo, perché la combinazione degli eventi – quella sì – è un gioco crudele per gli esseri umani, oltre ad essere una dimostrazione della precarietà dell’esistenza.
All’altro capo del filo un uomo – forse il suo vero nome è Leon, forse Max – approccia un dialogo che durerà nove ore (il romanzo è per tre quarti dominato da questa lunghissima telefonata). Lei non sa nulla di lui, lui sembra sapere tutto di lei, ciò che le passa per la testa, le pieghe dei suoi abiti, la forma del suo seno, i sogni, le paure. Forse quelle cose che lui conosce sul conto della ragazza – si chiama Barbara, ma lui sovrappone all’identità della fanciulla quella di un’altra presenza femminile, Susanna, una donna che per decenni gli è apparsa in sogno – le ha apprese da Martin, il legittimo fidanzato di quella che a tutti gli effetti sembra la preda di un esperto cacciatore. Sembra. Perché in Dorfman “non è ancora detta la parola ultima” – io direi mai, e non a caso di Bertold Brecht, in esergo, si cita proprio questa sentenza –; il narratore gioca con se stesso, con il lettore e con i propri personaggi; lo fa con la malizia di un consumato postmodernismo senza mai però apparire gratuito. Il suo, cioè, non è un gioco per il gioco, non è un trucco per saggiare le potenzialità combinatorie della letteratura, quanto, piuttosto, una strategia molto seria per farci sentire in pericolo. Il lettore di “Konfidenz” (un’ironica “fiducia”?) percepisce, come i suoi personaggi, che non ci si può fidare di nessuno, che ognuno può passare dal ruolo di vittima a quello di carnefice senza soluzione di continuità, perché gli avvenimenti mutano di continuo, perché la combinazione degli eventi – quella sì – è un gioco crudele per gli esseri umani, oltre ad essere una dimostrazione della precarietà dell’esistenza.

Nella stanza d’albergo del cui arredamento non si sa quasi nulla, Barbara non parlerà mai con Martin, l’uomo che si sarebbe aspettata di trovare. Dialogherà invece con Leon (con Max). Lui di lei sa tutto perché la ama, perché la vuole proteggere, perché la vorrebbe portare a letto. Parlano della vita e della morte, della fragilità e delle cose che durano, di ciò che l’uomo può fare per l’altra e viceversa, di un dare-avere che fa costantemente riferimento a qualcosa che manca, a qualcosa che incombe, a qualcosa da cui occorre proteggersi, a un pericolo permanente. Quella che Dorfman sembra mettere in atto è una specie di semiosi illimitata, di catena di significanti sotto forma di allusioni, di parole dette a metà, che fanno riferimento a un segreto (politico? erotico?) che non può mai essere svelato fino in fondo, pena il rischio di sapere troppo e di compromettersi col nemico che ci spia in agguato (ma chi è esattamente?). Qualcuno, infatti, li sta cercando (i nazisti? i francesi che si oppongono alla Germania che ha appena stipulato con la Russia il patto Molotov-Ribbentrop? Chi è il bersaglio? I comunisti? Gli ebrei? I traditori della causa? Ma quale causa?); Martin stesso è scomparso perché qualcuno l’ha braccato, forse è un voltagabbana, forse no. Quella lunga telefonata è l’occasione per tessere storie dentro ad altre storie, come fece Sharazād (più volte citata nel testo) col sultano di Persia, e il romanzo si trasforma in una lunga dimostrazione di quanto possa essere potente la parola, di quanto essa possa stemperare l’innocenza nell’artificio, la cura dell’altro in un raffinato raggiro, la protezione nell’inganno, l’amore nell’ossessione sessuale, la fedeltà nei principi in un’infida cecità ideologica.

Erotismo e politica stanno alla base del testo: e Dorfman ci fa sentire quanto siano imparentati, i due concetti, colmi come sono di parole non dette, di versioni addolcite della verità, di menzogne profumate di passione, di compromessi fatti sparire tra le lenzuola o dietro un proclama, di paure che i sogni non possano mai incontrare la realtà. E Barbara (o Susanna) è per Leon, prima di ogni altra cosa, un sogno da preservare soprattutto quando l’urto con la realtà non ne può assicurare la sopravvivenza. Cosa che parallelamente avviene anche nell’ambito politico – i due temi vanno di pari passo, lo abbiamo detto – nel momento in cui la tanto organizzata resistenza contro il proliferare del nazismo si scontra con i fraintendimenti di quelli che si credono nostri compagni, con i campanilismi dei fratelli di fede, tanto miopi da non capire che se un uomo fa politica per amore lo fa perché, dopo, ci sia un mondo che possa meritare la presenza di quell’essere unico che è la donna amata – così dice Leon a Barbara – “perché il mondo fosse pulito, privo di sofferenza, quando ti saresti unita a me”.
Ma i sogni si infrangono perché ci sono altri che la pensano diversamente, oppure perché – e qui sta la vera tragedia – coloro per i quali i sogni sono stati costruiti non li riescono a comprendere. I sogni sono un passo in avanti, sono un balzo nel vuoto. Ci vuole amore per sognare. Così a volte non si riesce a fare quel salto perché c’è troppa sofferenza, perché paradossalmente ci si è innamorati del proprio dolore, del proprio rancore, del proprio scontento, del proprio sospetto, e si è persa la fiducia. Non ci si raccapezza più. Come avviene, per certi versi, al lettore di questo libro magnetico – non smetterete di leggerlo senza arrivare alla fine – in cui, come in un gioco a scatole cinesi, ogni attante della strategia testuale sembra avere un piano autonomo e diverso: il narratore ne ha uno per Leon, Leon ne ha uno per Barbara, Barbara uno per sé e per Martin, e gli uomini che verso la fine del libro irrompono nella stanza d’albergo nutrono un altro piano ancora. E infine ci sono, qua e là, quelle pagine scritte in corsivo che rappresentano una sorta di ‘voce fuori campo’ e che paiono l’ennesimo gioco testuale di Dorfman; invece – a mio parere – rappresentano non tanto un richiamo metanarrativo al lettore, quanto un surreale sdoppiamento del narratore che parla a se stesso, incoraggiandosi a dare alla storia una determinata piega e, allo stesso tempo, allertandolo della presenza subdola del lettore – l’uomo nell’ombra – che forse è destinato a sapere e a capire più di tutti quanti ciò che sta avvenendo, e a giudicare, col severo sadismo di un Grande Fratello invisibile, la miseria delle azioni umane.
Giacomo Verri, scrittore
Pubblicato giovedì 30 Luglio 2020
Stampato il 04/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/realta-contro-sogno/