 Vi sono circostanze in cui bisogna correre il rischio di apparire retorici, persino banali. La morte di Andrea Camilleri è appunto una di queste. È fin troppo scontato dire che abbiamo perso uno straordinario “contastorie” (così amava definirsi), un fascinoso affabulatore, (ma anche un sapiente sceneggiatore e un fine saggista) che si è guadagnato una vastissima popolarità in Italia e fuori d’Italia. Gli addetti ai lavori, gli esperti continueranno presumibilmente a lungo a discettare sulle qualità della narrativa di Camilleri, sulla sua capacità di coniugare letteratura alta e letteratura popolare, sulle innovazioni da lui introdotte nella collaudata formula del genere poliziesco, sul suo sperimentalismo linguistico, sul rapporto con la tradizione letteraria siciliana del Novecento e con i suoi più illustri esponenti (Pirandello e Sciascia in primo luogo). Forse meno ovvio è dire che con Camilleri se ne va una delle più autorevoli espressioni della coscienza democratica del nostro Paese, una figura alta e nobile dell’antifascismo militante (e so che l’aggettivo suonerà a molti esagerato).
Vi sono circostanze in cui bisogna correre il rischio di apparire retorici, persino banali. La morte di Andrea Camilleri è appunto una di queste. È fin troppo scontato dire che abbiamo perso uno straordinario “contastorie” (così amava definirsi), un fascinoso affabulatore, (ma anche un sapiente sceneggiatore e un fine saggista) che si è guadagnato una vastissima popolarità in Italia e fuori d’Italia. Gli addetti ai lavori, gli esperti continueranno presumibilmente a lungo a discettare sulle qualità della narrativa di Camilleri, sulla sua capacità di coniugare letteratura alta e letteratura popolare, sulle innovazioni da lui introdotte nella collaudata formula del genere poliziesco, sul suo sperimentalismo linguistico, sul rapporto con la tradizione letteraria siciliana del Novecento e con i suoi più illustri esponenti (Pirandello e Sciascia in primo luogo). Forse meno ovvio è dire che con Camilleri se ne va una delle più autorevoli espressioni della coscienza democratica del nostro Paese, una figura alta e nobile dell’antifascismo militante (e so che l’aggettivo suonerà a molti esagerato).
A scongiurare possibili equivoci, sarà bene precisare da subito che sarebbe fuorviante separare nettamente la presenza di Camilleri nel discorso pubblico dal suo ruolo di narratore. Ogni lettore non superficiale o distratto è in grado di riconoscere, nell’epopea minore ‒ perennemente sospesa fra dramma e commedia ‒ di Vigata, la grandi e irrisolte questioni del Mezzogiorno, in particolare postunitario; e di trovare evocati, nelle inchieste di Montalbano, alcuni fra i mali che hanno afflitto nell’ultimo venticinquennio, e affliggono tuttora, la società isolana e quella nazionale (la criminalità mafiosa, la piaga dell’affarismo, i flussi migratori, la corruzione dell’amministrazione statale, l’ottusità della burocrazia, la tenace sopravvivenza di arcaici pregiudizi, e altro ancora). A differenza della Sicilia di Sciascia, che col passare del tempo aveva perso progressivamente la sua identità di luogo storico-geografico per divenire metafora di una entità atemporale (il potere e le sue immutabili, spietate logiche), la Sicilia di Camilleri ha mantenuto i suoi tratti peculiari e si è però fatta specchio di una realtà più vasta.
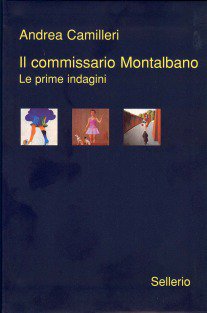 V’è di più. Il commissario Montalbano non si limita a prendere atto dello stato delle cose; lo analizza, lo interpreta, e infine lo giudica. Se vi è somiglianza fra personaggio e autore, essa non consiste in qualche comune abitudine (il piacere della buona cucina, a esempio), ma nella solidarietà con i deboli, nella pietas verso le vittime della violenza e del sopruso, nella coerenza con i propri principi morali, e quindi nella convinzione che non esiste alcuna meccanica equivalenza fra legge e giustizia, e che anzi l’affermazione della giustizia comporta talvolta l’infrazione (o quanto meno l’elusione) dei vincoli della legge. Tali affinità hanno impedito che le incursioni di Camilleri nel dibattito politico fossero percepite come stravaganti, indebite, velleitarie, addirittura strumentali: in fin dei conti, il commissario Montalbano la pensava come lui.
V’è di più. Il commissario Montalbano non si limita a prendere atto dello stato delle cose; lo analizza, lo interpreta, e infine lo giudica. Se vi è somiglianza fra personaggio e autore, essa non consiste in qualche comune abitudine (il piacere della buona cucina, a esempio), ma nella solidarietà con i deboli, nella pietas verso le vittime della violenza e del sopruso, nella coerenza con i propri principi morali, e quindi nella convinzione che non esiste alcuna meccanica equivalenza fra legge e giustizia, e che anzi l’affermazione della giustizia comporta talvolta l’infrazione (o quanto meno l’elusione) dei vincoli della legge. Tali affinità hanno impedito che le incursioni di Camilleri nel dibattito politico fossero percepite come stravaganti, indebite, velleitarie, addirittura strumentali: in fin dei conti, il commissario Montalbano la pensava come lui.
Per converso, Camilleri non ha mai dato l’impressione di approfittare della sua notorietà di scrittore (peraltro arrivata tardivamente, allo soglia dei sessant’anni) per ergersi a maître à penser e per impartire lezioni, diversamente dai suoi (tanti) colleghi che si promuovono a opinionisti e sproloquiano disinvoltamente ‒ non di rado a sproposito ‒ su tutto. Come i veri narratori, Camilleri era divenuto “persona di consiglio” (per dirla con Benjamin); eppure non ha mai sofferto di presenzialismo, mai ha posato a influencer o ‒ peggio ‒ sfruttato i mezzi di comunicazione di massa per appagare vanità narcisistiche. La sua voce si è ascoltata raramente, talora in occasioni del tutto spoglie di risonanza mediatica (chessò, una festa dell’Unità in un paesino della provincia siciliana), oppure in seguito a eventi da lui ritenuti di gravità tale da esigere una ferma presa di posizione; ma la modestia e la riservatezza hanno conferito maggior risalto alle sue denunce e alle sue censure. Forse la discrezione era figlia di un carattere naturalmente schivo; ma la generosità riveniva sicuramente dalla consapevolezza dei propri doveri di cittadino e delle proprie responsabilità di intellettuale. In altri termini, Camilleri ha messo la sua celebrità al servizio di una causa collettiva.
Camilleri si è professato ostinatamente «comunista all’italiana».

Il suo comunismo non era un’ideologia, men che meno una dottrina politica (non risulta che abbia mai auspicato l’instaurazione della dittatura del proletariato nel nostro Paese, o l’abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione); era piuttosto un sentimento, un paradigma morale, una religione civile, era la fede nei valori e negli ideali ereditati dalla Resistenza, gli stessi che stanno a fondamento della Costituzione repubblicana e antifascista: la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, l’emancipazione, la fratellanza, l’amicizia e la cooperazione fra i popoli. Perciò il crollo del socialismo reale non lo aveva indotto ad abiure, e neppure a radicali ripensamenti; credeva che quegli ideali e quei valori rimanessero pienamente attuali, che costituissero un patrimonio da custodire gelosamente, che andassero testimoniati senza deflettere o cedere allo sconforto. Non a caso negli ultimi anni i suoi appelli e i suoi moniti si erano fatti più frequenti, più appassionati: vedeva riapparire gli incubi del passato, riemergere un grumo oscuro di umori e di pulsioni ‒ nazionalismo, razzismo, xenofobia, intolleranza fanatica, accanto ai rigurgiti dichiaratamente fascisti ‒ che proietta la sua ombra minacciosa sul futuro. Camilleri ha replicato colpo su colpo alle manifestazioni più vistose di questa ondata retrograda, criticando aspramente il decreto sicurezza in nome del principio di accoglienza e del rispetto della persona umana, opponendo l’europeismo al sovranismo, difendendo l’insegnamento della storia nelle scuole e nelle università contro coloro che vorrebbero mutilare la memoria delle giovani generazioni, deprivarle della conoscenza critica di ciò che è stato.
 Questi interventi hanno procurato a Camilleri l’odio dei reazionari di ogni risma (che non lo ha risparmiato neppure nei giorni dell’agonia), le rampogne dei soliti soloni, i distinguo dei professori; ma gli insulti e le polemiche non lo avevano ridotto al silenzio. Egli ha continuato a parlare, sfidando ostilità e incomprensioni; e non perché utilizzasse come salvacondotto la stima e l’affetto dei suoi numerosissimi lettori, ma perché considerava un imperativo categorico proclamare a fronte eretta le sue idee, contribuire a una battaglia di civiltà e di progresso. Il suo esempio ha rappresentato una delle poche eccezioni in un panorama culturale dominato dal conformismo, dal nicodemismo, affollato di intellettuali che, se non scelgono la comoda veste di “consiglieri del principe”, si arroccano in una ipocrita equidistanza per timore di apparire faziosi, di compromettere il loro prestigio. E la sua coraggiosa milizia etico-civile costituisce un prezioso insegnamento per coloro che non si rassegnano alla marcia trionfale del populismo, e moltiplicano il loro impegno in favore della democrazia, dei diritti inalienabili degli individui, della pace. Di tutto questo gli antifascisti devono essere profondamente grati ad Andrea Camilleri.
Questi interventi hanno procurato a Camilleri l’odio dei reazionari di ogni risma (che non lo ha risparmiato neppure nei giorni dell’agonia), le rampogne dei soliti soloni, i distinguo dei professori; ma gli insulti e le polemiche non lo avevano ridotto al silenzio. Egli ha continuato a parlare, sfidando ostilità e incomprensioni; e non perché utilizzasse come salvacondotto la stima e l’affetto dei suoi numerosissimi lettori, ma perché considerava un imperativo categorico proclamare a fronte eretta le sue idee, contribuire a una battaglia di civiltà e di progresso. Il suo esempio ha rappresentato una delle poche eccezioni in un panorama culturale dominato dal conformismo, dal nicodemismo, affollato di intellettuali che, se non scelgono la comoda veste di “consiglieri del principe”, si arroccano in una ipocrita equidistanza per timore di apparire faziosi, di compromettere il loro prestigio. E la sua coraggiosa milizia etico-civile costituisce un prezioso insegnamento per coloro che non si rassegnano alla marcia trionfale del populismo, e moltiplicano il loro impegno in favore della democrazia, dei diritti inalienabili degli individui, della pace. Di tutto questo gli antifascisti devono essere profondamente grati ad Andrea Camilleri.
Ferdinando Pappalardo, già docente presso l’Università degli Studi di Bari, già parlamentare, coordinatore Anpi Puglia, componente del Comitato nazionale Anpi
Pubblicato venerdì 26 Luglio 2019
Stampato il 01/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/cittadinanza-attiva/camilleri-sono/






