 Un merito indiscutibile delle celebrazioni degli anniversari di importanti eventi del passato consiste nello stimolo al dibattito tra gli storici e nella sollecitazione a un riesame critico dei fatti, indispensabile per sottrarsi alla mera dimensione rievocativa: considerazioni critiche che non di rado hanno revocato in dubbio interpretazioni consolidate attraverso l’apertura di nuovi campi di indagine e la ridefinizione dei paradigmi tradizionali, suscitando discussioni che sono andate spesso oltre la cerchia degli addetti ai lavori.
Un merito indiscutibile delle celebrazioni degli anniversari di importanti eventi del passato consiste nello stimolo al dibattito tra gli storici e nella sollecitazione a un riesame critico dei fatti, indispensabile per sottrarsi alla mera dimensione rievocativa: considerazioni critiche che non di rado hanno revocato in dubbio interpretazioni consolidate attraverso l’apertura di nuovi campi di indagine e la ridefinizione dei paradigmi tradizionali, suscitando discussioni che sono andate spesso oltre la cerchia degli addetti ai lavori.
Un esempio eclatante, negli ultimi anni, è stato il centenario della Grande guerra: le celebrazioni, come ricordava Giovanni De Luna nel convegno “Il fascismo di confine e il dramma delle foibe” promosso dal Comitato nazionale Anpi e dal Coordinamento regionale Friuli-Venezia Giulia (4 gennaio 2020), hanno ripercorso la vicenda bellica attraverso un vero e proprio capovolgimento della prospettiva tradizionale, con uno sguardo non più concentrato esclusivamente sulla politica, la diplomazia, l’azione dei comandi militari, ma rivolto alle trincee, ai soldati di ambo le parti, al loro vissuto, ai traumi e alle sofferenze di un conflitto che ha mutato la prospettiva esistenziale di tutti i suoi protagonisti e ha sconvolto equilibri sociali consolidati, aprendo la strada ai successivi drammi del 900.
In questa ottica di riflessione critica sul “secolo breve” si colloca anche il convegno del 19 gennaio scorso che l’Anpi nazionale, in collaborazione con l’Anpi del Friuli Venezia Giulia, ha organizzato in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’aggressione italiana alla Jugoslavia: 1941, l’aggressione: l’Italia fascista in Jugoslavia.

Un convegno tanto più significativo in quanto tra i suoi promotori rientra anche l’associazione partigiana slovena Zzb Nob (Unione delle associazioni combattenti per la liberazione nazionale) il cui presidente Marijan Križman, ha portato un saluto all’iniziativa, nonché la Saba (Alleanza delle associazioni combattenti antifasciste della Croazia), presieduta da Franjo Habulin, che ha inviato un messaggio di adesione, e in quanto ha visto un confronto tra studiosi croati, italiani, sloveni, segno tangibile dell’intento di abbandonare definitivamente (lo ha sottolineato il presidente nazionale Anpi, Gianfranco Pagliarulo, nelle sue conclusioni) quel punto di vista nazionale che è stato alla base di molte distorsioni e di numerose omissioni nella ricostruzione delle vicende del confine italo-sloveno.

Nel merito, il dibattito ha mostrato la validità di un approccio transnazionale – che indica percorsi di approfondimento innovativi e di grande interesse – e l’utilità di un dialogo tra storici che, come ha ricordato nella sua introduzione il coordinatore dell’Anpi Friuli Venezia Giulia Dino Spanghero, è emblematico di una frontiera aperta, nel contesto di un’Europa dei popoli e delle regioni.
Il convegno si è svolto a poco meno di un mese dal Giorno del ricordo e, a tale proposito, non si può certo disconoscere il contributo che le giornate commemorative istituite con legge dello Stato hanno dato a una migliore e più consapevole conoscenza di avvenimenti che hanno plasmato il nostro presente, a partire dal Giorno della Memoria.
 E tale si può considerare anche la funzione del Giorno del ricordo, istituito diciassette anni or sono, con la legge n. 92 del 2004: con una differenza non trascurabile però, dato che, mentre gli effetti della legge istitutiva del Giorno della Memoria si sono rivelati coerenti con l’intento dei promotori, il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata, ha sortito un effetto se non opposto, certo divergente dall’intento originario dei proponenti, ovvero delle forze politiche appartenenti all’area del centrodestra, intenzionate a ritagliare dalle vicende dei territori alto adriatici tra il 1943 e il 1945 un proprio ambito memoriale esclusivo e un proprio martirologio distinto e contrapposto a quello resistenziale, e a tracciare un confine non oltrepassabile, per delegittimare chiunque avesse inteso proporre una diversa e più meditata versione di eventi sull’interpretazione dei quali i promotori della legge continuano ad accampare un’irragionevole pretesa di monopolio.
E tale si può considerare anche la funzione del Giorno del ricordo, istituito diciassette anni or sono, con la legge n. 92 del 2004: con una differenza non trascurabile però, dato che, mentre gli effetti della legge istitutiva del Giorno della Memoria si sono rivelati coerenti con l’intento dei promotori, il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata, ha sortito un effetto se non opposto, certo divergente dall’intento originario dei proponenti, ovvero delle forze politiche appartenenti all’area del centrodestra, intenzionate a ritagliare dalle vicende dei territori alto adriatici tra il 1943 e il 1945 un proprio ambito memoriale esclusivo e un proprio martirologio distinto e contrapposto a quello resistenziale, e a tracciare un confine non oltrepassabile, per delegittimare chiunque avesse inteso proporre una diversa e più meditata versione di eventi sull’interpretazione dei quali i promotori della legge continuano ad accampare un’irragionevole pretesa di monopolio.
 Nei fatti, dunque, l’istituzione del Giorno del ricordo ha promosso un diffuso impegno di ricerca che non solo è andato in una direzione diversa da quella auspicata dai proponenti, ma ha contribuito a mettere a fuoco le cause remote e quelle più immediate degli eccidi ricondotti sotto la comune denominazione delle “foibe” istriane e giuliane, ricollocandoli nel contesto dell’intreccio di tensioni e di contraddizioni maturate nel corso di decenni e portate alle estreme conseguenze durante il secondo conflitto mondiale.
Nei fatti, dunque, l’istituzione del Giorno del ricordo ha promosso un diffuso impegno di ricerca che non solo è andato in una direzione diversa da quella auspicata dai proponenti, ma ha contribuito a mettere a fuoco le cause remote e quelle più immediate degli eccidi ricondotti sotto la comune denominazione delle “foibe” istriane e giuliane, ricollocandoli nel contesto dell’intreccio di tensioni e di contraddizioni maturate nel corso di decenni e portate alle estreme conseguenze durante il secondo conflitto mondiale.
L’esatto opposto dell’intento originario, di isolare gli eventi del 1943-45 in una narrazione circoscritta al conflitto ideologico e nazionale tra comunisti jugoslavi e “italiani” senza ulteriori distinzioni.
 Chi ha adottato un approccio diverso e critico (da ultimo il bel lavoro di Eric Gobetti, E allora le foibe?), chi sulla base di un esame non assolutorio delle politiche repressive adottate dal regime jugoslavo, ha confutato, per citare una delle questioni più controverse, l’opinione che le foibe abbiano costituito una scelta di pulizia etnica antitaliana (il che non rende meno gravi gli eccidi né meno severa la condanna), è liquidato come “negazionista” e diviene oggetto di anatemi e vituperi, lanciati con un clamore che però non serve a nascondere un dato di fatto: nei diciassette anni trascorsi dall’adozione della legge n. 92, dagli ambienti che l’hanno promossa non è venuto alcuno studio degno di questo nome, ma soltanto slogan nazionalisti e provocazioni contro croati e sloveni, accompagnati da una macabra ragioneria della morte, che riduce le vittime a numeri anonimi, quando invece sarebbero ancora necessarie ricerche approfondite per restituire loro identità e quindi dignità e, al tempo stesso, per dare un volto e un nome ai carnefici.
Chi ha adottato un approccio diverso e critico (da ultimo il bel lavoro di Eric Gobetti, E allora le foibe?), chi sulla base di un esame non assolutorio delle politiche repressive adottate dal regime jugoslavo, ha confutato, per citare una delle questioni più controverse, l’opinione che le foibe abbiano costituito una scelta di pulizia etnica antitaliana (il che non rende meno gravi gli eccidi né meno severa la condanna), è liquidato come “negazionista” e diviene oggetto di anatemi e vituperi, lanciati con un clamore che però non serve a nascondere un dato di fatto: nei diciassette anni trascorsi dall’adozione della legge n. 92, dagli ambienti che l’hanno promossa non è venuto alcuno studio degno di questo nome, ma soltanto slogan nazionalisti e provocazioni contro croati e sloveni, accompagnati da una macabra ragioneria della morte, che riduce le vittime a numeri anonimi, quando invece sarebbero ancora necessarie ricerche approfondite per restituire loro identità e quindi dignità e, al tempo stesso, per dare un volto e un nome ai carnefici.
Il fatto è che qualcuno, sia in ambito politico, sia nel mondo dell’associazionismo democratico, sia nel mondo della ricerca, ha preso sul serio alcune affermazioni contenute nella legge n. 92 e in particolare l’impegno a conoscere meglio la “complessa vicenda del confine orientale” (art. 1). Ma già l’espressione “confine orientale” contiene in sé un’ambiguità, perché definisce, non solo geograficamente, un punto di vista – quello italiano – e stabilisce in tal modo una implicita differenza gerarchica tra chi osserva e chi, situato al di là di quel confine, è osservato, e considerato pertanto oggetto e non soggetto di storia. E la portata di questa ambiguità si svela nelle righe successive, quando l’asserita “complessità” della vicenda ricordata viene circoscritta all’identità italiana e al contributo degli italiani “negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica” e nella salvaguardia delle tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero.
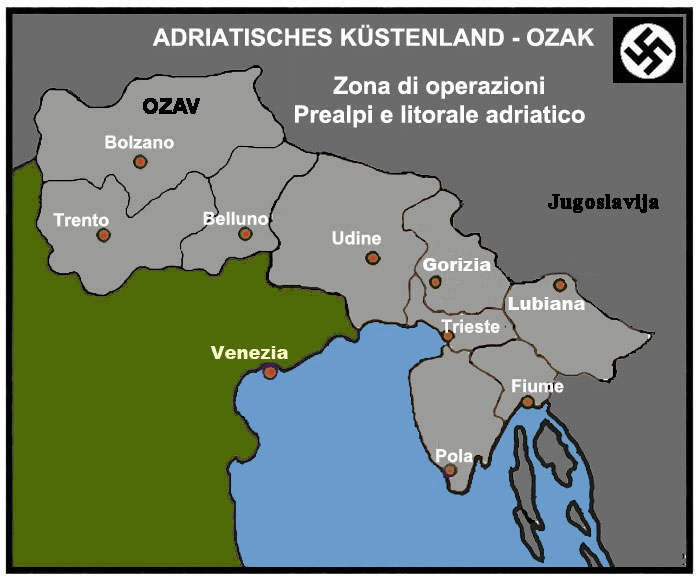
In altri termini, la legge n. 92 non si limita a dire che occorre ricordare, ma dice anche quali fatti devono essere ricordati, implicitamente invitando (per non dire obbligando) a dimenticarne altri. E, in particolare, per quello che ci riguarda, invita all’oblio proprio di quei fatti che giustificano l’uso del termine “complessità” per qualificare la vicenda del confine italo-sloveno (così preferiamo chiamarlo): circostanza, idee e personaggi da inquadrare in un contesto nel quale, tra la fine del XIX secolo e la metà del secolo scorso, su un medesimo territorio, si sono alternati momenti di cooperazione a momenti di conflitto tra italiani, sloveni e croati (come peraltro già vent’anni or sono ricordava la Commissione storica italo-slovena); nel quale, nei momenti di conflitto (innescati il più delle volte dalla torsione nazionalistica dell’irredentismo italiano) le differenze linguistiche e religiose si sono intrecciate e si sono sovrapposte a quelle sociali e politiche; nel quale, infine, proprio questa pluralità di tensioni ha fatto sì che nell’area alto adriatica, tra il 1943 e il 1945, l’aggressione delle potenze dell’Asse, il sorgere della Resistenza jugoslava e poi italiana, l’interazione della questione nazionale con il quadro generale della guerra antifascista conducessero verso esiti particolarmente cruenti.
L’aggressione italiana alla Jugoslavia è un fattore imprescindibile per la comprensione della “complessità” della vicenda dell’area alto adriatica, e offre numerosi spunti di riflessione, messi in rilievo da tutti gli intervenuti al convegno. In primo luogo, essa è l’esito di un processo apertosi all’indomani della fine della prima guerra mondiale e con il crollo degli imperi centrali e, in particolare, dell’impero asburgico: lungi dal realizzare il sogno di matrice mazziniana dell’interventismo democratico, di una Europa fondata sul principio dell’autodeterminazione dei popoli (che peraltro era stata anche una parola d’ordine della rivoluzione bolscevica), la fine degli imperi centrali consentì da un lato la realizzazione di aspirazioni secolari all’indipendenza dei popoli del centro Europa, ma dall’altro diede vita a compagini statali nelle quali, a fianco del gruppo nazionale egemone, convivevano consistenti minoranze, nel seno delle quali si sarebbero prodotti fenomeni di irredentismo destinati ad alimentare rivendicazioni indipendentiste e insieme aspirazioni espansioniste degli stati limitrofi (il caso più eclatante è quello dei Sudeti) nonché tensioni nei rapporti tra stati di vecchia e nuova formazione.

Come ha ricordato il prof. Jože Pirjevec, dell’Accademia delle Scienze slovena, per l’Italia vittoriosa nel 1918, la nascita del Regno dei serbi, dei croati e degli sloveni, poi Jugoslavia, costituì un’amara sorpresa, dato che la nuova entità statale smentiva le intese raggiunte con il Patto di Londra, stipulato dal governo Salandra con gli alleati, nel quale si prevedeva un’egemonia italiana incontrastata nell’area adriatica e nei Balcani: la delusione per l’insorgere di una scenario che frustrava gli ideali imperiali coltivati dalle classi dirigenti italiane sarebbe stata alla base del mito della “vittoria mutilata”, nonché della scelta di adottare una politica volta ad affermare la prevalenza dell’elemento nazionale italiano sulla popolazione croata e slovena residente nei territori annessi in seguito al trattato di pace, politica già manifestatasi nel periodo liberale, e portata alle sue estreme conseguenze con la nascita del “fascismo di confine”.

Quest’ultimo, come ha ricordato nel suo intervento il prof. Borut Klabjan (Science and Research Centre Koper, Institut for Historical Sciences), fu caratterizzato fin dalla nascita da una particolare fisionomia nella quale i tratti violenti dello squadrismo si alimentavano di un nazionalismo esasperato e di un altrettanto esasperato razzismo antislavo, ampiamente propagandato dallo stesso Mussolini in diversi discorsi pubblici, e precursore delle politiche segregazioniste che avrebbero caratterizzato il colonialismo fascista e della legislazione antisemita del 1938. Nella sua relazione, il prof. Pirjevec ha messo in luce un altro elemento, non sempre adeguatamente considerato, riguardante l’andamento delle relazioni tra Italia e Jugoslavia: se infatti nei territori annessi il regime fascista attuò una decisa politica di snazionalizzazione, di repressione e di italianizzazione forzata, che determinò tra l’altro un forte flusso migratorio verso la Jugoslavia, nei rapporti tra i due stati momenti di aperta ostilità si alternarono con momenti di distensione, culminati negli accordi Ciano-Stojadinović (1937). La ricerca di un accordo con la Jugoslavia, però, era dettata dalla comune esigenza di fare fronte all’aggressivo espansionismo della Germania nazista, intenzionata a includere la Jugoslavia nella sua sfera d’influenza.

I mesi che precedettero l’invasione della Jugoslavia dimostrano chiaramente come essa fosse oggetto anche di una rivalità tra le due potenze dell’Asse, e come l’Italia versasse in una posizione subordinata, aggravata dall’esito catastrofico del tentativo di invasione della Grecia, e dal conseguente fallimento della cosiddetta “guerra parallela”, che aveva accresciuto la dipendenza dell’Italia dal più potente alleato, estremamente contrariato dalle avventure di Mussolini nei Balcani.
Un altro punto di forza del convegno è stato l’avere messo a fuoco un tema molto rilevante nella ricostruzione dei rapporti tra occupanti e occupati: il ruolo degli opposti sciovinismi croato e serbo, che aggiungono un elemento peculiare al quadro generale del conflitto.

Dei cetnici, i combattenti monarchici serbi guidati dal generale Mihajlovic, ha parlato il prof. Ivo Goldstein, richiamando il fallimento del tentativo di accreditarsi presso gli alleati come rappresentanti della resistenza antinazista (nonostante il riconoscimento da parte del governo jugoslavo in esilio), la rottura e il conflitto con il movimento partigiano di Tito, i progetti di pulizia etnica, fino al collaborazionismo con gli italiani, in posizione di conflitto con lo stato fantoccio croato di Ante Pavelić.

Di quest’ultimo, e della difficile e innaturale alleanza con l’Italia fascista, ha dato conto lo storico Eric Gobetti, ricordando il sostegno accordato al movimento separatista e filofascista croato degli ustascia dal governo italiano alla fine degli anni 20, la successiva inversione di rotta dopo l’assassinio del re Alessandro di Jugoslavia da parte di terroristi croati, la chiusura dei campi di addestramento in Italia negli anni 30 e poi, dopo l’invasione, fallito il tentativo di appoggiarsi ad altre forze politiche, la scelta di Ante Pavelić come capo dello stato fantoccio di Croazia, con un sovrano di Casa Savoia, Aimone (che assunse il nome di Tomislav II) che si guardò bene dal prendere possesso del suo regno, stabilendo prudentemente la sua corte in una villa fiorentina.

Resta il fatto che, nel contesto generale della lotta tra gli occupanti nazifascisti e il movimento di liberazione jugoslavo, il conflitto tra le nazionalità, con tutta l’efferatezza che si è riproposta poi nei conflitti degli anni 90 e con la propensione a mutare la geometria delle alleanze e ad appoggiarsi ora all’uno ora all’altro dei contendenti per mantenere un minimo spazio di manovra (pagato a caro prezzo dalla popolazione civile), produsse un surplus di violenza in un contesto nel quale l’occupazione italiana – all’inizio accolta come il minor male dalla popolazione slovena e caratterizzata inizialmente anche da una certa indipendenza dai tedeschi, come mostra l’episodio, ricordato anche dal presidente dell’Anpi nelle sue conclusioni, del rifiuto di consegnare gli ebrei sloveni e croati ai nazisti – si fece sempre più aspra con il rafforzarsi, in parallelo, della Resistenza slovena, giungendo ad attuare una vera e propria guerra ai civili, contrassegnata da rappresaglie, presa di ostaggi, incendi di villaggi e soprattutto dalla deportazione della popolazione civile.

Una delle pagine più oscure della storia d’Italia, questa, ricordata puntualmente dal prof. Carlo Spartaco Capogreco, in un intervento che ha ricostruito la vicenda degli internamenti di donne, bambini, anziani nei campi di Arbe, Gonars, Cairo Montenotte (per citare solo i più noti), reclusi in condizioni inumane, con un tasso di mortalità per fame e malattie che emulava i campi di concentramento e sterminio dell’alleato tedesco.

Nella ricostruzione del biennio di occupazione italiana della Slovenia non solo va in pezzi la retorica degli “italiani brava gente”, ma si coglie anche un quadro d’insieme nel quale qualsiasi episodio, comprese le foibe istriane del 1943 e le foibe giuliane del 1945, si colloca al crocevia di spinte e controspinte prodotte da un intreccio di fattori internazionali, nazionali, regionali e insieme sociali, politici e militari, difficile da districare.

Anche per i movimenti di Resistenza italiano e sloveno, i cui rapporti non casualmente alternano momenti di collaborazione a momenti di conflitto che investono e condizionano anche l’orientamento spontaneamente antifascista del movimento operaio dell’area triestina, su cui ha riferito la storica Anna Di Gianantonio.

La fine della guerra, peraltro, non segna la conclusione della tormentata vicenda del confine italo-jugoslavo: che esso dovesse essere rivisto in favore di una delle nazioni vincitrici (la Jugoslavia) e con la restituzione di una porzione significativa dei territori annessi nel 1918 da parte dell’Italia, nazione sconfitta, era una questione pacifica, ampiamente riconosciuta non solo dagli alleati ma da tutti gli antifascisti italiani.
 Meno lineari, come ha spiegato nel suo intervento Federico Tenca Montini, dottore di ricerca in storia contemporanea, furono le modalità con cui si pervenne a una prima definizione di un confine non solo politico, ma anche ideologico, lungo il quale le tensioni della guerra fredda si sarebbero manifestate prematuramente.
Meno lineari, come ha spiegato nel suo intervento Federico Tenca Montini, dottore di ricerca in storia contemporanea, furono le modalità con cui si pervenne a una prima definizione di un confine non solo politico, ma anche ideologico, lungo il quale le tensioni della guerra fredda si sarebbero manifestate prematuramente.

Emblematici, a tal proposito, furono gli avvenimenti della primavera 1945: il 1° maggio, la IV Armata dell’Esercito popolare di liberazione della Jugoslavia si rivelò vincitrice per un solo giorno di quella che gli storici definiscono “corsa per Trieste”.
Il giorno successivo, infatti, la città fu raggiunta da reparti dell’VIII Armata britannica e, solo quaranta giorni dopo, l’esercito di liberazione jugoslavo accettò di ritirarsi oltre la linea Morgan (con la quale si creava un zona “A” sotto l’amministrazione anglo-americana e una zona “B” amministrata dalla Jugoslavia), dopo un periodo di occupazione durante il quale si verificarono quei fenomeni di violenza indiscriminata che portarono non solo alla punizione dei collaborazionisti, ma si rivolsero anche contro coloro che, italiani o meno, compresi non pochi antifascisti, avevano manifestato la loro opposizione al processo attraverso il quale – come si legge nel documento della Commissione storica italo-slovena – un movimento di liberazione nazionale si andava rapidamente trasformando in regime.
Dal trattato di pace fino al trattato di Osimo (1975), le relazioni italo-jugoslave hanno risentito profondamente del clima della guerra fredda, e sono state fortemente condizionate anche dalla rottura che, nel 1948, collocò il regime di Tito fuori dal blocco orientale, avvicinandolo alle potenze occidentali. Ciò accadde proprio quando queste ultime, alla vigilia delle elezioni del 18 aprile 1948, si erano compromesse impegnandosi a consegnare all’Italia l’intera zona A, all’interno della quale con il trattato di pace del 1947, era stato creato il Territorio libero di Trieste.
A fare le spese di queste incertezze furono le popolazioni dell’area alto adriatica: gli italiani costretti dall’ostilità del governo jugoslavo a un esilio quanto mai doloroso, ma anche gli sloveni rimasti all’interno del confine italiano, oggetto di intimidazioni e vessazioni da parte di gruppi neofascisti. L’aggressione italiana alla Jugoslavia portò dunque alle sue estreme conseguenze tensioni e conflitti che da tempo travagliavano i territori annessi dopo il 1918, umiliati e vessati dalla ventennale politica di italianizzazione forzata del regime fascista.
Al tempo stesso, fu l’inizio della fine di una vicenda che, nel giro di pochi anni, precipitò verso il suo drammatico esito, lasciando dietro di sé una scia di rancori, incomprensioni e diffidenze sulla quale ancora oggi si rende necessaria una riflessione che ne colga i diversi aspetti e le molteplici implicazioni.
Per l’Italia, il silenzio e le reticenze sui crimini di guerra del fascismo e la mancanza di quella che è stata definita una “Norimberga italiana”, hanno lasciato prevalere per molto tempo una propensione alla rimozione di un passato ingombrante, con il quale non sono mai stati fatti i conti fino in fondo. Iniziative come il convegno promosso dall’Anpi, del quale è auspicabile una prossima pubblicazione degli atti, possono contribuire a evitare che le lacune della memoria diano luogo a letture distorte e parziali del presente, e che la storia del ‘900 divenga non già un campo aperto all’indagine, al dialogo e al confronto, ma un territorio reclamato da diversi contendenti, in una guerra ideologica nella quale l’unica vittima certa è la verità.
Pubblicato giovedì 4 Febbraio 2021
Stampato il 15/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/longform/confine-orientale-primum-non-omettere/







