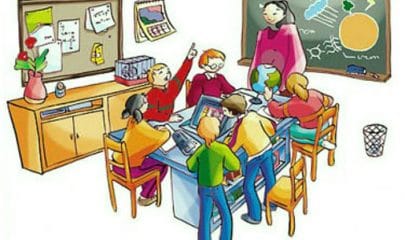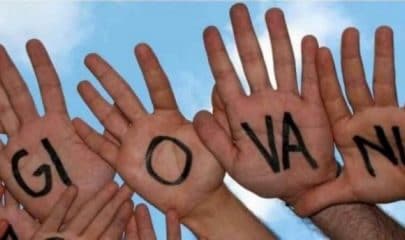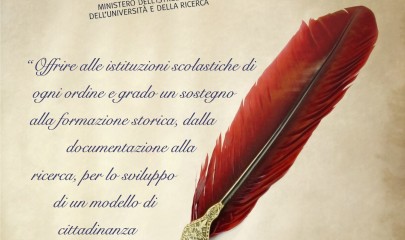La posizione di Lega e Movimento Cinque Stelle sulla scuola ha subito notevoli oscillazioni. Durante la campagna elettorale, Salvini e Di Maio hanno tuonato all’unisono contro la legge 107/15 (quella, per intendersi, della “Buona Scuola”), promettendone l’abrogazione. Ma il capo politico pentastellato si è spinto oltre: dopo aver aggiunto la sua voce alla ipocrita salmodia ‒ recitata da tutti i partiti indistintamente nell’ultimo ventennio ‒ sul ruolo decisivo dell’istruzione per i destini del Paese, ha assicurato che, qualora fosse andato al governo, avrebbe aumentato le retribuzioni dei docenti fino ad allinearle alla media dei paesi UE. Di questi impegni non è rimasta traccia nelle dichiarazioni programmatiche rese alle Camere dal professor Conte, che anzi ha celebrato i meriti dell’attuale sistema formativo («Le nostre scuole e università sono in grado di formare eccellenze assolute in tutti i settori»), lasciando quasi intendere che non vi è nulla da cambiare. Forse la retromarcia è apparente, e si deve attribuire alla “fumosità” (secondo molti opinionisti) del discorso del Presidente del Consiglio; ma poiché egli ama rappresentarsi come il ligio esecutore dell’accordo stipulato fra le due forze di maggioranza, per chiarirsi le idee converrà fare riferimento alle linee di politica scolastica enunciate nel “contratto”. (Per inciso: l’università è ignorata, se si eccettua un accenno di Conte alla necessità di arrestare la “fuga dei cervelli”.)
Il paragrafo a essa dedicato si apre con una dichiarazione tanto solenne quanto impegnativa: «La scuola italiana ha vissuto in questi anni momenti di grave difficoltà. Dopo le politiche dei tagli lineari e del risparmio, l’istruzione deve tornare al centro del nostro sistema Paese». Per la verità, da noi la crisi delle istituzioni formative dura da un tempo molto più lungo; ma il riferimento temporale contenuto nel “contratto” serve a far capire che il termine di confronto polemico è costituito dalla “Buona Scuola”, le cui misure sono giudicate «insufficienti e spesso inadeguate», e che occorre perciò superare «con urgenza». Le priorità del «necessario cambio di rotta» sono individuate nella eliminazione delle “classi pollaio” (cioè con un numero eccessivo di studenti), nel potenziamento dell’edilizia scolastica, nella revisione dei criteri di composizione delle graduatorie, nella rideterminazione dei titoli richiesti per l’insegnamento, nella soluzione del «problema del precariato nella scuola dell’infanzia e nella primaria», nella modifica del sistema di reclutamento dei docenti, in una diversa disciplina dei trasferimenti (finalizzata a favorire la continuità didattica).
 Se ne deduce che l’esecutivo giallo-verde assume a stella polare della sua politica scolastica la formazione ‒ a monte e a valle: dunque anche ricorrente ‒ dei docenti, nella convinzione che la «buona qualità dell’insegnamento» rappresenta «una condizione indispensabile per la corretta formazione dei nostri ragazzi». A corollario, viene affermata l’intenzione di adottare «strumenti efficaci che assicurino e garantiscano» (pleonasmo con evidente valore rafforzativo) «l’inclusione per tutti gli alunni, con maggiore attenzione a coloro che presentano disabilità più o meno gravi, ai quali va garantito lo stesso insegnante per l’intero ciclo»; e ciò anche per «limitare la dispersione scolastica». Ebbene, tutti gli obiettivi in precedenza richiamati sono condivisibili; altrettanto condivisibili sono le critiche ad alcuni punti della legge 107/15, in particolare a quelli relativi alla «possibilità della “chiamata diretta” dei docenti da parte del dirigente scolastico» (che assegna a questa figura un potere discrezionale così ampio da sconfinare nell’arbitrio), e all’alternanza scuola-lavoro (esperimento forse non «dannoso», come lo definisce il testo del “contratto”, ma sicuramente fallimentare). Ma soprattutto va apprezzata la volontà di accrescere gli investimenti nel sistema formativo; se alle parole seguiranno i fatti, se le risorse accessorie saranno cospicue e regolarmente erogate (diversamente da quanto è accaduto negli ultimi anni), ci troveremo in presenza di una salutare inversione di tendenza.
Se ne deduce che l’esecutivo giallo-verde assume a stella polare della sua politica scolastica la formazione ‒ a monte e a valle: dunque anche ricorrente ‒ dei docenti, nella convinzione che la «buona qualità dell’insegnamento» rappresenta «una condizione indispensabile per la corretta formazione dei nostri ragazzi». A corollario, viene affermata l’intenzione di adottare «strumenti efficaci che assicurino e garantiscano» (pleonasmo con evidente valore rafforzativo) «l’inclusione per tutti gli alunni, con maggiore attenzione a coloro che presentano disabilità più o meno gravi, ai quali va garantito lo stesso insegnante per l’intero ciclo»; e ciò anche per «limitare la dispersione scolastica». Ebbene, tutti gli obiettivi in precedenza richiamati sono condivisibili; altrettanto condivisibili sono le critiche ad alcuni punti della legge 107/15, in particolare a quelli relativi alla «possibilità della “chiamata diretta” dei docenti da parte del dirigente scolastico» (che assegna a questa figura un potere discrezionale così ampio da sconfinare nell’arbitrio), e all’alternanza scuola-lavoro (esperimento forse non «dannoso», come lo definisce il testo del “contratto”, ma sicuramente fallimentare). Ma soprattutto va apprezzata la volontà di accrescere gli investimenti nel sistema formativo; se alle parole seguiranno i fatti, se le risorse accessorie saranno cospicue e regolarmente erogate (diversamente da quanto è accaduto negli ultimi anni), ci troveremo in presenza di una salutare inversione di tendenza.
C’è da essere soddisfatti, dunque? Non proprio; il pacchetto di interventi per la scuola annunciato nel “contratto” appare parziale, addirittura minimalista, figlio di una cultura piattamente pragmatica, e per giunta influenzato dagli slogan propagandistici della campagna elettorale (davvero si crede che sia sufficiente la cancellazione, o una radicale riscrittura, della “Buona Scuola” per guarire il sistema formativo dai suoi numerosi, antichi mali?): tanto da confermare le malevole previsioni di coloro che assegnano una vita breve all’esecutivo giallo-verde. I provvedimenti di politica scolastica che il nuovo governo si propone di attuare sono visibilmente tarati sulla ‒ se non proprio circoscritti alla ‒ scuola dell’obbligo; ma chiunque abbia un minimo d’esperienza del settore, sa bene che i problemi più spinosi riguardano l’istruzione secondaria di secondo grado. Per affrontarli efficacemente, e per marcare una reale discontinuità con il passato, occorre rispondere preliminarmente a un interrogativo: il modello aziendalistico di organizzazione del sistema formativo e la concezione utilitaristica del sapere (quella, per intendersi, riassunta nel celebre motto tremontiano “con la cultura non si mangia”), cui si è ispirata ‒ seppure con accentuazioni differenti ‒ la legislazione scolastica dell’ultimo quindicennio, e che derivano entrambi dall’imperante mantra economicistico, sono realmente in grado di assecondare la crescita di una fra le prime potenze industriali del pianeta, e contribuiscono a creare le condizioni per un pieno esercizio della cittadinanza?
 Più nel dettaglio: siamo sicuri che la proliferazione degli indirizzi degli studi secondari di secondo grado, e la loro accentuata specializzazione, producano un capitale umano adeguato alle sfide della società della conoscenza, dove si registra un crescente calo di possibilità occupazionali per le professioni meno qualificate? Stando ai dati a disposizione, soltanto il 42% dei nostri diplomati si iscrive all’università (a fronte del 63% della media dei Paesi UE), e il 38,7% (di questi, oltre il 45% proveniente dagli istituti professionali) abbandona gli studi prima del termine; la nostra percentuale di laureati è più bassa della media dei paesi UE (24% contro 37%). Questa desolante situazione dipende certamente dall’assenza di una seria politica del diritto allo studio: ma in quale misura incide il fatto che i ragazzi (e le loro famiglie) sono precocemente costretti a compiere una scelta che ipoteca in buona misura il loro futuro lavorativo? Ancora: indirizzare i processi formativi verso l’acquisizione di specifiche abilità professionali, a fronte di un mercato del lavoro in vertiginosa evoluzione (anche per effetto del progresso tecnologico), non provoca un’asimmetria fra domanda e offerta, e non pregiudica le prospettive di mobilità verticale e orizzontale? Infine: non vi è il rischio che la scuola del “saper fare” abdichi al compito di educare al pensiero critico?
Più nel dettaglio: siamo sicuri che la proliferazione degli indirizzi degli studi secondari di secondo grado, e la loro accentuata specializzazione, producano un capitale umano adeguato alle sfide della società della conoscenza, dove si registra un crescente calo di possibilità occupazionali per le professioni meno qualificate? Stando ai dati a disposizione, soltanto il 42% dei nostri diplomati si iscrive all’università (a fronte del 63% della media dei Paesi UE), e il 38,7% (di questi, oltre il 45% proveniente dagli istituti professionali) abbandona gli studi prima del termine; la nostra percentuale di laureati è più bassa della media dei paesi UE (24% contro 37%). Questa desolante situazione dipende certamente dall’assenza di una seria politica del diritto allo studio: ma in quale misura incide il fatto che i ragazzi (e le loro famiglie) sono precocemente costretti a compiere una scelta che ipoteca in buona misura il loro futuro lavorativo? Ancora: indirizzare i processi formativi verso l’acquisizione di specifiche abilità professionali, a fronte di un mercato del lavoro in vertiginosa evoluzione (anche per effetto del progresso tecnologico), non provoca un’asimmetria fra domanda e offerta, e non pregiudica le prospettive di mobilità verticale e orizzontale? Infine: non vi è il rischio che la scuola del “saper fare” abdichi al compito di educare al pensiero critico?
Il programma dell’esecutivo giallo-verde elude queste (e altre, che qui si omettono per esigenze di brevità) domande, e preferisce attenersi a un profilo basso, empirico: che tradisce forse prudenza, forse difficoltà di sintesi, forse limitatezza di idee (sospetto, quest’ultimo, suffragato dalla riduzione della cultura ‒ nel paragrafo del “contratto” a essa riservato ‒ ai beni culturali e allo «spettacolo dal vivo» [?]). Non siamo fra quelli che invocano riforme a ogni pie’ sospinto; al contrario, siamo convinti che la scuola sia un organismo delicato, e che abbia dunque bisogno di tempo per metabolizzare innovazioni e sperimentazioni. Ma una visione d’insieme è indispensabile. Da questo punto di vista, il “governo del cambiamento”, della cesura “rivoluzionaria”, non si presenta con le migliori credenziali.
Ferdinando Pappalardo, già docente presso l’Università degli Studi di Bari, già parlamentare, presidente dell’Anpi provinciale di Bari, membro del Comitato nazionale Anpi
Pubblicato giovedì 21 Giugno 2018
Stampato il 15/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/cittadinanza-attiva/scuola-e-universita-fra-contraddizioni-e-rimozioni/