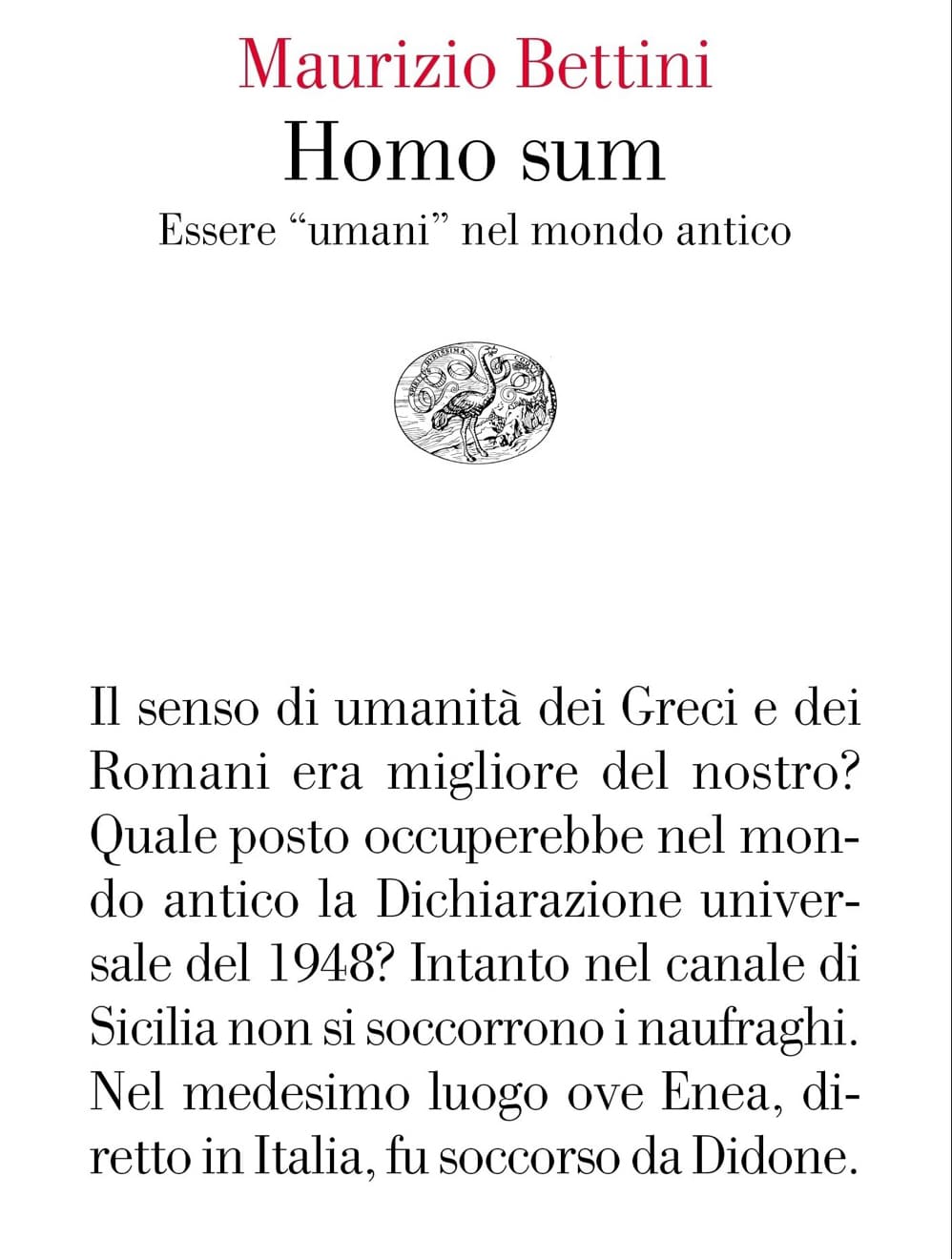 Maurizio Bettini, docente di filologia classica all’università di Siena, è uno dei maggiori studiosi del mondo antico.
Maurizio Bettini, docente di filologia classica all’università di Siena, è uno dei maggiori studiosi del mondo antico.
Una delle caratteristiche delle sue ricerche è mettere a confronto il nostro passato con l’attualità al fine di trarne affinità e divergenze, ma anche exempla utili per comprendere un presente sempre più complesso. Con questo libro Bettini interviene in modo critico sui decreti sicurezza, tutt’ora in vigore, approvati dal precedente governo. Se c’è qualcosa, pur nella loro diversità, che i greci e i romani possono ancora insegnarci è il senso di humanitas: quello spirito di accoglienza verso lo straniero che approda alle nostre spiagge.
Il suo saggio Homo sum proietta la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo del 1948 sull’antichità, cercandone analogie e differenze rispetto a problemi simili a quelli di oggi. Se nella modernità si parla di “Diritti inderogabili degli umani”, nell’antichità invece si poneva l’accento sui Doveri (lei parla di “obbligazioni”, ossia quelle azioni cui non ci si può sottrarre). Come ci ricorda nel libro, non è tanto il naufrago che ha il diritto di tendere la mano, quanto colui a chi la tende che ha il dovere di afferrarla. È stato conveniente questo cambio di prospettiva?
Forse sì, poiché i diritti si possono codificare, mentre con certi doveri ci sono delle difficoltà in più, quelli antichi – per esempio – erano sorvegliati non dalla legge, ma dalla morale consuetudinaria, oppure dalla religione e dagli dei; per questo dico che è più difficile codificare questo tipo di doveri, ossia quelli umani come li concepivano gli antichi. Ciò che si è un po’ perso, forse, in questo passaggio, è proprio il contenuto religioso ed emotivo che rispettare un dovere imposto dagli dei aveva, e che probabilmente non ha adempiere a un diritto umano. Tuttavia ritengo che, tutto sommato, il modello moderno che si è affermato sia senz’altro più efficace.

“Sono un uomo, niente di umano ritengo mi sia estraneo”. Questa frase così celebre, che dà il titolo al libro, costituisce secondo lei un invito all’indiscrezione. Impicciarsi degli altri, insomma, per conoscerli meglio, proprio come il troiano Ilioneo fa con la regina Didone. Eppure oggi l’indiscrezione voyeristica dei social media conduce più all’odio che alla fratellanza: come si pratica dunque l’indiscrezione di cui lei ci parla?
È un problema di intenzioni: l’indiscrezione dei social e dei media votati al gossip ha un’intenzione malevola, perché intende far conoscere cose che altri vogliono tenere nascoste, oppure vuole ostentare qualcosa cui si tiene particolarmente; l’indiscrezione terenziana, quella dell’homo sum, invece ha intenzioni positive, perché – per esempio in Terenzio – alla base c’è il desiderio di impedire ad un altro uomo di farsi del male. È un’indiscrezione di grado zero, che tocca il livello più elementare dell’umanità, in questo caso il dolore fisico. Anche quando si parla di diritti umani da tutelare e si è “indiscreti” nei confronti di altri Stati, poiché si vuole sapere e discutere ciò vi avviene, lo si fa generalmente in relazione a diritti elementari: il diritto di parola, l’amministrazione equa della giustizia, la libertà personale… ossia quello zoccolo di umanità che deve essere garantito prima e a prescindere dagli usi e costumi o da leggi sancite. Ad esempio: un conto è dire che si viola un diritto umano con il matrimonio coercitivo, un conto è dire che si viola un diritto umano quando la donna si mette il velo. Nel primo caso c’è una esplicita manifestazione di violenza. Possiamo dire, insomma, che quella terenziana è un’indiscrezione che funziona quando ha intenzione positiva e quando va a toccare elementi di base della convivenza umana, quando non praticarla corrisponderebbe a una omissione di soccorso.
 Nel suo saggio spiega che la parola latina humanitas racchiudeva e intrecciava significati diversi, relativi sia al “comportamento umano”, ossia l’essere miti e benevoli, sia alla cultura e all’educazione, quasi a significare che attraverso queste si può ottenere quello; lo stesso principio si legge anche nel Preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti. Se si parla di educazione e cultura non si può non parlare di scuola, e vorrei ricordare anche i convegni estivi che lei tiene a Siena per docenti di scuole superiori: cosa vuol dire fare politica a scuola, un insegnante ha il dovere di farla e di quale senso dovrebbe riempire questa parola?
Nel suo saggio spiega che la parola latina humanitas racchiudeva e intrecciava significati diversi, relativi sia al “comportamento umano”, ossia l’essere miti e benevoli, sia alla cultura e all’educazione, quasi a significare che attraverso queste si può ottenere quello; lo stesso principio si legge anche nel Preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti. Se si parla di educazione e cultura non si può non parlare di scuola, e vorrei ricordare anche i convegni estivi che lei tiene a Siena per docenti di scuole superiori: cosa vuol dire fare politica a scuola, un insegnante ha il dovere di farla e di quale senso dovrebbe riempire questa parola?
L’insegnante dovrebbe farla traducendo politica, che viene dal greco polis, con l’equivalente latino che è civitas, creando quindi il senso di una comunità civica, propria dei cittadini: questo non è fare politica nel senso più comune del termine, ossia quello che pertiene ai partiti, ma serve a dire: “attenzione, siamo una comunità di cittadini e prima ancora di uomini, ci sono diritti e doveri da rispettare, ci sono comportamenti e tradizioni culturali e istituzionali da conoscere”; in questo modo la scuola farebbe una bella politica, parlando di noi, di come dobbiamo stare insieme: comunità, società cittadina e umana.
Qualche tempo fa, lei aveva proposto di aggiungere alla versione di greco e latino dell’esame di Stato anche delle domande di comprensione del testo, proposta su cui qualcuno ebbe da ridire. Eppure non sarebbe utile, anche alla luce della cronaca degli ultimi mesi – costellata di atti e violenze di stampo razzista – assicurarsi che la scuola riesca a trasmettere il senso e i valori della classicità?
In parte il Ministero ha recepito la proposta che facevamo, aggiungendo – in seconda prova – alcune domande di comprensione del testo. Sebbene si trattasse di domande piuttosto scontate, che non andavano a colpire la sostanza culturale dei testi, ma per lo più la forma letteraria, tuttavia è già un passo avanti. Ritengo sia importantissimo abituare i ragazzi a prendere sul serio quello che leggono: quando si legge un brano di Cicerone o di Seneca o di Virgilio, non si legge soltanto un pezzo di latino in cui identificare alcune forme o costrutti o certe eleganza di stile, si leggono dei testi che dicono anche delle cose, delle cose spesso molto importanti, però queste passano sempre in seconda linea perché i testi diventano mere versioni. Pochissimi considerano questi testi per ciò che dicono: un testo di Platone non è analizzabile solo per la teoria platonica delle idee, ma dovrebbe essere messo in relazione con i grandi problemi dell’uomo, del cittadino, della donna, dello Stato – questo peraltro è il carattere di moltissimi testi degli autori antichi. Quindi non solo prendere sul serio quel che si legge, ma di conseguenza scegliere dei brani che abbiano un contenuto interessante, rilevante anche per gli studenti.
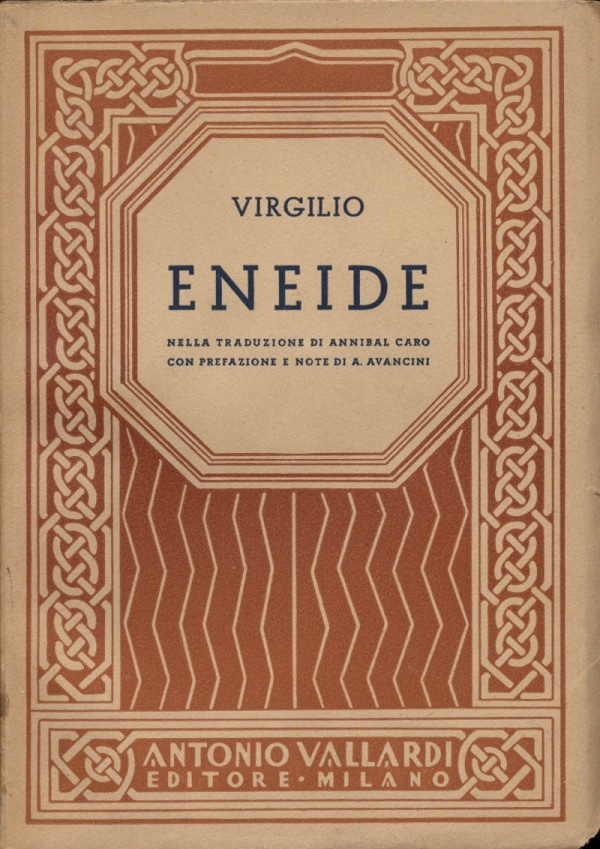 Lei scrive che oggi l’Eneide non si può leggere solo come un’opera letteraria, ma è diventata cronaca. Eppure non è solo in questi anni che la disperazione spinge migliaia di donne e uomini sulle nostre sponde, si pensi per esempio alle grandi migrazioni dall’Albania negli anni Novanta. Perché ha sentito proprio ora l’urgenza di scrivere questo saggio?
Lei scrive che oggi l’Eneide non si può leggere solo come un’opera letteraria, ma è diventata cronaca. Eppure non è solo in questi anni che la disperazione spinge migliaia di donne e uomini sulle nostre sponde, si pensi per esempio alle grandi migrazioni dall’Albania negli anni Novanta. Perché ha sentito proprio ora l’urgenza di scrivere questo saggio?
Perché non era mai avvenuto prima che ci si dicesse ufficialmente, esplicitamente “questi non devono sbarcare” e che impedirglielo fosse presentato addirittura come un dovere; non era mai avvenuto questo rovesciamento polare per cui dal dovere di accogliere si passasse al dovere di respingere. È questo che mi ha colpito profondamente: se anche in passato ci sono state oscillazioni, critiche nel modo in cui si gestivano i migranti, nessuno però aveva mai detto “è conforme alle leggi dello Stato e alle leggi democratiche impedire che queste persone approdino”. Ritengo che questo sia un cambiamento radicale, che tocca un nervo, per questo ho tirato fuori le parole di Ilioneo: “Ma che barbara terra è mai questa che ci nega l’approdo?”.

Non crede che, in questo scenario preoccupante, non solo gli intellettuali e gli scrittori, ma anche i docenti universitari debbano far sentire la loro voce? Non è ora che l’università recuperi un rapporto con la scuola e la società civile? Questo suo libro, come i precedenti Radici e Elogio del politeismo, rispondono a questa esigenza?
Sì, questo è assolutamente un bisogno che sento. Ritengo che l’università sia stata silente o quasi, in tutti questi anni, sulle vicende che accadono intorno a noi. Conoscevo un’università che era centro propulsivo di idee, di pensiero, di critica sia da parte dei docenti sia da parte degli studenti, c’era una reazione. Ora non dico di tornare indietro agli anni 70 o 80, quando se avveniva qualcosa anche dall’altra parte del mondo – in Cile o in Argentina – le università italiane si infiammavano, ma anche in anni più recenti c’era comunque sempre un minimo di attenzione o reazione. Oggi tutto questo è scomparso, le università sono completamente dominate dal verbo “adempiere”: “adempiere” a dei formulari, a delle regole, a delle prestazioni. All’università si “adempie” e basta. È chiaro che se si usano tempo ed energie solo per riempire formulari, scrivere articoli resi necessari solo dai meccanismi di valutazione, e non da reali necessità di ricerca, non resta più tempo e neanche fantasia per pensare e reagire: si riduce tutto a un gioco di domande da soddisfare, si producono cose astratte e tantissime carte ma non più idee. Tutto questo ha provocato inaridimento e spegnimento del pensiero nelle università. Mi auguro che i giovani se ne accorgano e sappiano rimediare.
Pubblicato mercoledì 27 Novembre 2019
Stampato il 14/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/interviste/una-questione-di-humanitas/






