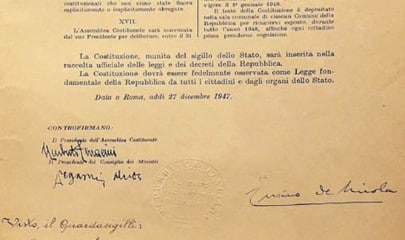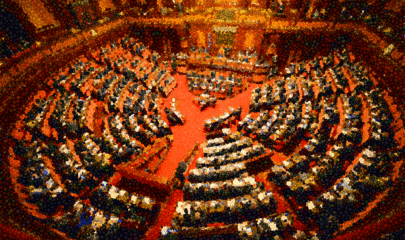Pubblichiamo volentieri l’interessante intervista concessaci dal professor Mario Dogliani, che consente di allargare il dibattito su temi essenziali per il futuro della democrazia italiana e che, per questo, stanno molto a cuore a tanta parte del Paese, ad associazioni, movimenti, costituzionalisti e all’ANPI in particolare. Su molte questioni le opinioni del professore coincidono col punto di vista dell’ANPI, a cominciare dalla gravità e dalla profondità della crisi della politica; non collimano su alcune specifiche questioni, come ad esempio il giudizio sull’allora ventilata modifica dell’art. 138. (G.P.)
Abbiamo chiesto al professor Mario Dogliani la sua opinione su queste questioni: 1) quali sono i punti principali della proposta di riforma del Senato; 2) che ne pensa delle modifiche alla riforma, in particolare alla luce delle proposte della sinistra Pd; 3) che rapporto c’è fra modifica della Costituzione e riforma del Senato; 4) come si colloca tale riforma nel contesto del crescente astensionismo dell’elettorato italiano e del declino del carattere rappresentativo delle istituzioni. Ecco il punto di vista del professor Dogliani:
«Partiamo da una constatazione di fatto. Il ruolo del Senato, nell’ambito della forma di governo italiana, è sempre stato discusso, il bicameralismo perfetto è sempre stato oggetto di discussione da parte di molti. Basta tenere presente che i costituenti avevano dato una giustificazione forte al Senato in quanto avevano previsto uno sfasamento nella durata delle due Camere. Nodo importantissimo: il Senato fotografava l’elettorato in condizioni storico-politico diverse da quelle della Camera dei Deputati. Al di là delle differenze sull’età, sull’elettorato attivo e passivo, c’era questa volontà di avere due Camere che rappresentavano l’elettorato in momenti diversi.
Questo, in parte, può costituire un ostacolo: così facendo si possono produrre delle maggioranze di volta in volta diverse. Adesso questa cosa fa paura, allora era accettata. Per vari motivi, uno fra tutti la fiducia nel corpo elettorale. Anche allora c’erano delle paure come, per esempio, la vittoria delle sinistre, ma comunque quei partiti non avevano paura di un Senato differenziato. E anche la legge elettorale avrebbe dovuto introdurre forti differenze. Il Senato avrebbe dovuto essere eletto con dei collegi uninominali, creando degli effetti, come diremmo noi oggi, “distorsivi” sulla governabilità. Questo fu chiaramente percepito e l’ipotesi di legge elettorale del Senato fu poi “svuotata” con un accordo Togliatti-Dossetti per cui si stabilì che il quorum per vincere le elezioni del collegio uninominale era il 65%. Il collegio diventava così pressoché inutile e si dovevano fare per forza delle alleanze e, attraverso dei collegamenti con i candidati dei collegi uninominali, si facevano delle liste di carattere regionale. Così facendo diventava un sistema di tipo proporzionale a livello regionale.

I costituenti volevano avere un Senato che potesse essere un elemento di contrappeso, di freno, ad eventuali maggioranze schiaccianti nella Camera dei Deputati. Ma il Senato venne sciolto anticipatamente facendo coincidere le sue elezioni con quelle della Camera. Ci siamo quindi trovati con due Camere di durata uguale, di composizione lievemente diversa, ma praticamente simili.
Il sistema bicamerale non portava particolari problemi fintanto che i partiti riuscivano a governare i loro gruppi parlamentari e quindi a praticare una sorta di divisione del lavoro tra le due Camere. Se io chiedessi ad un fornaio: «Lei preferisce avere un forno solo o ne vorrebbe due?» Nessuno risponderebbe uno solo! Però dovrebbe essere capace di organizzare il lavoro dei due forni.
Dunque la critica della lentezza che si attribuisce al Senato, su cui ha insistito molto anche Napolitano, non corrisponde alla realtà e non è per niente condivisibile.
Perché il problema vero non sta nel bicameralismo, ma nell’incapacità di usarlo. L’anti-bicameralismo è soltanto una testimonianza, una dichiarazione dell’incapacità del sistema dei partiti di governare le due Camere. Infine c’è stata l’infelice legge elettorale che ha semplicemente fatto palese questa incapacità, dimostrando che la razionalità di quella riforma era nulla.
Dopo la crisi costituzionale che ha portato alle dimissioni del governo Berlusconi e alla formazione del governo Monti, fu avviato un processo di riforma, con la nomina, da parte di Letta, della cosiddetta Commissione dei 35 e la presentazione di un disegno di legge sulla procedura della revisione costituzionale. Molte forze politiche e forze culturali, anche autorevoli, non avevano afferrato il cuore del problema. Prima di tutto è stata invocata l’illegittimità per quanto riguarda le modifiche della legge 138. Il punto che però era sfuggito a tutti i critici era che la modifica era piuttosto blanda. Non si trattava di modifiche che svilivano le rigidità costituzionali. Questo disegno rendeva infatti fra l’altro obbligatori i referendum: un cavallo di battaglia, questo, dei difensori della Costituzione da quando furono introdotte le leggi maggioritarie. Il 138 dice «Se sono favorevoli più dei due terzi, non si fa il referendum» perché nel ’48 il Pc e il Psi avevano più dei due terzi. Quando questa norma fu scritta, intendeva: «Se si raggiunge una maggioranza superiore ai due terzi, vuol dire che si è raggiunta l’unanimità». I partiti infatti non erano “sfarinati” come oggi, ma erano blocchi compatti. La ratio del 138 è molto semplice. In questo contesto attuale di partiti sfaldati e leggi elettorali maggioritarie, tutti i più accesi nemici della riforma hanno dimenticato che era un loro cavallo di battaglia prevedere un referendum obbligatorio.
L’altra è un’innovazione della cui saggezza ci si è resi conto molto dopo. Questa consisteva nel dire che la fase referente, cioè la preparazione dei testi, sarebbe dovuta avvenire per opera di una commissione mista, composta da senatori e deputati in base ad una correzione proporzionalistica.
Cosa si è scoperto ora? Che le due Camere hanno lavorato in modo totalmente separato: la Camera dei Deputati si è occupata di garantire la centralità del proprio ruolo, e il Senato gli spezzoni delle sue funzioni. Il dialogo fra le due Camere non c’è stato, cosicché ogni Camera parlava il suo linguaggio. Quindi, la riforma che per molti avrebbe stravolto l’impianto dell’articolo 138, in realtà si limitava a dire che l’attività istruttoria sarebbe dovuta essere distribuita equamente tra le due Camere in una commissione mista. Ho avuto modo di partecipare a delle audizioni di Camera e Senato in cui era palese che non vi era nessun punto di contatto, nessun confronto. Una cosa veramente squallida.
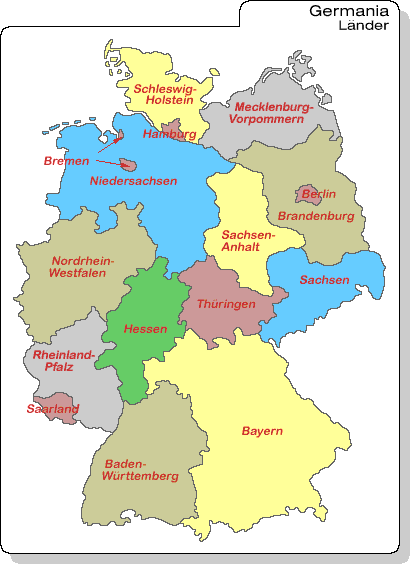
La commissione dei 35 quando affrontò il problema del bicameralismo constatò che emergeva una differenza sostanziale, che probabilmente rifletteva una frattura più profonda. C’erano alcuni, studiosi del diritto costituzionale, ma soprattutto di diritto regionale, che erano convinti che si dovesse fare del Senato la Camera delle Regioni ed un luogo di raccordo tra il sistema degli enti territoriali e l’Unione Europea. Questa tesi era molto diffusa, a mio parere con delle ambiguità. Il modello di riferimento era quello tedesco, che però era sbagliato! Non si può fare del nostro parlamento una Camera rappresentativa delle Regioni, perché l’unico soggetto rappresentabile è il popolo. Tutti parlano della Germania ma, cosa che tutti dimenticano, si tratta è uno stato federale in cui i Lander sono stati sovrani. Ma in uno stato che federale non è, come il nostro, la rappresentanza dev’essere sempre popolare. Insomma, non si può dire che il Senato rappresenta le Camere di Commercio; o meglio si può anche dire, ma a quel punto non è più rappresentanza politica, ma quella di interessi economici. Un’altra ala della commissione riteneva invece che il Senato doveva essere una seconda Camera di garanzia, una Camera “alta”, non una Camera secondaria, un contrappeso alla Camera dei Deputati. Doveva avere voce in capitolo su questioni di cui nessuno si occupa oggi, e di cui si non si occuperà certamente la nuova Camera, a schiacciante maggioranza governativa, ma che invece sono molto importanti, come la verifica delle nomine governative, le inchieste, le indagini sul funzionamento della macchina pubblica, gli esiti delle leggi, la razionalizzazione dell’ordinamento, la creazione di testi unici, di codici. Tentare insomma di mettere ordine in questo disperato disordine.
Alla fine è prevalsa la linea regionalistica ed è venuto fuori che il Senato doveva essere quell’organo che raccordava, parola che non si sa bene cosa voglia dire, lo Stato e le Regioni da un lato e lo Stato e l’Europa dall’altro. Io mi chiedo quale legittimità politica possano derivare da queste due funzioni. Il Senato diventa, dunque, una cerniera dei rapporti tra Regioni e Stato e, tra queste e l’Europa. Adesso la fisionomia del Senato dipenderà da come si attuerà tutto ciò nella pratica. Certo che, se verranno inviati in Senato dei personaggi di seconda fila del ceto politico regionale, la situazione potrebbe diventare molto grave e complicata. Se invece, ci saranno delle persone in grado di avere uno sguardo sull’ordinamento lungo, grande e complessivo, la riforma che è stata spuntata dalla sinistra del Partito Democratico potrebbe avere un suo significato. Potrebbe avere degli sviluppi considerevoli in quanto attenuerà il ruolo del Senato quale rappresentante solo delle Regioni, e non di interessi politici più ampi.
Il Senato, con questa riforma del suo sistema elettorale, viene a rappresentare le Regioni viste non solo come enti, ma come comunità territoriali istituzionalizzate. Con questo, a mio parere, si recupera la rappresentanza popolare perché l’elezione non è più di secondo grado, ma indiretta. Un po’ come negli Stati Uniti dove i cittadini vanno a votare per i grandi elettori di ogni stato, ma in realtà votano direttamente per il Presidente. I Consigli Regionali dovranno eleggere senatori coloro che sono stati designati nel corso delle elezioni regionali stesse da parte del corpo elettorale. Dunque, secondo me, non è vero che è una riforma inutile come molti si sono affrettati a dire. Può avere un senso. Altrimenti potrebbe succedere che, dopo le elezioni, i gruppi politici regionali che compongono la maggioranza si suddividerebbero le cariche: “Tu fai il Presidente della Regione, tu fai l’Assessore all’Urbanistica e te invece, ti mandiamo in Senato”. Dal punto di vista di chi la riforma l’ha voluta, è molto discutibile l’assenza dei presidenti delle Regioni nel Senato: in quest’ottica ci sarebbero stati bene. Non si capisce bene cosa ci stia a fare il sindaco. Vediamo cosa ci riserverà il futuro su questa vicenda.
 Il problema generale, che sta a monte di tutto, deriva dal fatto che la democrazia, così come l’abbiamo introdotta in Italia, è fondata sui partiti: sono loro i suoi pilastri. Non c’è niente da fare. E i partiti sono i grandi ammalati che non si riesce a guarire o, per lo meno, ad avviarli sulla strada della guarigione. Tutti questi meccanismi istituzionali potranno fare quindi molto poco. Il sistema politico dovrebbe funzionare in maniera molto semplice: i partiti – nella loro diversità – dovrebbero raccogliere le opinioni parziali in conflitto, e poi, la loro unità in parlamento, dovrebbe costituire la rappresentanza. Lo Stato è rappresentativo perché il Parlamento è rappresentativo, come organo considerato nel suo insieme, composto da partiti che forniscono “rappresentazioni” parziali dei conflitti che dividono la società. È tutto il loro lavoro e la loro com-presenza in Parlamento che genera la rappresentanza. Se gli attuali partiti sono incapaci, inetti, litigiosi e volgari, la rappresentanza dove va a finire? È quindi l’incapacità dei partiti che ha generato tutto questo. C’è un’idea rapace di politica. L’anti-politica ha vinto. Il futuro è molto oscuro».
Il problema generale, che sta a monte di tutto, deriva dal fatto che la democrazia, così come l’abbiamo introdotta in Italia, è fondata sui partiti: sono loro i suoi pilastri. Non c’è niente da fare. E i partiti sono i grandi ammalati che non si riesce a guarire o, per lo meno, ad avviarli sulla strada della guarigione. Tutti questi meccanismi istituzionali potranno fare quindi molto poco. Il sistema politico dovrebbe funzionare in maniera molto semplice: i partiti – nella loro diversità – dovrebbero raccogliere le opinioni parziali in conflitto, e poi, la loro unità in parlamento, dovrebbe costituire la rappresentanza. Lo Stato è rappresentativo perché il Parlamento è rappresentativo, come organo considerato nel suo insieme, composto da partiti che forniscono “rappresentazioni” parziali dei conflitti che dividono la società. È tutto il loro lavoro e la loro com-presenza in Parlamento che genera la rappresentanza. Se gli attuali partiti sono incapaci, inetti, litigiosi e volgari, la rappresentanza dove va a finire? È quindi l’incapacità dei partiti che ha generato tutto questo. C’è un’idea rapace di politica. L’anti-politica ha vinto. Il futuro è molto oscuro».
Pubblicato mercoledì 2 Dicembre 2015
Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/dogliani-chiaroscuro-della-riforma-del-senato-la-notte-dei-partiti/