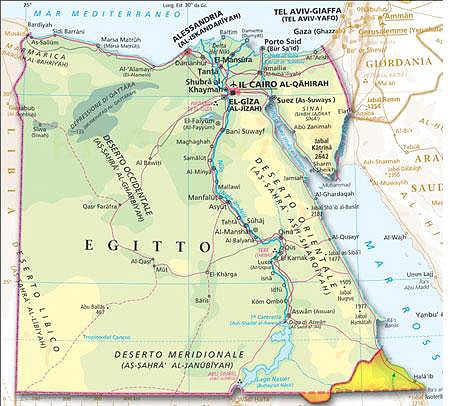 Pane, libertà, giustizia sociale. Quale di queste tre rivendicazioni ha trovato seguito dopo il 25 gennaio 2011? Quali di quei tre desideri espressi dai ragazzi di Piazza Tahrir si è trasformato in realtà? Osservando l’Egitto di oggi, quello in cui ha drammaticamente trovato la morte il dottorando italiano Giulio Regeni, è molto complesso rispondere, specialmente se le parole che maggiormente risuonano nel dibattitto intorno (e non interno) al Paese sono oggi ben altre: povertà, impunità, violenza.
Pane, libertà, giustizia sociale. Quale di queste tre rivendicazioni ha trovato seguito dopo il 25 gennaio 2011? Quali di quei tre desideri espressi dai ragazzi di Piazza Tahrir si è trasformato in realtà? Osservando l’Egitto di oggi, quello in cui ha drammaticamente trovato la morte il dottorando italiano Giulio Regeni, è molto complesso rispondere, specialmente se le parole che maggiormente risuonano nel dibattitto intorno (e non interno) al Paese sono oggi ben altre: povertà, impunità, violenza.
“Stranieri non venite!”. L’appello non è di qualche sedicente gruppo islamico, ma di una nota attivista egiziana di sinistra come Mona Seif. A seguito del brutale assassinio di Regeni, la Seif ha scritto e divulgato sui social network un accorato comunicato denunciando aspramente il clima di paura e repressione che vige nelle strade del Paese dove lo Stato crea nemici immaginari per poter reprimere persone vere, in carne ed ossa. Nel 2012, era in marzo, fui testimone di una conferenza all’American University del Cairo dove si discuteva dei risultati conseguiti dalla rivoluzione a poco più di un anno di distanza dal suo inizio. Ascoltai uno degli oratori mettere in guardia l’uditorio poiché, a suo dire, nessuna rivoluzione era possibile in 12 mesi: trent’anni di Mubarak non si potevano cancellare con due settimane di proteste di piazza, per quanto potenti, per quanto emotivamente dirompenti, per quanto il vecchio dittatore avesse finalmente abbandonato le redini del comando. Secondo il giovane docente la vera domanda da porsi era (ed è ancora oggi): a chi sono state consegnate le chiavi del Paese a seguito delle dimissioni di Mubarak? Ai giovani rivoluzionari? Ai rappresentanti delle opposizioni? Ai tanto temuti Fratelli Musulmani? La risposta era presto data: no. Fu l’esercito, per esattezza il Consiglio Supremo delle Forze Armate, a gestire il processo di transizione e quindi a prendere il comando. Dunque il primo risultato della cosiddetta “rivoluzione egiziana” è stato quello di eliminare un militare, Mubarak, per installare un organismo di potere presieduto da più militari. Quegli stessi militari che nel corso degli ultimi anni erano entrati in collisione proprio con il clan Mubarak e che nei giorni successivi al 18 febbraio 2011 (data delle dimissioni del vecchio faraone) non avrebbero esitato a sparare sulla folla affinché la stessa “tornasse alle proprie case”. Il Consiglio Supremo delle Forze Armate si sarebbe poi alleato con i Fratelli Musulmani, storico movimento di opposizione nato nel 1928 e dichiaratamente islamista, prima permettendo che questi fossero in grado di ottenere la maggioranza in Parlamento e conquistassero persino la poltrona della presidenza della Repubblica, e poi il 3 luglio 2013, rimuovendo il Presidente Morsi e sciogliendo lo stesso Parlamento con un colpo di Stato. Certo, il supporto popolare che spinse alla destituzione di Morsi era più che evidente (oltre 20 milioni di egiziani scesero in piazza per chiedere le sue dimissioni) ma ancora oggi pare opportuno interrogarsi se il modo più corretto e democratico di rimuovere un Presidente, che pure aveva agito al di fuori dei poteri del proprio mandato e che pure aveva commesso gravissimi errori e violazioni, sia stato intervenire manu militari.

Al lettore poco abituato alle cronache egiziane potrebbe a questo punto sorgere spontanea, e legittima, una domanda: perché l’esercito? Perché un ruolo così preponderante dei militari nelle vicende di ieri e di oggi del Paese? La risposta è presto data. In Egitto i militari controllano da decenni larga parte dell’economia (circa un 40% secondo recenti fonti giornalistiche) ed è dagli anni 50 che la presidenza del Paese è occupata da un militare: prima Gamal Abd al-Nasser, poi Anwar Sadat, Hosni Mubarak ed infine oggi Abdel Fattah al-Sisi. Secondo la ricercatrice Shana Marshall siamo dinanzi ad un vero e proprio impero economico con le mostrine, capace di controllare la compravendita di terreni, la produzione di beni alimentari, investimenti nell’alta finanza e molto altro ancora. Come la politica ad esempio. Se Morsi era stato accusato di voler islamizzare lo Stato piazzando Fratelli Musulmani in ogni angolo del Paese e facendoli accomodare su ogni poltrona di potere disponibile, con il nuovo governo di al-Sisi le cose non sono migliorate. Nel 2015 un report del Carnegie Endowment for International Peace riferiva che ben 27 governatorati provinciali sono ad oggi gestiti da generali dell’esercito. Una ingerenza di non poco conto nella vita dello Stato e che ha prodotto non poche conseguenze nella vita quotidiana del popolo egiziano.
Scrive Amnesty International sul proprio sito ufficiale: “migliaia di attuali oppositori del governo come di presunti oppositori, sono stati arrestati durante le proteste, nelle loro case, presso il loro luogo di lavoro”. Ed ancora “la tortura dei criminali viene abitualmente utilizzata per estorcere confessioni, punire ed umiliare”. Le decine di testimonianze riprese dai media occidentali e propagandate per bocca dei portavoce delle organizzazioni non governative presenti nel Paese, non sembrano lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio. Basta leggere i loro reportage e pescare, a caso, la storia del giornalista Omar Abd al-Maqsoud in galera dall’aprile del 2014 ed ancora in attesa di un processo che verrà celebrato, salvo rinvii, il 21 febbraio 2016. L’Egyptian Initiative for Personal Rights ha recentemente denunciato l’illegale detenzione del connazionale aggiungendo altresì che tutta la famiglia del sospettato (a partire dal padre) è stata sottoposta negli ultimi mesi a misure restrittive ed al carcere. Di casi simili, ed anche molto più drammatici, la recente letteratura delle organizzazioni non governative è tristemente ben documentata.

L’Egitto di al-Sisi e dei suoi fedelissimi sembra, secondo alcuni, addirittura peggio di quello di Mubarak. Secondo altri al-Sisi è il novello Nasser, ne intende ricalcare le orme pur mancando però di quel carisma e di quello spessore ideologico che rese Nasser il paladino della causa araba facendolo sopravvivere, seppur per poco, persino al dramma arabo della Guerra dei Sei Giorni nel 1967. Ed è forse proprio la mancanza di una pur fragile stampella ideologica a mostrare il volto feroce del regime. Un regime che vuole vedere nemici ovunque e che, come dimostra purtroppo il caso Regeni, ha forse deciso di alzare l’asticella del confronto anche con il mondo occidentale. Sul piano interno, infatti, il limite è da tempo oltrepassato. Secondo l’indipendente Egyptian Center for Economic and Social Rights, al 2015 in carcere erano presenti 40.000 detenuti per motivazioni politiche, nonché fra i 18 ed i 60 giornalisti. Secondo Freedom House, la legge sulla libertà associativa relativamente al settore non governativo è fra le più restrittive al mondo. I Fratelli Musulmani sono stati messi al bando e gran parte dei suoi membri è da molti mesi in carcere ed ha subito condanne a morte. Moltissimi studenti, denuncia il National Council for Human Rights (NCHR), sono detenuti e torturati per giorni, se non settimane, al fine di ottenere informazioni e senza che le famiglie ne sappiano nulla.
La violenza, scrive lo scrittore egiziano Khaled Mansour, è ormai quasi normalizzata. La violenza che è strumento necessario e privilegiato per normalizzare la paura. La paura che porta all’obbedienza, al servilismo, alla noncuranza. L’unico elemento rivoluzionario che il 25 gennaio 2011 era stato in grado di produrre realmente era stato quello di risvegliare le coscienze degli egiziani dopo anni di torpore forzato dalla repressione. L’Egitto aveva mostrato al mondo la presenza di una società civile viva, forse politicamente immatura certo, ma comunque attiva, presente, pronta a lottare, ad imparare. Piazza Tahrir non è stata solo un sogno, ma la reale dimostrazione di un magma incandescente che con forme dirompenti ha invaso le strade della capitale prima e di tutto il Paese poi. Quelle illusorie giornate avevano spinto gli egiziani a parlare liberamente per strada, nei caffè, a criticare il governo, a denunciare la corruzione, le violenze delle forze di sicurezza, a realizzare ciò che fino a pochi giorni, poche ore prima, era finanche impensabile. Questa era la vera rivoluzione egiziana. Una rivoluzione che magari dal punto di vista dei cambiamenti politici, sociali ed economici non aveva prodotto alcuna trasformazione sostanziale, ma che tuttavia lasciava presagire un futuro diverso, con la mente libera dal passato. Liberi, finalmente, dalla paura. Oggi però anche questa ultima eredità del 25 gennaio sembra progressivamente esaurirsi, piegarsi sotto le frustate della repressione alla quale basta colpire, anche indiscriminatamente, per seminare paura e terrore ripristinando lo status quo ante. O peggio.
Pubblicato venerdì 19 Febbraio 2016
Stampato il 18/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/egitto-leredita-di-piazza-tahrir-cinque-anni-dopo/








