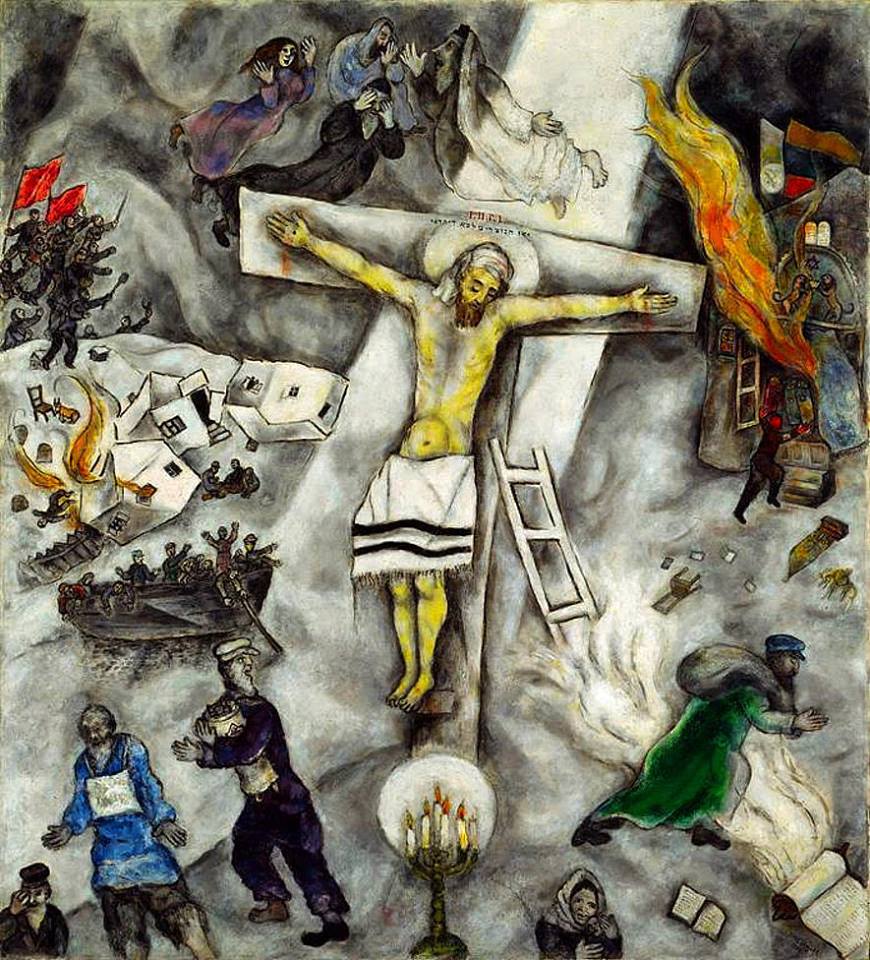
Da molto tempo la ricorrenza nel calendario civile dell’anniversario dell’8 settembre 1943 è stata tematizzata da certuni come il momento in cui morì la «patria». Senza spiegare bene cosa fosse stata la patria medesima fino a quella data fatale. Partiamo allora della fine, ossia dall’evento storico in sé, per poi costruire un discorso di senso rispetto al presente. Sull’insieme dei fatti che anticiparono la proclamazione pubblica dell’armistizio (la crisi militare dell’Italia impegnata in guerra; quella politica che si risolse con il colpo di mano del 25 luglio; l’interregno dei quarantacinque giorni di Badoglio a Roma; la firma materiale dell’armistizio in Sicilia; la sua dichiarazione alla radio, peraltro obtorto collo), già le cose sono, per i lettori di queste righe, sufficientemente chiare. Soltanto alcuni passaggi meritano di essere ricordati. L’Italia, che si voleva potenza continentale, era entrata in guerra completamente e disastrosamente impreparata. Il passaggio dalla teorizzazione mussoliniana di una «guerra parallela» alla concretezza di un conflitto completamente «subalterno» a Berlino, negli obiettivi così come nelle procedure, rimane la cornice di fondo alla quale riportare l’insieme delle riflessioni. Poiché l’irreversibile crisi del regime fascista, maturata tra il 1940 e il 1943, si fonda anche e soprattutto sulla lunga erosione bellica. L’ingresso nel Secondo conflitto mondiale era avvenuto nell’inconsapevolezza collettiva degli oneri che esso avrebbe implicato. Per una parte degli italiani costituiva un evento di transito, destinato a concludersi in un arco di tempo limitato, a costi contenuti e con apprezzabili benefici. Nei fatti, invece, le cose andarono ben diversamente. Già nel 1941, le perplessità, sia pure sottotraccia, trapelavano. Soprattutto dinanzi al richiamo delle classi giovanili, mobilitate per andare a combattere battaglie che per nulla incontravano il favore popolare. L’incantesimo di una guerra “comoda”, sostanzialmente indolore e destinata a fare le fortune dell’Italia mediterranea e «imperiale», si era velocemente inabissato. Anche su questo concreto aspetto, il fascismo giocò buona parte delle sue residue fortune, rivelandosi quindi incapace di fare fronte a ciò che esso stesso aveva innescato. Poiché la crescente titubanza, che si faceva diffidenza e poi avversione per il prosieguo del confronto militare, diveniva un universo di risentimenti che si associavano al regime medesimo. Più che la maturazione di una consapevolezza antifascista, che apparteneva ancora a un numero limitato di italiani, era nel rifiuto di continuare a garantire il consenso a qualcosa di completamente estraneo rispetto alla vita degli italiani che si andò quindi giocando e coagulando la crisi del mussolinismo.

In buona sostanza, era la stessa «patria fascista» ed essere rifiutata, soprattutto per ciò che essa stava riservando alla collettività. Il 25 luglio 1943 segnò quindi la morte di quella “patria”, senz’altro nell’illusoria ed ingenua convinzione che venendo meno il regime sarebbe finita anche la guerra, ma anche nel ben più concreto obiettivo che l’equazione tra fascismo e conflitto bellico andasse spezzata a partire dalla cancellazione del primo fattore, per l’appunto il sistema antidemocratico, illiberale e totalitario che aveva condizionato il Paese fino a farlo sprofondare nel baratro bellico. D’altro canto, quest’ultimo aveva intossicato all’inverosimile l’idea stessa di patria, trasformandola in uno strumento di controllo ed espropriazione delle libertà residue degli italiani. La patria, infatti, doveva essere “fascista” e non altro. Quella patria, per l’appunto, l’8 settembre morì. Non morì invece ben altro. Quel ben altro che non era più il ritorno della vecchia nazione liberale – costruita su un sistema di gerarchie sociali e culturali che demandava ancora ad un’unità fittizia, fatta non di cittadini bensì di sudditi – ma di una società assai più complessa ed articolata, dove la dialettica tra libertà, giustizia e diritti diventava il fuoco dell’agire prima politico e poi istituzionale. La lotta di Liberazione costituì il contesto in cui venne definendosi questo quadro, che sarebbe poi maturato, pur con grandi difficoltà, nei decenni successivi. L’8 settembre 1943, da questo punto di vista, costituì una sorta di trauma necessario, un brusco se non brutale risveglio, che travolse quello che restava delle illusioni pregresse, consegnando l’intero Paese (la vera patria, non un insieme di false deferenze e di obblighi fittizi) al confronto con se stesso, con la sua recente storia, quindi con il fallimento, prima ancora che sul versante militare, del sistema morale, civile e culturale che era conosciuto come «regime fascista». Come anche delle isole di consenso che pure aveva raccolto intorno a sé e alle sue imprese. Moriva il nazionalismo imperialista, mentre nasceva una diversa idea di nazione e, con essa, di sovranità. L’una e l’altra consegnate, anche per il gioco delle circostanze, ad un tortuoso ma indispensabile percorso di ricostruzione delle ragioni dello stare insieme. In buona sostanza, se dell’idea (e delle pratiche) di nazione venivano radicalmente ridisegnati i contenuti, fondando ora il fulcro della comunità sulla cittadinanza costituzionale, la sovranità veniva al contempo circoscritta territorialmente, cancellando ogni residua intenzione espansionista. Nazione e sovranità erano progressivamente ricondotte al consesso di un’Europa democratica, a sua volta basata su società costituzionali.
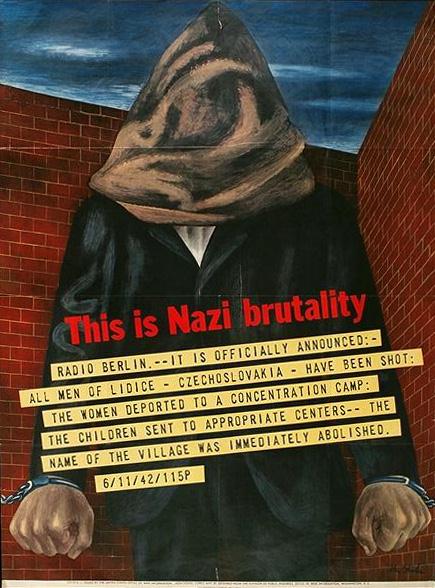
Il processo di integrazione europea, avviatosi concretamente nel 1949, ne era parte integrante. In altre parole ancora: la patria era tale non in virtù di aleatori (e concretamente pericolosi) concetti di superiorità (“noi al di sopra del resto del mondo”) o di autosufficienza (“noi a prescindere dal resto del mondo”) ma in ragione del riconoscimento che lo sviluppo dell’essere nazione italiana implicava, per la nostra stessa esistenza, quello dell’interdipendenza continentale. Il bipolarismo e l’antagonismo tra Est ed Ovest aveva una grande parte in queste dinamiche ma non era meno vero che per i padri costituenti l’Italia non avrebbe potuto fare a meno dell’Europa (e viceversa). Non solo le dimensioni di scala dei mercati, già allora globali, lo richiedevano ma anche una logica politica basata sulla pace e sulla felice contaminazione culturale. Per preservare e costruire la nazione italiana ci voleva una cornice continentale. Era la premessa indispensabile. La sua sovranità, come recita la stessa Costituzione, era prerogativa del popolo, attraverso i suoi rappresentanti scelti democraticamente e un sistema di leggi condivise, ma in un contesto dove le limitazioni della medesima erano non più un vincolo bensì un’opportunità per lo sviluppo sociale, culturale, economico e civile. Per arrivare a questa consapevolezza c’erano voluti più di un secolo, dai primi movimenti di unificazione peninsulare, una lunga traiettoria di trasformazioni sociali, due guerre mondiali, la dittatura fascista, la Resistenza, l’avvio della ricostruzione materiale e morale del Paese. Settanta e più anni sono oggi trascorsi da quello che per noi fu un nuovo punto di partenza. Lo scenario odierno, va da sé, si presenta profondamente modificato rispetto a quel passato. Una lettura che metta in rilievo solo gli aspetti critici e problematici, il molto che è rimasto incompiuto, non ci restituirebbe il senso degli sforzi che comunque sono stati nel mentre compiuti. L’Italia e l’Europa di oggi hanno poche cose in comune con ciò che erano prima e durante le due guerre mondiali: l’imperialismo, il militarismo; la mortificante prassi della sistematica subordinazione collettiva alla volontà dei pochi; l’elitarismo come pratica rivendicata abitualmente da una parte delle classi dirigenti; l’ingiustizia diffusa corroborata dalla modestia, se non dalla miseria, dei molti, se non sono sempre e comunque ricordi del passato hanno tuttavia subito un processo di erosione grazie anche, e soprattutto, alla diffusione di un sistema di regole democratiche. Le quali, va detto e ripetuto, non vivono di sola luce propria, non si sostengono da sé, non possono essere racchiuse nei soli confini nazionali, ma sempre più spesso richiedono un confronto con le altre società democratiche. Siamo – e sempre più spesso saremo, volenti o nolenti – società meticce, composte da popolazioni autoctone (a loro volta, però, prodotto di precedenti processi migratori) e da individui provenienti da altri luoghi.

Non si tratta di scegliere poiché nell’evoluzione storica spesso si “è scelti”, ovvero si deve affrontare qualcosa che ci sovrasta e si impone su di noi nostro malgrado. I fenomeni delle migrazioni internazionali si inquadrano in questo contesto, al netto delle politiche di regolazione dei flussi, queste ultime parte integrante del dispositivo democratico. Anche per questa evidente ragione, il rilancio dei sovranismi, dei populismi e degli “identitarismi” da parte di alcune forze politiche europee e italiane, alla ricerca di facili consensi dinanzi alla paura del cambiamento, rischia di rivelarsi non solo manipolatorio, illusorio e anacronistico ma fortemente controproducente. Il sovranismo riproduce la falsa convinzione che un Paese possa esistere e svilupparsi operosamente riconducendo tutte le dinamiche decisionali e tutelando i propri interessi dentro i confini nazionali. Ne deriva che chi pensa in tale modo abbia una visione statica e astorica della società (nazionale e internazionale) nella quale vive. Pensare alle frontiere come ad una condizione immutabile implica il non capire (oppure il fingere di non comprendere) che tali linee di divisione politica ed amministrativa non solo hanno un carattere temporaneo, in quanto prodotto precipuo delle circostanze storiche, ma anche fittizio, non corrispondendo in alcun modo (se non attraverso una volontà arbitraria) a linee “naturali” di divisione e, ancora meno, a unità “etniche”, ossia a nazionalità predefinite. I nazionalismi, vale la pena di ricordarlo ancora una volta, precedono le “nazioni”, nel senso che le creano come entità.
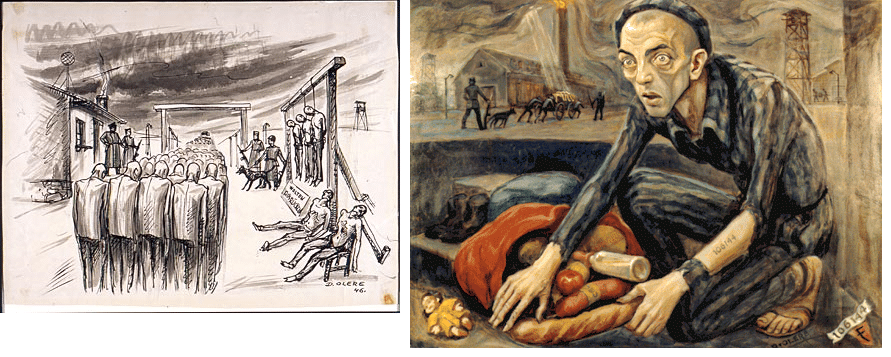
L’unico patriottismo plausibile, al giorno d’oggi, è quello costituzionale, repubblicano e democratico, che si fonda non sulla reificazione della terra e dei confini ma sulla condivisione di sistemi di regole fondamentali anche tra popoli e culture diverse. Il sovranismo, nel nome della difesa degli «interessi nazionali», il più delle volte fa strame di questa premessa. Non di meno, per cercare di enfatizzare la “nazione” stessa, giocando spesso sulle angosce e le paure di società in trasformazione, salta a piè pari le mediazioni e le rappresentanze democratiche, viste e presentate come dei ritualismi destinati esclusivamente ad affaticare i processi decisionali. Non a caso, infatti, al sovranismo si lega il populismo, che fa dell’elegia ingannevole del “popolo sovrano” il proprio ossessionante motivo di riferimento. La sacralizzazione della volontà popolare in assenza di intermediazioni e di filtri, costituisce non un di più di democrazia ma un suo deliberato annichilimento. Poiché è l’anticamera della cancellazione dei sistemi di garanzia, senza i quali le società contemporanee rischiano di consegnarsi alla prevaricazione dei più forti. Nel populismo non esiste una reale volontà popolare ma la decisione dei leader che impongono alla collettività, in un fittizio sistema di scambi tra capi e società, senza il vaglio delle istituzioni democratiche, devitalizzate e neutralizzate nei loro ruoli. Nel populismo i rischi che stanno dietro l’angolo, quindi, sono l’oclocrazia (lo pseudogoverno delle moltitudini, quindi della conflittualità permanente tra gruppi contrapposti e della confusione totale) e la “democratura” (l’imposizione di un’unica volontà, spesso con la forza, fatta però passare per manifestazione di consenso collettivo). Un ulteriore passaggio demagogico che connota i nazionalismi contemporanei, alla ricerca perenne di una “nazione che non c’è” se non nella fantasia a tratti delirante, è l’identitarismo, ossia la costruzione di false identità collettive, intese – al pari dei confini – come delle essenze immutabili, inviolabili, insindacabili. L’identità nazionale, in questi casi, diventa un costrutto mitologico, da scagliare contro quanti e ciò che non risultino conformi agli interessi dei gruppi dirigenti oligarchici. Come si avrà modo di osservare ad un riscontro critico, tutti questi procedimenti di falsificazione del discorso politico, e dell’azione pubblica, non sono in sé inediti. Già nel secolo trascorso hanno intossicato la comunicazione e l’immaginario collettivi. Parlare di «patria», di «nazione», di «confini nazionali» è non solo legittimo ma anche necessario, se però ad ognuna di queste espressioni si ricollega il concetto (e le prassi) della democrazia costituzionale. Un popolo esiste soprattutto quando le regole che ne governano l’esistenza sono basate sulla legittimità dei processi decisionali, sulla giustizia redistributiva (che garantisce coesione sociale), sulla trasparenza delle scelte, sulla revocabilità delle decisioni sbagliate, sull’intercambiabilità dei decisori e sulla rappresentanza di tutte le parti che costituiscono la società. In una espressione sola: sulla garanzia concreta del pluralismo culturale, sociale e civile che pratica l’eguaglianza dei diritti in una società di persone diverse, tali poiché titolari di storie e percorsi di vita differenti. Il neonazionalismo etnicista, quello che afferma che si è parte di una collettività solo per nascita (quindi per ascendenza ancestrale), collante del populismo, dei sovranismi e degli identitarismi, è il rovesciamento di ogni forma di patriottismo costituzionale. Interviene nelle collettività spaesate dai processi di trasformazione indotti dalla globalizzazione; ne alimenta paure offrendovi ingannevoli soluzioni; propone e impone scorciatoie pericolosissime dinanzi alla complessità del mutamento planetario (e societario). Consegnarsi ad esso è come legarsi mani e piedi, nascondendo la testa sotto la sabbia, nel mentre il mare avanza. Ancora una volta, l’unica soluzione possibile e plausibile è ritornare all’altrimenti interrotto processo di integrazione europea. Sarà una tela senz’altro in parte da ritessere ma senza la quale l’Italia, così come gli altri Paesi continentali, rischiano di rimanere privi di rete di protezione.
Claudio Vercelli, Università cattolica del Sacro Cuore, Istituto di studi storici Salvemini
Pubblicato mercoledì 18 Settembre 2019
Stampato il 02/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/la-patria-l8-settembre-e-loggi/







