 In un periodo in cui abbiamo dovuto necessariamente ridisegnare nuovi confini dell’interazione e delle manifestazioni d’affetto, dell’organizzazione della vita quotidiana e dell’espletamento dei doveri lavorativi, forse inconsapevolmente abbiamo istituito nuovi mo(n)di. Di comunicare, in primis. Ma anche di percepire sé e gli altri nel mondo.
In un periodo in cui abbiamo dovuto necessariamente ridisegnare nuovi confini dell’interazione e delle manifestazioni d’affetto, dell’organizzazione della vita quotidiana e dell’espletamento dei doveri lavorativi, forse inconsapevolmente abbiamo istituito nuovi mo(n)di. Di comunicare, in primis. Ma anche di percepire sé e gli altri nel mondo.
“Vicini, anche se distanti” e slogan analoghi sono stati il perno della fase di lockdown, in cui il ferreo distanziamento sociale ha fondato nuove categorie sociali, umane, ontologiche. Il mondo è stato filtrato attraverso nuovi dispositivi (siano essi tecnologici che mentali), infrastrutture invisibili e connessioni costanti, anche se in absentia.
È stato inventato un altro modo possibile di socializzare e adempiere ai doveri quotidiani e, ciò che è più importante, è stato introdotto senza gradualità, senza mezze misure. Straordinario e quotidiano si sono improvvisamente mescolati e, ad oggi, è difficile dire se l’ordinario fosse il periodo prepandemico o, al contrario, la “normalità” sia oggi. Stilemi insoliti, quelli che caratterizzano il “qui e ora”, ma pur sempre fondativi di un periodo storico. La pervasività del digitale è un dato di fatto: filo di Arianna e spada di Damocle, insieme, che congiunge e separa, isola e protegge. Uno strumento controverso che, però, ha avuto ricadute anche sul modo di interagire.
Cosa è rimasto, allora, dei nostri cinque sensi, a fine lockdown? L’ottundimento ha prevalso o, forse, si sono affinati, anche se seguendo percorsi “laterali”? Il primo stadio di esperienza, la persona (sia l’individuo, che la specie) lo pone in essere proprio attraverso i sensi; i filosofi presocratici e i neonati insegnano questo: mettere a sistema il mondo partendo dai sensi e dagli elementi della natura. Un approccio deduttivo, primordiale, in cui le sensazioni sono veicolo di conoscenza. Certo, l’Homo sapiens postmoderno ha saputo guardare oltre, ma questa traccia primitiva è rimasta sottocutanea.
 Già poco prima del lockdown non ci si stringeva più la mano e, con l’avvento della quarantena, abbiamo anche oscurato i sorrisi con le mascherine. I dispositivi di sicurezza anticontagio hanno riscritto sia il modo in cui l’individuo si pone con gli altri, sia il modo in cui egli viene percepito. E gli esempi sono molteplici e quotidiani: il metro di distanza dal bancone consente al negoziante di fiducia di sentire bene le richieste del cliente? L’automobilista che lascia attraversare il pedone lo fa con un’aria seccata o gentile? «Quel ragazzo che ho incontrato era un mio compagno di scuola? Beh, difficile a dirsi, con la mascherina…».
Già poco prima del lockdown non ci si stringeva più la mano e, con l’avvento della quarantena, abbiamo anche oscurato i sorrisi con le mascherine. I dispositivi di sicurezza anticontagio hanno riscritto sia il modo in cui l’individuo si pone con gli altri, sia il modo in cui egli viene percepito. E gli esempi sono molteplici e quotidiani: il metro di distanza dal bancone consente al negoziante di fiducia di sentire bene le richieste del cliente? L’automobilista che lascia attraversare il pedone lo fa con un’aria seccata o gentile? «Quel ragazzo che ho incontrato era un mio compagno di scuola? Beh, difficile a dirsi, con la mascherina…».
La comunicazione si è spostata quasi totalmente sul digitale, relegando all’offline interazioni infiacchite dalla presenza di presidi medici e da una distanza interpersonale molto maggiore rispetto al passato. In questo modo, alcuni sensi, quelli abitualmente usati in modo collaterale, sono stati completamente scalzati e sostituiti da vista e udito, fortemente messi a repentaglio dal nuovo vademecum della comunicazione. “Occhio per occhio, dente per dente”, “occhio non vede, cuore non duole”, “se non vedo, non credo”: sono innumerevoli i proverbi e le locuzioni che dimostrano quanto la vista sia il senso egemone. Lo confermano le religioni, la letteratura, la cultura popolare… insomma: gli occhi sono sempre al centro della comunicazione e dell’interazione. Doversi o potersi vedere solo in videochiamata ha aperto scenari totalmente nuovi.
 Non si tratta di un senso completamente precluso dall’interazione 2.0, come, ad esempio, l’olfatto o il gusto, ma di un senso intralciato, corrotto da impulsi fallaci, ma che trova il modo di reagire e adattarsi a nuove regole e a nuove difficoltà. Ad esempio, la situazione tipo di una conference call di lavoro è rappresentata da un mosaico di volti inquadrati in vario modo, alcuni sgranati, altri più definiti. Prospettive che non rispettano nemmeno il punto di vista dell’interlocutore, costretto a vedere non ciò che gli permette il proprio campo visivo, ma ciò che inquadra una webcam (anche e soprattutto se posizionata male). Bassa risoluzione, pixel, scatti e voci evanescenti: gli esseri umani si sono rivelati assoggettati alla stabilità di connessione. Vulnerabili non a causa di rischi o deficit concreti, ma colti nella loro inadeguatezza comica: facce che si bloccano in smorfie inconsuete, volti deformati da una rete internet che vacilla, occhi aperti o chiusi in modo asimmetrico, bocche ibernate in lunghissime vocali. È innegabile: cercare di mantenere la serietà in momenti del genere è impresa molto ardua. Provare a ricomporre i pezzi del puzzle fonico-visivo, lo è ancora di più: ricavare le informazioni complete, le frasi dell’interlocutore, al netto delle interferenze di rete, è una disperata necessità. Vivere la quarantena e la rivoluzione pandemica significa anche accettare che, durante una videochiamata, l’interlocutore possa bloccarsi o interrompersi in modo anomalo. La pausa non è un momento per rimarcare un concetto e lasciare riflettere l’ascoltatore, ma il silenzio diventa improvviso, addirittura non voluto e dannoso, perché fa il suo ingresso in modo prepotente, in un momento in cui sarebbe stato necessario ascoltare.
Non si tratta di un senso completamente precluso dall’interazione 2.0, come, ad esempio, l’olfatto o il gusto, ma di un senso intralciato, corrotto da impulsi fallaci, ma che trova il modo di reagire e adattarsi a nuove regole e a nuove difficoltà. Ad esempio, la situazione tipo di una conference call di lavoro è rappresentata da un mosaico di volti inquadrati in vario modo, alcuni sgranati, altri più definiti. Prospettive che non rispettano nemmeno il punto di vista dell’interlocutore, costretto a vedere non ciò che gli permette il proprio campo visivo, ma ciò che inquadra una webcam (anche e soprattutto se posizionata male). Bassa risoluzione, pixel, scatti e voci evanescenti: gli esseri umani si sono rivelati assoggettati alla stabilità di connessione. Vulnerabili non a causa di rischi o deficit concreti, ma colti nella loro inadeguatezza comica: facce che si bloccano in smorfie inconsuete, volti deformati da una rete internet che vacilla, occhi aperti o chiusi in modo asimmetrico, bocche ibernate in lunghissime vocali. È innegabile: cercare di mantenere la serietà in momenti del genere è impresa molto ardua. Provare a ricomporre i pezzi del puzzle fonico-visivo, lo è ancora di più: ricavare le informazioni complete, le frasi dell’interlocutore, al netto delle interferenze di rete, è una disperata necessità. Vivere la quarantena e la rivoluzione pandemica significa anche accettare che, durante una videochiamata, l’interlocutore possa bloccarsi o interrompersi in modo anomalo. La pausa non è un momento per rimarcare un concetto e lasciare riflettere l’ascoltatore, ma il silenzio diventa improvviso, addirittura non voluto e dannoso, perché fa il suo ingresso in modo prepotente, in un momento in cui sarebbe stato necessario ascoltare.
Quindi, percepire ed essere percepiti come immagine corrotta va molto oltre una semplice connessione internet basculante: è un ponte tra psicologia e sociologia, che si irradia tra Jung e Marx, individuo e società dei consumi. L’imago junghiana orienta le percezioni del soggetto attraverso degli schemi mentali che fanno elaborare le presenze con cui si interagisce come archetipi. A ciò si somma l’asse Marx-Debord che arriva a identificare una connessione tra immagini e relazioni nella società massmediatica dello spettacolo degli anni Sessanta.
Un legame che, oggi, non sarebbe difficile traslare nella presenza (e nel presenzialismo) social: «Lo spettacolo non è un insieme di immagini, ma un rapporto sociale tra individui, mediato dalle immagini» affermava il filosofo francese riattualizzando “Il Capitale”. L’immagine, quindi, non è solo il riflesso di sé su e attraverso uno schermo, ma un setaccio attraverso cui passano le percezioni e si compie la relazione con l’esterno. Restituire all’interlocutore digitale una imago accidentata, dunque, significa anche, che lo si voglia oppure no, utilizzare quell’immagine così frammentata come “biglietto da visita”. Una ripercussione non dagli esiti funesti, ma comunque significativi. Immaginare una videolezione di una classe liceale in cui la professoressa o il professore, temuti e severissimi a scuola, vengono ridotti a icone traballanti con una scarsa dimestichezza con il medium, lascia presagire con facilità quanto l’avatar possa far perdere rapidamente autorevolezza alla sua controparte in carne e ossa.
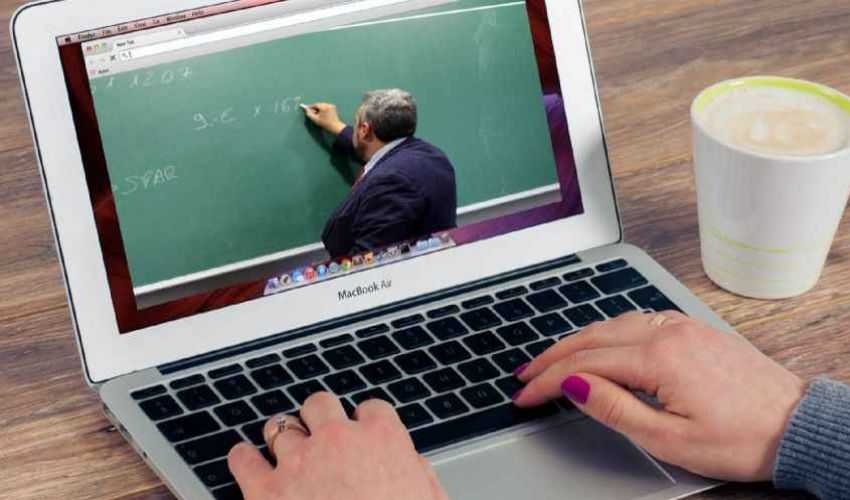 Quello della poor image è un concetto elaborato dalla poliedrica artista visuale Hito Steyerl e caratterizzato da un’immagine, appunto, povera, depauperata della terza dimensione sia fisica che psicologica. La dimensione fantasmatica, così al centro delle digressioni psicanalitiche, diventa realtà. Non solo: diventa l’unico aggancio dell’individuo con la realtà. In questo scenario, in cui il lavoro e le interazioni sociali di vario livello sono sostituiti dalle app per fare videochiamate (preferibilmente di gruppo), allora l’apparenza tanto vilipesa, nel tempo, come sinonimo di superficialità, diventa più che mai specchio della frammentazione interiore. Del resto, il concetto di glitch, l’errore digitale, era già uscito negli scorsi decenni dalla sua “comfort zone”, la tecnologia, per sconfinare nel mondo dell’arte e rappresentare la falla del sistema: l’imperfezione che rappresenta l’unicità.
Quello della poor image è un concetto elaborato dalla poliedrica artista visuale Hito Steyerl e caratterizzato da un’immagine, appunto, povera, depauperata della terza dimensione sia fisica che psicologica. La dimensione fantasmatica, così al centro delle digressioni psicanalitiche, diventa realtà. Non solo: diventa l’unico aggancio dell’individuo con la realtà. In questo scenario, in cui il lavoro e le interazioni sociali di vario livello sono sostituiti dalle app per fare videochiamate (preferibilmente di gruppo), allora l’apparenza tanto vilipesa, nel tempo, come sinonimo di superficialità, diventa più che mai specchio della frammentazione interiore. Del resto, il concetto di glitch, l’errore digitale, era già uscito negli scorsi decenni dalla sua “comfort zone”, la tecnologia, per sconfinare nel mondo dell’arte e rappresentare la falla del sistema: l’imperfezione che rappresenta l’unicità.
E, forse, gli ultimi mesi ci hanno dimostrato proprio questo: è l’essere umano il vero glitch, il robot insubordinato, l’androide che scopre di avere dei sentimenti. Nell’era del post-postumano, ci scopriamo schegge impazzite del cyberspazio, ologrammi in carne e ossa, che misurano gli affetti sullo schermo di uno smartphone e si bloccano in pose anomale.
Letizia Annamaria Dabramo
Pubblicato martedì 2 Giugno 2020
Stampato il 05/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/la-scomparsa-dei-volti-e-dintorni/








