 La riforma Renzi-Boschi, a giudizio dei sostenitori del No, è un caso lampante di cambiamento in peggio. Lo si è dimostrato analizzandola nei suoi diversi aspetti, alcuni dei quali qui richiamo per sommi capi, anche seguendo i titoli enunciati dal Referendum:
La riforma Renzi-Boschi, a giudizio dei sostenitori del No, è un caso lampante di cambiamento in peggio. Lo si è dimostrato analizzandola nei suoi diversi aspetti, alcuni dei quali qui richiamo per sommi capi, anche seguendo i titoli enunciati dal Referendum:
a) SOVRANITÀ: la riforma ci consegna un Senato non più eletto dal popolo ma da consiglieri regionali e da sindaci (che sono stati, sì, eletti dal popolo, ma per fare altre cose: cosa c’entra un sindaco con le leggi costituzionali o con i trattati europei, per dirne solo due?); e quel Senato è una delle due parti di cui si compone il Parlamento (art. 55 comma 1), che è il luogo della rappresentanza, ma non vota la fiducia al Governo (però elegge il Presidente della Repubblica ed i giudici della Corte Costituzionale, vota le leggi e modifiche costituzionali e tuttavia non vota lo stato di guerra: un pasticcio inspiegabile); con una Camera dei Deputati dove, secondo la legge elettorale vigente al momento del Referendum, «domina una maggioranza artificiale creata distorcendo l’esito del voto» (Lorenza Carlassare, costituzionalista); con le province “abolite” (in realtà solo “depennate“) che però funzionano ugualmente ma senza un organo eletto direttamente dai cittadini.
b) SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO: Oltre che sul non-voto di fiducia al Governo, il cosiddetto “superamento” è basato sulla riduzione della potestà legislativa del Senato, come descritto nell’ 70, sul quale alcune osservazioni critiche sono immediate:
1) quell’articolo è illeggibile, ed è la dimostrazione di come le cose non devono essere fatte. La Costituzione deve essere comprensibile a tutti;
2) per 16 materie la potestà legislativa resta bicamerale, esattamente come ora; inoltre, come ha scritto il Servizio Studi della Camera, «Se si considera la partecipazione al procedimento legislativo, tutti i procedimenti risultano “bicamerali” perché a tutti i procedimenti prendono parte – sia pure, nella maggior parte dei casi, con poteri diversi – entrambe le Camere»: perciò non è vero che “una sola Camera fa le leggi”, come alcuni dicono;
3) all’unico procedimento legislativo attuale si sostituisce una pluralità di procedimenti: alcuni costituzionalisti dicono che sono sette (Azzariti), altri che sono dieci (Zagrebelsky), e che potranno generare molti conflitti di competenza fra Camera e Senato, senza nessun luogo preposto alla loro risoluzione (il testo parla di “intesa”: che fra due non è mai garantita).
Quindi: Il “bicameralismo paritario” non è “superato“, come viene detto, ma è solo un po’ ridotto e molto “pasticciato” (così è definito da molti costituzionalisti).
 c) RIDUZIONE DEI PARLAMENTARI E DEI COSTI: Non è una bella bilancia quella che mette su un piatto la sovranità e sull’altro il risparmio economico: se si vuole risparmiare, bisogna farlo senza che la democrazia ne soffra. Il modo in cui la riforma riduce il Senato ed i suoi costi da un lato è inaccettabile per la soppressione di sovranità che comporta (punto “a” precedente), e dall’altro fa realizzare risparmi irrisori, che la Ragioneria dello Stato valuta in non più di 60 milioni all’anno. E poi: il Cnel si può sopprimere oppure rendere efficace, ma in ogni caso non basta a giustificare l’intera riforma; la riduzione delle indennità dei consiglieri regionali si può tranquillamente fare per legge ordinaria, senza scomodare la Costituzione.
c) RIDUZIONE DEI PARLAMENTARI E DEI COSTI: Non è una bella bilancia quella che mette su un piatto la sovranità e sull’altro il risparmio economico: se si vuole risparmiare, bisogna farlo senza che la democrazia ne soffra. Il modo in cui la riforma riduce il Senato ed i suoi costi da un lato è inaccettabile per la soppressione di sovranità che comporta (punto “a” precedente), e dall’altro fa realizzare risparmi irrisori, che la Ragioneria dello Stato valuta in non più di 60 milioni all’anno. E poi: il Cnel si può sopprimere oppure rendere efficace, ma in ogni caso non basta a giustificare l’intera riforma; la riduzione delle indennità dei consiglieri regionali si può tranquillamente fare per legge ordinaria, senza scomodare la Costituzione.
d) COMPITI DEL SENATO (art. 55 comma 5): al Senato vengono attribuiti ben 14 diversi compiti (compreso quello delle leggi e modifiche costituzionali, o della “valutazione delle politiche pubbliche”), 9 dei quali non hanno alcuna attinenza con le “istituzioni territoriali” delle quali il citato art. 55 comma 5 gli attribuisce la “rappresentanza”: una tale vastità e complessità di compiti non è conciliabile con gli impegni che competono, primariamente, a consiglieri regionali e sindaci; non è questione di buona volontà o di capacità, ma semplicemente di tempo materiale da dovere e potere dedicare a questioni molto complesse. Un Senato così non può funzionare e darebbe luogo a molti conflitti di competenza.
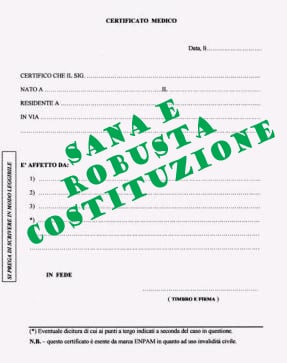 e) REVISIONE DEL TITOLO V: Una revisione delle modifiche apportate al Titolo V nel 2001 sarebbe opportuna: ma non questa, che genera un accentramento eccessivo di poteri nello Stato centrale, e un impoverimento del potere dei territori, che a parole si dice di voler esaltare, nonché un aumento della divaricazione fra le Regioni ordinarie e quelle a statuto speciale (anche perché a queste ultime non si applica la revisione del Titolo V: 9 milioni di cittadini “più uguali” degli altri); l’ex-Presidente della Corte Ugo De Siervo ha scritto che la “Riforma” porta ad «uno sgangherato riaccentramento ed a un paradossale aumento di privilegi delle Regioni speciali». Per non dire della finta “abolizione” delle Province (sottratte anch’esse al voto popolare) e della contestuale creazione di una pluralità di “enti di area vasta“.
e) REVISIONE DEL TITOLO V: Una revisione delle modifiche apportate al Titolo V nel 2001 sarebbe opportuna: ma non questa, che genera un accentramento eccessivo di poteri nello Stato centrale, e un impoverimento del potere dei territori, che a parole si dice di voler esaltare, nonché un aumento della divaricazione fra le Regioni ordinarie e quelle a statuto speciale (anche perché a queste ultime non si applica la revisione del Titolo V: 9 milioni di cittadini “più uguali” degli altri); l’ex-Presidente della Corte Ugo De Siervo ha scritto che la “Riforma” porta ad «uno sgangherato riaccentramento ed a un paradossale aumento di privilegi delle Regioni speciali». Per non dire della finta “abolizione” delle Province (sottratte anch’esse al voto popolare) e della contestuale creazione di una pluralità di “enti di area vasta“.
L’ampiezza della Revisione costituzionale (tale è, più che una “modifica”, riguardando ben 47 articoli) comporta uno sforzo di informazione e comprensione improbo, se non impossibile, per un largo numero di cittadini, e dimostra quanto i sostenitori del NO hanno più volte affermato: vale a dire che il cambiamento non è, in sé, né positivo né negativo, poiché la sua qualità (e quindi l’aggettivo che gli si può attribuire) dipende dai contenuti. Si può cambiare in meglio, ed è allora opportuno farlo; ma si può cambiare anche in peggio, ed allora è bene (e perfino doveroso) opporsi ad esso. Non è perciò razionalmente fondato (come spesso fanno molti della parte del Sì) accusare chi sostiene il NO di non volere “il cambiamento in sé e per sé” e di essere perciò “ancorati al vecchio”: ci si oppone invece, si obietta da parte del NO, non al cambiamento senza aggettivi ma ad un cattivo cambiamento, ed in questo caso essere conservatori – l’accusa che viene loro rivolta – ha un senso positivo. Anche i peggiori fatti della storia hanno rappresentato un cambiamento – banalmente: ciò che è diverso dal precedente è sempre un cambiamento – ma non è questo a renderli meno odiosi di quanto meritino; altre volte il cambiamento ha apportato benefici e progresso: ma non semplicemente in quanto diverso o nuovo (questo sarebbe “nuovismo”), bensì perché migliore, rispetto a prima. Le cose, sembra banale eppure per alcuni non lo è, vanno valutate non tanto e non solo per il tasso di novità che contengono, ma per i progressi positivi che comportano; l’alternativa non è fra movimento e stagnazione o termini analoghi, perché il “movimento” può essere in avanti ma anche all’indietro: non basta muoversi per essere sicuri di far bene, bisogna essere coscienti e sicuri della direzione che si prende e della strada a cui il movimento porta. E quando (o se) muoversi significa arretrare, restare fermi non costituisce “stagnazione” ma difesa di quanto si ha, in attesa, e con il proposito, di costruire qualcosa di veramente migliore: la vera diade, in questo caso, è fra avventura e consolidamento.

Noi speriamo che il NO prevalga ed apra la strada all’applicazione reale della Costituzione, che finora è troppo spesso mancata, per poterle anche apportare, ricercando il massimo consenso possibile, quei pochi adeguamenti che la ragione democratica suggerisce. Con questo animo, con tale “sentimento costituzionale” – come ha detto l’ANPI – guardiamo, fiduciosi, all’esito delle votazioni.
Buon voto e, soprattutto, Buona Costituzione a noi tutti.
Franco Bianco – Ricercatore in scienze economiche e sociali
Pubblicato venerdì 2 Dicembre 2016
Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/pillole-finali-di-riflessione-e-poi-buona-costituzione-a-tutti/



