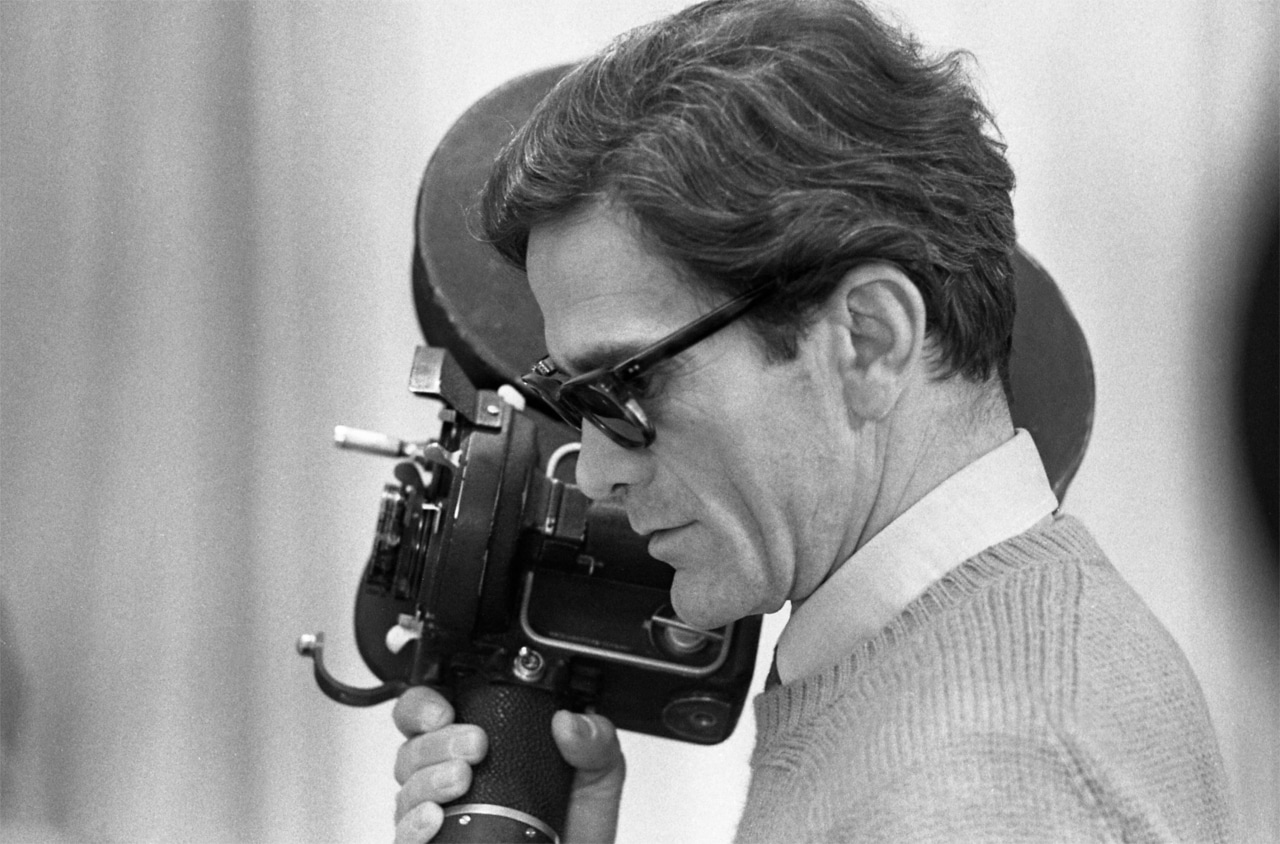Collaborazioni a distanza, da remoto, telelavoro: lo smart working, ben prima della pandemia, aveva già dei parenti prossimi della cui esistenza non tutti erano al corrente. Ecco perché la risonanza del fenomeno all’indomani del lockdown è stata così discussa (avevamo già affrontato il tema in un precedente articolo). Non che questo sminuisca l’effettivo portato innovativo dello smart working ma, semplicemente, se negli anni fossero state contemplate modalità alternative al lavoro in praesentia, forse, il lockdown non avrebbe destabilizzato così tanto.
Infatti, sembra che lo smart working, nel 2020, abbia delineato orizzonti del tutto inediti. Ha abbattuto gli scenari fantozziani, ad esempio, e questo è un merito che bisogna riconoscere alla “new wave” del lavoro in quarantena.
Ma è tutto oro quello che luccica? O meglio, sono stati solo sfavillii quelli che ha portato con sé lo smart working? La risposta è, senza dubbio, no.

Trovarsi costretti a ridisegnare i confini delle proprie interazioni e del proprio raggio d’azione all’interno di un perimetro domestico non è stata cosa semplice. Per quanto alienante, il luogo di lavoro è, appunto, quello preposto all’espletamento dei compiti quotidiani, all’interazione con colleghi, superiori e clienti. Il lockdown ha condensato tutto ciò all’interno di pochi metri quadri: anzi, pochissimi, se si pensa alla condizione di lavoratori fuori sede che condividono una casa con altri in condizioni analoghe.

Quindi, le quattro mura sono state costrette ad assurgere, per causa di forza maggiore, al ruolo più ampio di luogo di lavoro, oltre che al luogo designato per le interazioni sociali (rigorosamente, anche quelle, in videochiamata, se si escludono conviventi e coinquilini) e per la quotidianità domestica.
Videochiamate e conference call con colleghi e superiori hanno, inoltre, fatto intravvedere una nuova idea di gerarchia. L’idea di “entrare” nella casa del proprio capo e poterne scorgere, attraverso il segmento di vita che la webcam riusciva a restituire, l’arredamento o il comportamento del superiore in altri contesti (grazie alle interferenze di figli capricciosi o coniugi “presenti”) non è un dato marginale.
 Così come, a questo elemento di scoperta, se ne aggiunge un altro, capace di allungare la lista dei diritti dei lavoratori calpestati: gli orari. Venendo meno la colonna portante del lavoro salariato, vale a dire le 8 ore lavorative (più quella centrale rappresentata dalla pausa pranzo) e, soprattutto, non essendoci motivazioni plausibili che potessero rappresentare un diversivo (dire di avere un impegno, durante la quarantena, avrebbe suscitato grande ilarità), il lavoro ha dilagato, sconfinando in altre fasce orarie, solitamente destinate a impegni e svaghi del tutto personali.
Così come, a questo elemento di scoperta, se ne aggiunge un altro, capace di allungare la lista dei diritti dei lavoratori calpestati: gli orari. Venendo meno la colonna portante del lavoro salariato, vale a dire le 8 ore lavorative (più quella centrale rappresentata dalla pausa pranzo) e, soprattutto, non essendoci motivazioni plausibili che potessero rappresentare un diversivo (dire di avere un impegno, durante la quarantena, avrebbe suscitato grande ilarità), il lavoro ha dilagato, sconfinando in altre fasce orarie, solitamente destinate a impegni e svaghi del tutto personali.

Il lavoro ha sempre portato con sé enormi cambiamenti (coincisi, spesso e non a caso, con la definizione di rivoluzioni): lo sviluppo in altezza delle città, l’estensione in larghezza verso un hinterland dai confini scoloriti, l’urbanizzazione coercitiva e la progressiva sottrazione di spazio alle aree rurali per assecondare l’ipertrofia lavorativa, demografica e urbanistica delle città. Perciò pensare che, in modo analogo, lo smart working non provochi cambiamenti è una considerazione che trascura il periodo di fondamentale importanza e unicità storiche che stiamo vivendo.
Già la storia recente ci aveva restituito edifici divenuti ormai di archeologia industriale ma, solo fino a pochi anni o decenni fa, ancora destinati a ospitare delle figure professionali.
È il caso dei caselli autostradali, strutture che oggi risultano un po’ sovrabbondanti nell’assolvere all’unica funzione di inserimento del denaro ed erogazione del ticket. La figura del casellante non c’è più e, allo stesso modo, stanno scomparendo o si stanno depotenziando altri mestieri. È il caso, ad esempio, del benzinaio, sempre meno presente e sostituito dalle postazioni self, disponibili 24 ore su 24 e a costi più ridotti. Il meccanismo è semplice: l’alleggerimento del lavoro, di spazi, tempi e costi, passa dalla sostituzione dell’intermediazione umana con un terminale interattivo. Il risultato più evidente di questo processo è la trasformazione progressiva dei luoghi in nonluoghi, gli spazi teorizzati da Marc Augé, concentrato di postmodernità.

L’impersonalità incontra, in questa steppa del mondo del lavoro che fu, una stratificazione di funzioni ed edifici. Il passaggio di staffetta tra l’impiegato umano e la sua controparte digitale è ben digerita: ottimizza i tempi e le modalità di erogazione di un servizio, porta un miglioramento performativo e un sensibile risparmio per utenti o clienti. Si è ben lontani, come è evidente, dal congetturare ipotesi sulla ribellione della macchina all’uomo-demiurgo, ma delle riflessioni sul tema non si possono negare.

L’archeologia industriale, anche quella di recentissima formazione a causa della dismissione di una figura professionale poco dopo la sua istituzione, è lì a confermare che la razionalizzazione degli spazi non è stata, probabilmente, la cifra più emblematica dell’Italia del boom economico. In altre parole, accanto a ecomostri ed edifici che, a vario livello, per abusivismo, presenza di materiali nocivi, assenza di criteri antisismici (e l’elenco potrebbe allungarsi rapidamente) sono incompatibili con lo stile di vita e le norme di sicurezza di questi decenni, si registrano delle opere – in molti casi faraoniche – totalmente svuotate della loro funzione. E oggi, in numerose zone d’Italia, si assiste alla riqualifica di questi stessi spazi urbani e archeoindustriali; in molti casi, poi, le aree in questione vivono una riqualifica, oltre che strutturale, anche etica. E così, fabbriche dismesse precedentemente adibite alla lavorazione di tabacchi o di sostanze dannose, attraversano una stagione florida e intensa, fatta di partecipazione civile ed eventi culturali.

Nell’era del (quasi) post Covid, ci si trova a compiere un ulteriore passo: lasciandosi alle spalle i colossi edili dei decenni scorsi, caratterizzati, in modo paradossale, da corridoi angusti, stanze e uffici claustrofobici e ambienti bui, l’edilizia del lavoro si apre a costruzioni sensate e pensate per soddisfare requisiti di luce, spazio, vivibilità – che incidono in modo finora quasi impensato sulla qualità della vita del dipendente e, dunque, sulla sua performatività lavorativa.
I “recinti” lavorativi sono stati riprogettati, aprendo lo scenario urbano a nuovi luoghi e a nuove concezioni dello spazio di lavoro. Hub e coworking, ad esempio, sono le formule che hanno segnato in modo considerevole il decennio 2010-2020 e continuano a farlo. Rappresentano una intelligente razionalizzazione degli spazi, nonché un costo di affitto più sopportabile da piccole aziende in fase di start-upping, che sono quelle che popolano, per la maggior parte, questi “incubatori” di business. Il nuovo corso ha imposto una parola chiave, che riassume l’approccio al lavoro degli ultimi anni: smart. Perciò, questi smart building, fatti per ottimizzare simultaneamente risorse strutturali e mansioni, sono pensati per la tecnologia, con postazioni progettate su misura per laptop e dispositivi tecnologici, con uno sguardo alla sostenibilità, sia sotto il profilo dell’edilizia che sotto quello umano. Spazi che, probabilmente, sono destinati a vivere la loro età dell’oro a breve, quando il rischio pandemia sarà sfumato ma, contestualmente, si sarà insinuato un nuovo modo di lavorare, in cui il lavoratore farà propria, in modo stabile, l’“agilità” dello smart working.
 Senza escludere il “nomadismo lavorativo”, il lavoro da casa o da altre postazioni come treni o stanze d’albergo, residenze temporanee per manager e dipendenti in trasferta, i prossimi anni dovrebbero essere dedicati a comprendere pro e contro dello smart working per perfezionare le modalità e puntare, finalmente, a un’idea di lavoro “sostenibile”, in cui la produttività resta un criterio determinante, ma l’abnegazione del lavoratore non si traduce più in estenuanti straordinari (spesso non retribuiti, per giunta) necessari solo a ribadire l’equazione secondo cui la presenza prolungata sul luogo di lavoro sia sinonimo di maggiore dedizione.
Senza escludere il “nomadismo lavorativo”, il lavoro da casa o da altre postazioni come treni o stanze d’albergo, residenze temporanee per manager e dipendenti in trasferta, i prossimi anni dovrebbero essere dedicati a comprendere pro e contro dello smart working per perfezionare le modalità e puntare, finalmente, a un’idea di lavoro “sostenibile”, in cui la produttività resta un criterio determinante, ma l’abnegazione del lavoratore non si traduce più in estenuanti straordinari (spesso non retribuiti, per giunta) necessari solo a ribadire l’equazione secondo cui la presenza prolungata sul luogo di lavoro sia sinonimo di maggiore dedizione.
Sconfiggere l’idea che, quanto più tempo si passa in ufficio, tanto più si è instancabili stacanovisti, sarebbe il lascito più fruttuoso della pandemia al mondo del lavoro. O forse, in una visione più cupa e utopica, la parentesi smart working sarà destinata a esaurirsi in breve tempo, decretando una rivincita morale e urbanistica degli ecomostri e un controllo di orari e mansioni non troppo distante dagli scenari orwelliani.
Letizia Annamaria Dabramo
Pubblicato sabato 19 Settembre 2020
Stampato il 15/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/longform/agile-flessibile-quasi-evanescente/