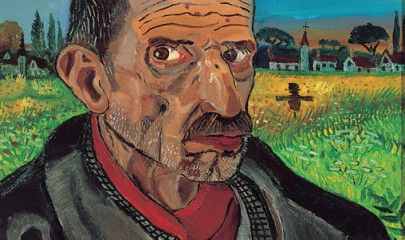È nato nei primi anni Settanta del secolo scorso a Bristol, in Inghilterra, e le sue opere, dislocate in tutto il mondo, fanno discutere ed emozionare. Lavora in maniera semiclandestina e nessuno ne conosce la vera identità. In molti hanno cercato di smascherarlo, di tracciarne una biografia ma Banksy, lo street artist più influente dei nostri tempi, è sempre riuscito a nascondersi e a lavorare nell’anonimato. Con uno stile provocatorio, l’artista scuote da anni le coscienze, parlando in maniera semplice e diretta dei grandi problemi del nostro secolo, dalla guerra all’immigrazione, dalla povertà alle ingiustizie sociali. Iconici alcuni suoi lavori: la bambina a cui sfugge un palloncino con accanto la scritta “c’è sempre speranza” (Balloon Girl, Londra 2002), i due poliziotti che si baciano (Kissing coppers, Brighton, 2004), il lanciatore di fiori (Flower Thrower, Gerusalemme 2003), gli amanti con lo smartphone (Mobile Lovers, Bristol 2014), gli uccelli della stessa specie (Birds of a Feather, Essex 2014). Tutte immagini, queste, entrate nell’immaginario moderno, emblema visivo per tutti coloro che non si arrendono e sperano in un futuro migliore.
È nato nei primi anni Settanta del secolo scorso a Bristol, in Inghilterra, e le sue opere, dislocate in tutto il mondo, fanno discutere ed emozionare. Lavora in maniera semiclandestina e nessuno ne conosce la vera identità. In molti hanno cercato di smascherarlo, di tracciarne una biografia ma Banksy, lo street artist più influente dei nostri tempi, è sempre riuscito a nascondersi e a lavorare nell’anonimato. Con uno stile provocatorio, l’artista scuote da anni le coscienze, parlando in maniera semplice e diretta dei grandi problemi del nostro secolo, dalla guerra all’immigrazione, dalla povertà alle ingiustizie sociali. Iconici alcuni suoi lavori: la bambina a cui sfugge un palloncino con accanto la scritta “c’è sempre speranza” (Balloon Girl, Londra 2002), i due poliziotti che si baciano (Kissing coppers, Brighton, 2004), il lanciatore di fiori (Flower Thrower, Gerusalemme 2003), gli amanti con lo smartphone (Mobile Lovers, Bristol 2014), gli uccelli della stessa specie (Birds of a Feather, Essex 2014). Tutte immagini, queste, entrate nell’immaginario moderno, emblema visivo per tutti coloro che non si arrendono e sperano in un futuro migliore.
 Le sue opere hanno implicazioni politiche e sociali e, senza fronzoli, denunciano le storture della società capitalista. Come un moderno Picasso, Banksy usa la sua arte per manifestare il proprio dissenso contro i conflitti bellici e, in particolare, a sostegno della causa palestinese. La catastrofe del popolo palestinese è infatti una delle questioni più importanti del nostro tempo. Sono già tre le generazioni di bambini cresciuti nei campi profughi in condizioni di miseria e privati dei loro diritti. Migliaia di palestinesi subiscono ogni giorno discriminazioni. «La Palestina – afferma l’artista – è occupata dall’esercito israeliano dal 1967. Nel 2002 il governo di Israele iniziò a costruire un muro che separa i territori occupati da Israele, la maggior parte non conforme alle leggi internazionali. Il muro è controllato da una serie di checkpoint e torri d’osservazione, è alto tre volte il muro di Berlino ed è lungo 700 chilometri, la stessa distanza che c’è fra Londra e Zurigo. La Palestina è oggi la prigione a cielo aperto più grande del mondo e la destinazione ultima per gli artisti di graffiti». E proprio sul quel muro, nel 2005, Banksy realizza alcuni lavori: si tratta di finte aperture che proiettano immagini di paesaggi esotici e montani, un passaggio fra mondo ideale e mondo reale. Sul muro compare anche la colomba della pace con il suo rametto di ulivo, provvista però anche di un giubbotto antiproiettile, con un mirino puntato sul cuore: segno evidente che le trattative di pace hanno fallito. La richiesta di liberazione del popolo palestinese è palesata dalle figure di alcuni bambini che scavano delle buche alla ricerca di una via di fuga, o ancora da una bambina che cerca di superare la barriera aggrappata a palloncini ad elio.
Le sue opere hanno implicazioni politiche e sociali e, senza fronzoli, denunciano le storture della società capitalista. Come un moderno Picasso, Banksy usa la sua arte per manifestare il proprio dissenso contro i conflitti bellici e, in particolare, a sostegno della causa palestinese. La catastrofe del popolo palestinese è infatti una delle questioni più importanti del nostro tempo. Sono già tre le generazioni di bambini cresciuti nei campi profughi in condizioni di miseria e privati dei loro diritti. Migliaia di palestinesi subiscono ogni giorno discriminazioni. «La Palestina – afferma l’artista – è occupata dall’esercito israeliano dal 1967. Nel 2002 il governo di Israele iniziò a costruire un muro che separa i territori occupati da Israele, la maggior parte non conforme alle leggi internazionali. Il muro è controllato da una serie di checkpoint e torri d’osservazione, è alto tre volte il muro di Berlino ed è lungo 700 chilometri, la stessa distanza che c’è fra Londra e Zurigo. La Palestina è oggi la prigione a cielo aperto più grande del mondo e la destinazione ultima per gli artisti di graffiti». E proprio sul quel muro, nel 2005, Banksy realizza alcuni lavori: si tratta di finte aperture che proiettano immagini di paesaggi esotici e montani, un passaggio fra mondo ideale e mondo reale. Sul muro compare anche la colomba della pace con il suo rametto di ulivo, provvista però anche di un giubbotto antiproiettile, con un mirino puntato sul cuore: segno evidente che le trattative di pace hanno fallito. La richiesta di liberazione del popolo palestinese è palesata dalle figure di alcuni bambini che scavano delle buche alla ricerca di una via di fuga, o ancora da una bambina che cerca di superare la barriera aggrappata a palloncini ad elio.
 Ad un’altra bambina, invece, Banksy affida la denuncia di un altro problema che affligge la nostra società, quello delle politiche di accoglienza in Europa. In questo caso la piccola è un personaggio conosciuto: è la Cosette dei Miserabili di Victor Hugo, simbolo delle condizioni disumane in cui sono costretti a vivere i rifugiati. L’opera è apparsa nel 2016 sulla parete dell’ambasciata francese di Londra.
Ad un’altra bambina, invece, Banksy affida la denuncia di un altro problema che affligge la nostra società, quello delle politiche di accoglienza in Europa. In questo caso la piccola è un personaggio conosciuto: è la Cosette dei Miserabili di Victor Hugo, simbolo delle condizioni disumane in cui sono costretti a vivere i rifugiati. L’opera è apparsa nel 2016 sulla parete dell’ambasciata francese di Londra.
Qualche mese prima su un muro del campo profughi di Calais in Francia, in cui vivono oltre 4000 migranti, ha disegnato “il figlio di un migrante siriano”, ovvero Steve Jobs, cofondatore di Apple e figlio di un migrante siriano. «Siamo inclini a pensare – commenta l’artista – che l’immigrazione rappresenti un danno per le risorse di un Paese e invece Steve Jobs era il figlio di un migrante siriano. Apple paga circa 7 miliardi di dollari all’anno di tasse ed esiste unicamente perché l’America ha accolto un giovane uomo da Homs».
Quella promossa da Banksy è una guerriglia urbana costante, capace di creare un inciampo visivo e interrompere la distrazione collettiva. Con un linguaggio espressivo immediato, l’artista sposta l’interesse dalla forma al contenuto, nobilitando l’arte di strada a qualcosa di più che una semplice decorazione estetica. Suo il merito di aver convinto anche i più scettici a superare la concezione che considera le scritte sui muri solamente delle azioni vandaliche, e di aver promosso una riflessione sull’importanza di questo tipo di linguaggio. Un linguaggio di resistenza artistica, politico e ribelle. Ed è proprio per questo che, spesso, le opere dell’artista sono state cancellate dalle autorità. «Gli amministratori delle nostre città – commenta Banksy – non capiscono i graffiti perché per loro nulla ha il diritto di esistere se non dà profitto. Ma i veri deturpatori dei nostri quartieri sono le aziende che scrivono giganteschi slogan sulle facciate degli edifici e degli autobus, cercando di farci sentire in difetto se non acquistiamo i loro prodotti».
 Detrattore della mercificazione dell’arte, Banksy combatte l’establishment per ricordare a tutti che l’arte deve essere democratica e non un settore riservato soltanto ad una cerchia ristretta e facoltosa. «Ho sempre creduto – racconta l’artista – che la bellezza dell’arte di strada stesse nella sua capacità di trasformare le città in musei, in centri aperti a tutti, ad ogni tipologia di pubblico possibile. Un museo gratuito, in cui i biglietti da visita sono gli sguardi delle persone e le occhiate dei passanti. Il messaggio diventa così qualcosa di immediato, libero da ragionamenti controversi e posticci, che passa dal grezzo muro per colpire l’interiorità di ognuno di noi». In questo senso, nel 2013 l’artista realizza a New York Better out than in (Meglio fuori che dentro): un grande progetto artistico della durata di un mese, durante il quale Banksy disloca per le strade della grande mela un suo lavoro, annunciato sul suo profilo Instagram. Una mostra a cielo aperto gratuita che ha spinto tutto il pubblico newyorkese a partecipare ad una grande caccia al tesoro e portandolo a visitare quartieri periferici dove l’arte, senza Banksy, non sarebbe mai arrivata. «I graffiti – spiega l’artista – sono uno dei pochi strumenti in mano a chi non ha quasi niente. E anche se non si inventa un’immagine in grado di cancellare la miseria umana, può sempre riuscire a strappare un sorriso».
Detrattore della mercificazione dell’arte, Banksy combatte l’establishment per ricordare a tutti che l’arte deve essere democratica e non un settore riservato soltanto ad una cerchia ristretta e facoltosa. «Ho sempre creduto – racconta l’artista – che la bellezza dell’arte di strada stesse nella sua capacità di trasformare le città in musei, in centri aperti a tutti, ad ogni tipologia di pubblico possibile. Un museo gratuito, in cui i biglietti da visita sono gli sguardi delle persone e le occhiate dei passanti. Il messaggio diventa così qualcosa di immediato, libero da ragionamenti controversi e posticci, che passa dal grezzo muro per colpire l’interiorità di ognuno di noi». In questo senso, nel 2013 l’artista realizza a New York Better out than in (Meglio fuori che dentro): un grande progetto artistico della durata di un mese, durante il quale Banksy disloca per le strade della grande mela un suo lavoro, annunciato sul suo profilo Instagram. Una mostra a cielo aperto gratuita che ha spinto tutto il pubblico newyorkese a partecipare ad una grande caccia al tesoro e portandolo a visitare quartieri periferici dove l’arte, senza Banksy, non sarebbe mai arrivata. «I graffiti – spiega l’artista – sono uno dei pochi strumenti in mano a chi non ha quasi niente. E anche se non si inventa un’immagine in grado di cancellare la miseria umana, può sempre riuscire a strappare un sorriso».
 Quasi sempre monocromatiche, le immagini di Banksy raccontano la storia dei più poveri, degli umili, di tutta quella parte di società che, altrimenti, rimarrebbe senza voce. «Le opere di Banksy – commenta l’artista e collega Shepard Fairey – sono piene di immagini metaforiche che trascendono le barriere linguistiche. Le immagini sono divertenti e brillanti, eppure semplici e accessibili: anche se i bambini di sei anni non hanno la minima idea di che cosa sia un conflitto culturale, non avranno alcun problema a riconoscere che c’è qualcosa che non quadra vedendo Monna Lisa che impugna un lanciafiamme». Fra i segni più ripetuti compaiono i “rats”, i ratti, simbolo della classe di reietti, ipnotizzata, confusa e ribelle. Una classe sempre più numerosa, che annovera chi, nella società dei consumi, ha pochi diritti e nessun lavoro. Una classe, però, tenace e ostinata, impegnata nella disobbedienza civile con l’obiettivo di smascherare l’inutilità di certe norme. Fra i più famosi, ricordiamo i topi che realizzano graffiti manifestando il proprio scontento sociale, quelli che indossano il simbolo della pace o ritratti in prossimità di un divieto nell’atto di violarne la regola (Welcome to hell, Let them eat crack, Because I’m Worthless). Con i piccoli topini Banksy sollecita riflessioni in ognuno di noi, attori attivi nella società che possiamo far finta di niente o sentirci impotenti, possiamo sperare o essere consapevoli che a certe barbarie ci si deve opporre con tutti i mezzi possibili.
Quasi sempre monocromatiche, le immagini di Banksy raccontano la storia dei più poveri, degli umili, di tutta quella parte di società che, altrimenti, rimarrebbe senza voce. «Le opere di Banksy – commenta l’artista e collega Shepard Fairey – sono piene di immagini metaforiche che trascendono le barriere linguistiche. Le immagini sono divertenti e brillanti, eppure semplici e accessibili: anche se i bambini di sei anni non hanno la minima idea di che cosa sia un conflitto culturale, non avranno alcun problema a riconoscere che c’è qualcosa che non quadra vedendo Monna Lisa che impugna un lanciafiamme». Fra i segni più ripetuti compaiono i “rats”, i ratti, simbolo della classe di reietti, ipnotizzata, confusa e ribelle. Una classe sempre più numerosa, che annovera chi, nella società dei consumi, ha pochi diritti e nessun lavoro. Una classe, però, tenace e ostinata, impegnata nella disobbedienza civile con l’obiettivo di smascherare l’inutilità di certe norme. Fra i più famosi, ricordiamo i topi che realizzano graffiti manifestando il proprio scontento sociale, quelli che indossano il simbolo della pace o ritratti in prossimità di un divieto nell’atto di violarne la regola (Welcome to hell, Let them eat crack, Because I’m Worthless). Con i piccoli topini Banksy sollecita riflessioni in ognuno di noi, attori attivi nella società che possiamo far finta di niente o sentirci impotenti, possiamo sperare o essere consapevoli che a certe barbarie ci si deve opporre con tutti i mezzi possibili.
Francesca Gentili, critica d’arte
Per chi fosse interessato a scoprire l’arte di Banksy, fino al 14 aprile 2019, il Mudec di Milano presenta The Art of Banksy, a visual protest, una mostra non autorizzata dall’artista che espone settanta lavori provenienti da alcune prestigiose collezioni private internazionali.
Pubblicato venerdì 7 Dicembre 2018
Stampato il 16/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/forme/banksy-lemozione-e-il-paradosso/