
Un’arte espressiva richiama le altre, in un accrescersi di potenzialità di comunicazione. L’evoluzione dei mezzi comporta il moltiplicarsi e il raffinarsi delle tecniche. E quest’ultime non si soppiantano in chiave temporale, ma si integrano vicendevolmente. La cinematografia si è nutrita del mezzo fotografico: esso, a sua volta, ha fatto tesoro della grafica e delle arti pittoriche. Quel che fa arte attraverso un mezzo tecnico è la capacità di esprimere una visione, uno sguardo particolare su ciò che si sta descrivendo e narrando. L’analisi delle dinamiche di realizzazione di un’opera e degli strumenti utilizzati è il presupposto della critica. Tutto concorre all’ermeneutica: ed essa non può non proporsi la necessità di una lettura etica di quanto si ha davanti.

La fotografia per me è stato un approccio al cinema; quello che ho imparato in gioventù con l’uso della camera me lo sono ritrovato come patrimonio di comprensione quando ho cominciato a occuparmi di cinematografia in maniera consapevole. Non sono mai stato un fotografo degno di questo nome: ma quanto mi sforzavo di tradurre in una inquadratura ha rappresentato un mio modo per circoscrivere, capire, analizzare uno spicchio di realtà, un contesto, una dinamica di azione.

Ho avuto modo di vedere a Torino la mostra dedicata al lavoro di una grande fotografa statunitense, Dorothea Lange, dal titolo “Racconti di vita e lavoro”, curata da Monica Poggi e Walter Guadagnini (c’è ancora tempo fino all’otto ottobre). La vicenda umana di questa artista è molto interessante. Dopo un’infanzia travagliata da problemi fisici e familiari, diventò una ritrattista di successo: ma decise di dedicarsi piuttosto ad una fotografia che tenesse conto delle urgenze storiche. Sposato in seconde nozze Paul S. Taylor, si occupò con lui e per conto del Dipartimento delle Aree Rurali di documentare vita e passione degli agricoltori statunitensi, costretti da un’emergenza climatica a trasferirsi, dagli Stati del centro, verso le coste.

Siamo negli anni 30\40, la Grande Depressione americana: una fase terribile di povertà estrema e dolore, che sembrò tagliare le gambe a uno dei più grandi Paesi del mondo, fino ad allora in forte crescita. Lange segue gli itinerari migratori delle famiglie e narra per immagini la sofferenza delle classi lavoratrici. In particolare delle donne, le madri, le bambine e i bambini.

Una foto su tutte, che riporta in mostra titolo e didascalia originale, redatta dalla stessa Lange: Madre migrante. Raccoglitori poveri di piselli in California. Madre di sette figli. Età: trentadue. Nipomo, California. 1936. Una donna di 32 anni che sembra averne il doppio, con un neonato in braccio e altri due figli appoggiati su di lei. Una maternità di respiro sacro, capace di racchiudere in solo scatto fatica, sofferenza, ingiustizia, ma anche dignità e valore. Quelli delle classi sociali più umili, sistematicamente costrette a subire le conseguenze di crisi decise altrove, che arricchiscono pochi e feriscono molti. Il capitalismo statunitense non impiegò molto a risollevarsi, ma il prezzo fu comunque pagato dalle classi sociali più umili.

Il lavoro di Lange ebbe comunque dei risultati positivi: in seguito al New Deal del presidente Roosevelt, cominciarono ad arrivare sussidi e molti riuscirono a uscire dall’indigenza più feroce. La foto della Lange fu usata nelle campagne di sensibilizzazione politica. In seguito lei e Taylor furono chiamati a documentare la condizione degli americani di origine giapponese, che dopo lo scoppio del conflitto nippo-statunitense furono confinati in aree prescritte del Paese fino alla fine della guerra. Presa posizione pubblicamente contro questa risoluzione, i due poterono lavorare solo a condizione di eliminare alcuni aspetti di quanto stava accadendo, senza mostrare recinzioni e filo spinato.
 In seguito Dorothea fu nel primo nucleo operativo della mitica agenzia di fotografia Magnum Photos, che ha segnato la storia dell’informazione, e della fotografia in quanto tale, del XX secolo. Continuò il suo lavoro, in particolare per la rivista Life, nonostante i vari problemi di salute che la affliggevano: nel 1965, a 70 anni, dovette arrendersi ad un cancro all’esofago.
In seguito Dorothea fu nel primo nucleo operativo della mitica agenzia di fotografia Magnum Photos, che ha segnato la storia dell’informazione, e della fotografia in quanto tale, del XX secolo. Continuò il suo lavoro, in particolare per la rivista Life, nonostante i vari problemi di salute che la affliggevano: nel 1965, a 70 anni, dovette arrendersi ad un cancro all’esofago.
Ho visto negli anni diverse esposizioni delle fotografe e dei fotografi dell’agenzia Magnum. Oltre all’ammirazione per i risultati tecnici, ottenuti con macchine di buon livello ma di capacità ridotta rispetto a quelle di adesso, sono sempre stato colpito dall’impegno sociale profuso e dalle loro biografie, sovente contraddistinte da scelte forti, coraggiose, spesso pagate a caro prezzo. Una fotografia sociale, che diviene inevitabilmente politica e militante. Durante la seconda guerra mondiale gli scatti della Magnum raccontarono i teatri di conflitto con efficacia mirabile, contribuendo a definire torti e colpe rispetto alla guerra stessa. Se non è certo la prima guerra narrata con le fotografie, sarà la prima in cui la fotografia stessa rivestirà un ruolo così importante per l’opinione pubblica.

Si pensi alla figura di Robert Capa, pseudonimo di Endre Ernő Friedmann, di origine ungherese, senza il cui lavoro non avremmo avuto dei reportage così importanti sulla Guerra Civile Spagnola (e forse l’opinione pubblica statunitense sarebbe stata più sedotta dalle sirene franchiste) e le varie guerre a seguire. Capa è autore tra l’altro di un libro bellissimo sui suoi itinerari di vita: Leggermente fuori fuoco, edizioni Contrasto. Morì saltando su una mina, durante la guerra d’Indocina, nel 1954: aveva 40 anni. La sua compagna Gerda Porohylle Taro, tedesca, fu con lui fotoreporter in Spagna e lì mori, a 26 anni, nel 1937, schiacciata da un carro armato. David Szymin, conosciuto con il cognome Seymour, polacco, grande fotografo umanista, morì nel 1956, durante la crisi di Suez, falciato da una mitragliatrice.

Impossibile non citare Henry Cartier-Bresson, francese, classe 1908 (fortunatamente morto nel suo letto, molti anni dopo), anch’egli fotografo di enorme sensibilità sociale. Tutte persone con forti motivazioni politiche, antifasciste, coinvolte nelle guerre del 900 con un ruolo che adesso possiamo comprendere con maggior chiarezza: una generazione di fotoreporter con caratteristiche artistiche, che con la loro militanza hanno scritto pagine rilevanti non solo nella storia della fotografia, ma anche in quella dell’anti nazifascismo, combattuto con le immagini.

Del resto Woody Guthrie, meraviglioso cantore proprio delle lotte sociali degli anni 30, aveva scritto sulla chitarra This Machine Kills Fascists, Questa macchina ammazza i fascisti. Come potete immaginare ebbe i suoi guai, soprattutto durante l’imperversare del senatore McCarthy e della Commissione per le attività antiamericane. Motivazioni di vario genere (Capa e Taro erano comunisti, Seymour di origine ebraica, Cartier-Bresson partecipò alla Resistenza francese, Lange aderì a quell’umanesimo di stampo socialista che innervò prima le lotte sociali, poi quelle per i diritti civili, negli Stati Uniti) ma uno stesso spirito nell’uso sociale di un mezzo tecnico che altrove conobbe ben altro uso: i regimi falsificano e manipolano, donne e uomini liberi sanno bene quanto è importante dire la verità, a qualunque prezzo. Non a caso, l’impegno sociale anche loro, è stato spesso perseguito con motivazioni di ordine antisovversive: l’accusa è sempre stata (e rimane), quella di essere comunisti. Capitato spesso anche a me: la cosa non mi fa problema.
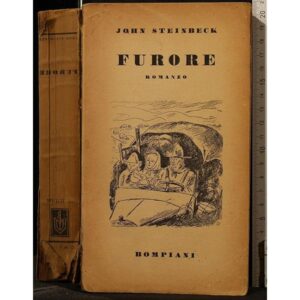 Come avete capito, ho fatto una rassegna di percorsi emotivi, quindi politici, più che recensire una mostra. Aggiungo altre due emozioni. Dal capolavoro Furore, di John Steinbeck, 1939, fu tratto nel 1940 l’omonimo film, con la regia del maestro John Ford. Nel 1995 Bruce Springsteen trae dal libro la linea narrativa dell’album The ghost of Tom Joad. La canzone che dà il titolo a questo lavoro è una delle sue più belle. Nonché una delle canzoni della mia vita.
Come avete capito, ho fatto una rassegna di percorsi emotivi, quindi politici, più che recensire una mostra. Aggiungo altre due emozioni. Dal capolavoro Furore, di John Steinbeck, 1939, fu tratto nel 1940 l’omonimo film, con la regia del maestro John Ford. Nel 1995 Bruce Springsteen trae dal libro la linea narrativa dell’album The ghost of Tom Joad. La canzone che dà il titolo a questo lavoro è una delle sue più belle. Nonché una delle canzoni della mia vita.
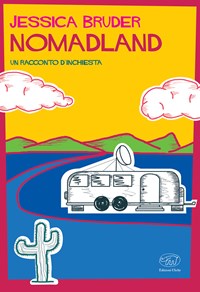 Nel 2017 la giornalista statunitense Jessica Bruder, dopo molto lavoro sul campo, racconta in Nomadland. Un racconto d’inchiesta (edizioni Clichy) la nuova epopea dei lavoratori e lavoratrici che hanno perso previdenza sociale e casa in seguito alla scellerata crisi del 2008\09 e sono costretti a errare per gli USA con i camper, cercando lavori stagionali e solidarietà tra di loro. Dal libro la regista di origine cinese Chloé Zhao ha tratto nel 2020 il film omonimo, prodotto tra l’altro dalla protagonista Frances McDormand.
Nel 2017 la giornalista statunitense Jessica Bruder, dopo molto lavoro sul campo, racconta in Nomadland. Un racconto d’inchiesta (edizioni Clichy) la nuova epopea dei lavoratori e lavoratrici che hanno perso previdenza sociale e casa in seguito alla scellerata crisi del 2008\09 e sono costretti a errare per gli USA con i camper, cercando lavori stagionali e solidarietà tra di loro. Dal libro la regista di origine cinese Chloé Zhao ha tratto nel 2020 il film omonimo, prodotto tra l’altro dalla protagonista Frances McDormand.
La mostra di Dorothea Lange, la memoria dei membri della Magnum, Furore, The ghost of Tom Joad, Nomadland rinnovano il mio istinto alla commozione, sicuramente con gli anni meno sotto controllo. Non ho ricette per la rianimazione della sinistra politica italiana. Mi permetto però di annotare che la memoria delle radici nobili di un pensiero a sostegno fattivo dei poveri, un umanesimo sociale che si ponga il problema del contrasto alla sofferenza generata dall’ingiustizia e un’empatia a cui continuamente educarsi, sono sicuramente passaggi adeguati, a riguardo. Quantomeno a tutelare la nostra dignità personale.
Andrea Bigalli, docente di Cinema e teologia all’Istituto superiore di scienze religiose della Toscana, referente di Libera per la Toscana
Pubblicato sabato 23 Settembre 2023
Stampato il 16/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/forme/una-macchina-fotografica-per-cambiare-la-realta/







