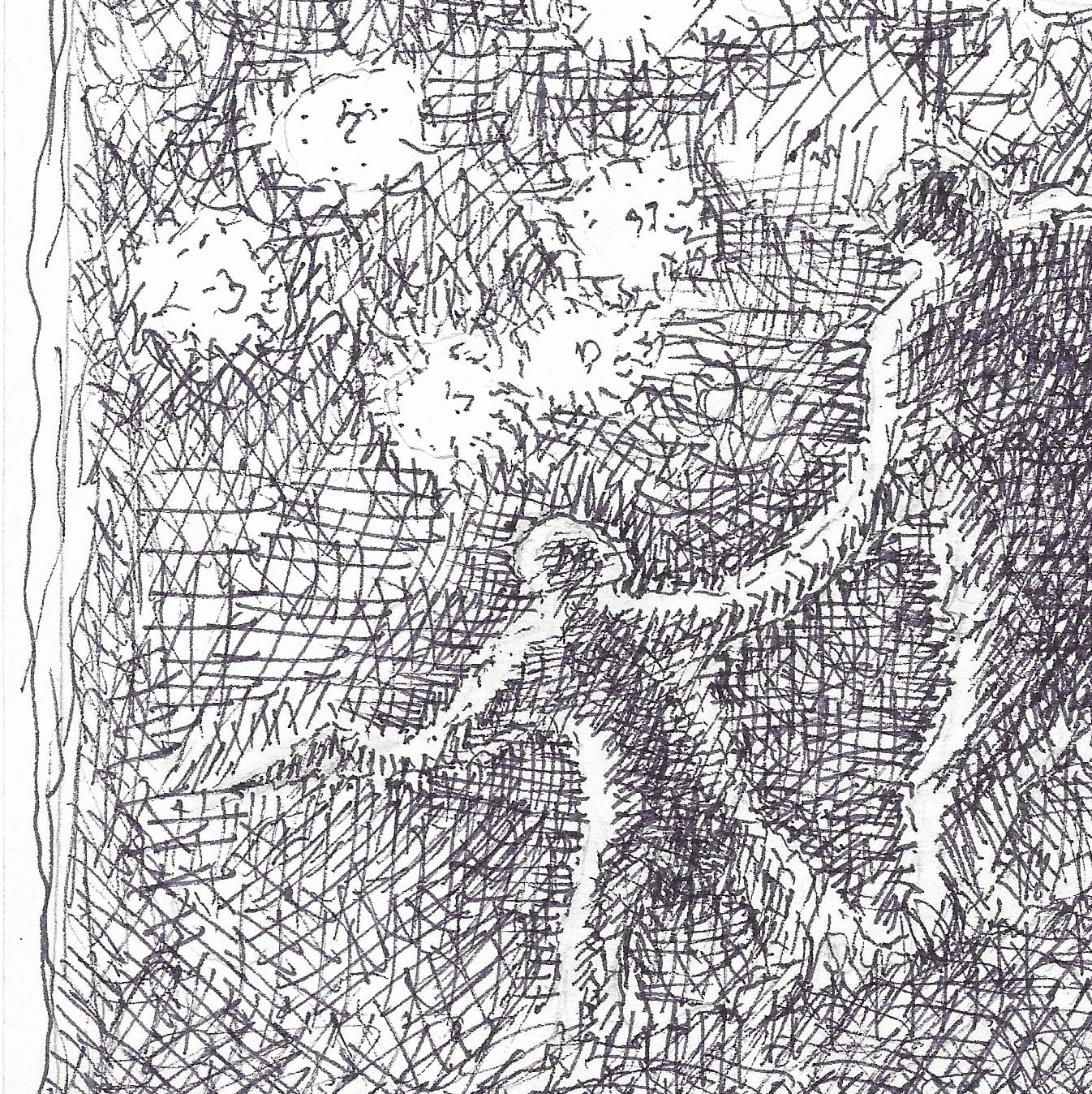Lo scrittore Giacomo Verri, collaboratore di questa testata, riprende il tema de “I paesaggi e i loro Partigiani” magistralmente sollevato dall’architetto Aimaro Isola con una speciale attenzione ed emozione per la montagna.
“L’eroe moderno è eroe perché, senza retoriche, ma con misura, quando è giusto, per un bene comune, si sporge offrendo sé come dono” scrive Aimaro Isola in un denso saggio apparso qualche settimana fa sulle colonne di questa stessa rivista, dedicato – attenzione – non ai partigiani e ai loro paesaggi quanto ai Paesaggi e ai loro partigiani. Quasi a dire che non sarebbero potuti esistere quegli eroi senza, prima, la presenza dei luoghi entro i cui confini si mossero.
È la montagna, in molti casi, ad aver fatto i partigiani. Certo, assieme alla coscienza politica – per molti, ma non per moltissimi – e al desiderio di svincolarsi, anche solo istintivamente, da ciò che Alberto Cavaglion chiama la “malizia” del regime, sotto cui visse almeno un’intera generazione, quella nata negli anni Venti del secolo scorso. Le formazioni partigiane trovarono, dunque, il naturale luogo di genesi sulle montagne (“Siamo i ribelli della montagna, viviam di stenti e di patimenti” recita il celebre canto) perché esse sono il rifugio, la protezione, sono il luogo che la retorica esageratamente urbana del regime aveva stolidamente tralasciato. Basti pensare che in molte comunità alpine il potere rimase saldamente in mano non ai rappresentati del partito fascista in quanto tali, ma in quanto membri delle famiglie e dei clan che da sempre avevano dominato la montagna. Questo significa che la montagna era luogo “altro” rispetto alla fascistizzazione degli spazi tentata in maniera intensa nei grandi centri, ma via via meno incisiva alla periferia dell’impero; eppure ciò non significa, di conseguenza, che la montagna fosse per certo il luogo d’elezione del dissenso. Questo no, perché isolamento e asprezza delle condizioni di vita avevano spesso irrigidito i montanari nella morsa del conservatorismo. Ma i partigiani, credo, videro nella montagna lo spazio di un’opportunità. Quella, prima di tutto, di nascondersi, di organizzarsi senza essere visti (facendo affidamento su alcuni elementi: la distanza dai centri di potere, l’impervietà dei luoghi, la fondata speranza che i fascisti non avessero le idee chiare sulla reale consistenza dei gruppi che si andavano formando), e poi sull’opportunità di prendere tempo per riscoprirsi uomini pensanti anziché obbedienti.

Così le montagne (o altrove le colline) attrassero i partigiani. Fu un richiamo quasi magico e ancestrale, checché ne abbiano detto alcuni teorici, eccessivamente imbibiti di ideologia, che sistemarono a posteriori i paletti della storia della Resistenza. E il legame divenne ben presto indissolubile. Perciò dice bene Isola sostenendo che l’eroe – in specie partigiano – si offre ai luoghi come dono. Perché i luoghi “alti”, a loro volta, regalarono all’eroe resistente l’aspra poesia di un paesaggio prima sublime (che attrae e atterrisce) e poi epico, in una sovrapposizione o, anche, in una irregolare interferenza che alterna la percezione di forti emozioni, la malinconia e, infine, la creazione di un vero e proprio microcosmo diverso dal mondo di fuori. Un paesaggio che diventa carne della Resistenza, un luogo che diventa spazio privilegiato per l’edificazione di una coscienza nuova. Una simbiosi tanto evidente in quanto non si può pensare a nessuna storia partigiana che non sia abbarbicata a un territorio ben definito.
Anni fa – era l’ultimo o il penultimo di liceo classico – partecipai al concorso che da tempo il Consiglio Regionale del Piemonte indice per gli studenti delle scuole superiori dedicato alla storia contemporanea (e sempre incentrato su temi legati al Secondo conflitto mondiale). Per quell’occasione, io e un compagno lavorammo sui cippi e sulle targhe commemorative dedicate ai partigiani caduti nel comune di Serravalle Sesia. Intervistammo Nadia Moscatelli, figlia del celebre comandante Cino. Venne lei da noi, sedette al tavolo di cucina del mio amico. E ci spiegò che la prima cosa che andava osservata nel nostro studio era la collocazione delle lapidi: mai – o quasi mai – inserite in spazi anonimamente pubblici ma nel luogo esatto in cui era avvenuta l’azione partigiana o dove l’eroe era caduto. Spesso, quindi, in montagna. Una montagna, come scrive Angelo Bendotti nel suo bellissimo Nel segno di Fenoglio – fatta di elementi burkianamente sublimi (che nutrono perciò l’idea di pericolo e di dolore), il freddo, il gelo, la neve, il ghiaccio, ma che a un tempo si voltano in “ultima ‘difesa’ per il partigiano, creando una sorta di luogo protetto dove i nemici faticano ad avventurarsi”.
 L’algida, olimpica, terribile montagna diventa dunque il simbolo della libertà. O meglio: della faticosa ascesa verso la libertà; faticosa perché che sta in alto; perché in basso c’è l’oppressione dei fascisti; perché in alto ci si sente più grandi, forse più forti – forti di quella forza conquistata col sacrifico; perché in alto l’aria è più pulita; perché tra i boschi, nella natura, il partigiano è colto da un senso panico, si immedesima e si confonde con quanto lo circonda, trovando così il destro per diventare invisibile agli occhi del nemico.
L’algida, olimpica, terribile montagna diventa dunque il simbolo della libertà. O meglio: della faticosa ascesa verso la libertà; faticosa perché che sta in alto; perché in basso c’è l’oppressione dei fascisti; perché in alto ci si sente più grandi, forse più forti – forti di quella forza conquistata col sacrifico; perché in alto l’aria è più pulita; perché tra i boschi, nella natura, il partigiano è colto da un senso panico, si immedesima e si confonde con quanto lo circonda, trovando così il destro per diventare invisibile agli occhi del nemico.
Non solo: quello partigiano è il paesaggio della coscienza, della presa di coscienza, in contrapposizione al paesaggio organizzato (ovvero imposto) dal regime, quello dei grandi viali, delle fastose architetture, delle piazze destinate alle adunanze, prefigurazione di non luoghi nei quali venne abrogata la storia – magari anche dimessa, ma autentica – del passato, per far luogo a una risemantizzazione che brucia secoli di vita umana in nome di un anacronistico ritorno alla grandezza di Roma imperiale. Un paesaggio, ancora, che faceva sentire nei suoi cementi la coercizione di chi inculca assieme alla percezione di legittimità dell’autorità anche l’adesione a quello stesso sistema di autorità. Un paesaggio, insomma, capace di subordinare l’individuo e, a un tempo, di deresponsabilizzarlo poiché il soggetto è posto forzatamente dentro a uno spazio fisico e ideologico eteronomico.
Quello fascista fu allora – per certi versi – un paesaggio ridicolmente e tragicamente pomposo che distrusse, a volte, il profilo dei vecchi paesi (il centro storico della mia Borgosesia fu proprio a cavallo tra gli anni Venti e Trenta letteralmente sventrato per consentire la creazione di un’enorme piazza). E assieme a quel profilo, venne lesa anche forse un’idea di democrazia nascente (quella di fine Ottocento, di inizio Novecento), sobria, ma tutto sommato onesta, quella che mi piace credere intravedesse, qualche decennio più tardi, anche l’umile Amerigo Ormea, l’eroe di Italo Calvino nella Giornata di uno scrutatore, tra le mura scalcinate del Cottolengo, durante le elezioni: “La democrazia si presentava ai cittadini sotto queste spoglie dimesse, grigie, disadorne; ad Amerigo a tratti ciò pareva sublime, nell’Italia da sempre ossequiente a ciò che è pompa, fasto, esteriorità, ornamento; gli pareva finalmente la lezione d’una morale onesta e austera; e una perpetua silenziosa rivincita sui fascisti, su coloro che la democrazia avevano creduto di poter disprezzare proprio per questo suo squallore esteriore, per questa sua umile contabilità, ed erano caduti in polvere con tutte le loro frange e i loro fiocchi”.
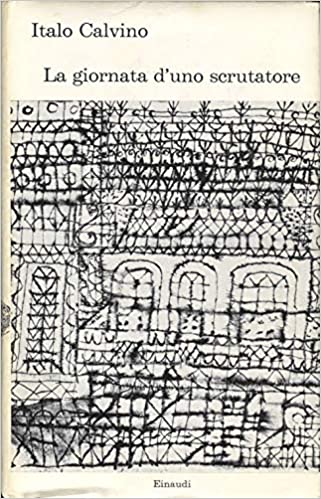 Il paesaggio partigiano è, al contrario, quello della costruzione di un’identità personale, soggettiva, nata dal di dentro e non imposta da fuori: spazio vissuto, in prima battuta, in solitaria e solo dopo comunitariamente condiviso con gli altri. O meglio, esso entrava dentro a ogni partigiano in maniera originale, esclusiva, diversa, relativa. Anche il paesaggio fu dunque la “questione privata” di ogni combattente della montagna.
Il paesaggio partigiano è, al contrario, quello della costruzione di un’identità personale, soggettiva, nata dal di dentro e non imposta da fuori: spazio vissuto, in prima battuta, in solitaria e solo dopo comunitariamente condiviso con gli altri. O meglio, esso entrava dentro a ogni partigiano in maniera originale, esclusiva, diversa, relativa. Anche il paesaggio fu dunque la “questione privata” di ogni combattente della montagna.
Condizione peculiare del partigiano – lo si ritrova praticamente in ogni scritto, nei diari, nei racconti, nei romanzi – è la solitudine di fronte al paesaggio, vero maestro di vita, autentico educatore del bene e del male. Anche di quest’ultimo, sì, della fatica, del dolore, della sofferenza. Fu il carattere aspro dei monti a insegnare la natura del Male ai partigiani, in maniera più efficace di come avesse potuto fare il fascismo stesso. E così il paesaggio riuscì, ovviamente, anche nell’educazione sentimentale dell’opposto, ovvero del Bene.
Qualche anno fa scrivendo un’Intervista impossibile a Beppe Fenoglio, io e quel fantasma ragionavamo appunto intorno a questa faccenda:
“Intervistatore: Il fascismo fu dunque una sorta di Moby Dick, un condensato del male che scatenò, per antitesi, la Resistenza…
Fenoglio: No, faccia attenzione. In primo luogo Moby Dick è il simbolo del male tutto, preso nella sua vastità e profondità oceanica; è il male nobile, grande, eterno, sublime… il fascismo non fu che una povera cosa, come le ho detto, la pelle lubrica di un corpo malato. E poi la Resistenza: essa fu un fulgido e ammirevole stato di grazia collettivo. Ma fu il singolo uomo, Johnny o un altro, il nome poco importa, fu il singolo uomo che dovette combattere, periclitare, patire, sputare, per raggiungere la statura morale che lo avrebbe fatto sentire grande, un grande uomo.
Intervistatore: Purezza sentimentale, grandezza della storia!
Fenoglio: Sì, la purezza, il raffinamento dello spirito. È qualcosa che si ottiene nella solitudine. Nella solitudine d’una stanza, come nella solitudine d’una somma collina. Nella sconfinata, assoluta, profonda, alta, stregata, incubosa, vespertina, invernale, vacua solitudine che s’aderge superba, che separa una morte dall’altra. Amavo e tuttora amo fumare in solitudine e absent-mindedness, quasi cercando un esercizio di souplesse. Nobile souplesse. Il mio esercizio spirituale mirava alla grandiosità, all’impressionante umanità dell’agire. Volevo che tutto fosse in me nobilmente umano”.
Non fa dunque meraviglia leggere questo elenco di aggettivi per indicare la solitudine (vengono tutti dal Partigiano Johnny), perché è di lì, dal contatto visivo e poi spirituale col paesaggio, che il singolo uomo divenne combattente per la libertà.
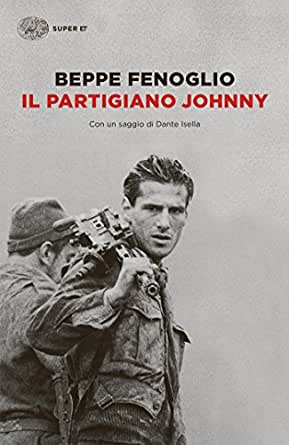 Così il paesaggio partigiano è quello della montagna su cui “fischia il vento e infuria la bufera” e in cui la rabbia degli elementi, pazientemente addomesticata, si fa dono, davvero, a chi resiste a tutto per un mondo nuovo. Il paesaggio parla ai partigiani, offre loro segni complessi, multiformi, lontani dal discorso univoco della dittatura. Accanto all’ostilità raccontata, ad esempio, dai rigori del freddo e che fa “scaturire la volontà di reagire” (come scrive Veronica Pesce a proposito dei paesaggi fenogliani) c’è la promessa di un futuro diverso (perennemente esemplato da elementi paesaggistici), tanto splendido perché fuori dal tempo, totale, organico, assoluto, un tutto a cui nulla va aggiunto, non in quanto imposto dall’alto, ma poiché sbocciato dall’interno come un orizzonte morale. E non c’è forse bisogno di dire che ne è massimo corollario, ancora, la titanica immagine di Johnny che “partì verso le somme colline, la terra ancestrale che l’avrebbe aiutato nel suo immoto possibile, nel vortice del vento nero, sentendo com’è grande un uomo quando è nella sua normale dimensione umana”.
Così il paesaggio partigiano è quello della montagna su cui “fischia il vento e infuria la bufera” e in cui la rabbia degli elementi, pazientemente addomesticata, si fa dono, davvero, a chi resiste a tutto per un mondo nuovo. Il paesaggio parla ai partigiani, offre loro segni complessi, multiformi, lontani dal discorso univoco della dittatura. Accanto all’ostilità raccontata, ad esempio, dai rigori del freddo e che fa “scaturire la volontà di reagire” (come scrive Veronica Pesce a proposito dei paesaggi fenogliani) c’è la promessa di un futuro diverso (perennemente esemplato da elementi paesaggistici), tanto splendido perché fuori dal tempo, totale, organico, assoluto, un tutto a cui nulla va aggiunto, non in quanto imposto dall’alto, ma poiché sbocciato dall’interno come un orizzonte morale. E non c’è forse bisogno di dire che ne è massimo corollario, ancora, la titanica immagine di Johnny che “partì verso le somme colline, la terra ancestrale che l’avrebbe aiutato nel suo immoto possibile, nel vortice del vento nero, sentendo com’è grande un uomo quando è nella sua normale dimensione umana”.
E questa coscienza del paesaggio, a cavallo tra sublime ed epica, non solo fu la matrice che ispirò gli afflati di chi visse quei giorni ma deve, a mio parere, essere la chiave, oggi ancora, per chi ha desiderio di penetrare la memoria partigiana. Tema sul quale ho impostato gran parte della mia riflessione, divenuta romanzo, e mosso i primi passi verso una rieducazione, personale, di come va riascoltato il passato. In chiosa al mio primo libro, Partigiano Inverno, cercavo di fare i conti con gli scrittori che mi avevano preceduto, con il canone della letteratura resistenziale e con i guasti causati da quella che Antonio Scurati chiama la malattia dell’inesperienza. Mi chiedevo cioè come potessi raccontare – io, nato nel 1978 – avvenimenti tanto separati dalla mia pratica quotidiana. Sarebbe stato come cercare di dire quale dolore si prova a prendere una martellata su un dito senza mai averla davvero sperimentata. E però una strada la volevo trovare. Così scrivevo, strizzando un po’ l’occhio al Calvino dell’Introduzione alla seconda edizione del Sentiero dei nidi di ragno:
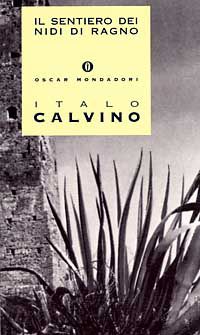 “Ma in che maniera parlarne, oggi? Un racconto sincero e spassionato non potevo farlo: primo per la malattia dell’inesperienza, secondo perché, anche a far vista di avercela (l’esperienza), non potevo fingere di ignorare chi in base all’esperienza aveva scritto. Perciò, accettata serenamente la perdita di contatto col mondo di ieri, mi sembrò sensato far affiorare l’idea che l’uomo di oggi può paragonarsi a quello passato solo se posto di fronte alle cose della natura (e non della storia), che sono uguali da migliaia di anni: per questo è importante l’insistenza sugli elementi naturali, sui rami secchi, sull’inverno, sui movimenti del sole, sulla lusinga della ciclicità delle stagioni, su ciò che è a-storico, eterno, ancestrale. A fare le azioni importanti non sono i protagonisti del romanzo (Umberto, Jacopo e Italo) ma Cino Moscatelli, Giuseppe Osella e gli altri che ci furono davvero; i miei personaggi per la maggior parte del tempo si limitano a passeggiare, a guardare in aria, a pensare, a rievocare proustianamente in un’atmosfera sospesa; attendono qualcosa, o cercano l’Occasione della vita; progrediscono ma non secondo un movimento lineare: non vanno da un punto all’altro ma muovono disordinati, senza meta, per brevi scarti. Sono soli e perduti, come noi di fronte al passato. Rincorrono qualcosa avanti a loro ma non sanno cosa: la linearità s’inchiocciola e diventa circolare. L’insufficiente diventa evento, o lo diventa ciò che è grottescamente abbondante, ovvero l’eccedenza deforme”.
“Ma in che maniera parlarne, oggi? Un racconto sincero e spassionato non potevo farlo: primo per la malattia dell’inesperienza, secondo perché, anche a far vista di avercela (l’esperienza), non potevo fingere di ignorare chi in base all’esperienza aveva scritto. Perciò, accettata serenamente la perdita di contatto col mondo di ieri, mi sembrò sensato far affiorare l’idea che l’uomo di oggi può paragonarsi a quello passato solo se posto di fronte alle cose della natura (e non della storia), che sono uguali da migliaia di anni: per questo è importante l’insistenza sugli elementi naturali, sui rami secchi, sull’inverno, sui movimenti del sole, sulla lusinga della ciclicità delle stagioni, su ciò che è a-storico, eterno, ancestrale. A fare le azioni importanti non sono i protagonisti del romanzo (Umberto, Jacopo e Italo) ma Cino Moscatelli, Giuseppe Osella e gli altri che ci furono davvero; i miei personaggi per la maggior parte del tempo si limitano a passeggiare, a guardare in aria, a pensare, a rievocare proustianamente in un’atmosfera sospesa; attendono qualcosa, o cercano l’Occasione della vita; progrediscono ma non secondo un movimento lineare: non vanno da un punto all’altro ma muovono disordinati, senza meta, per brevi scarti. Sono soli e perduti, come noi di fronte al passato. Rincorrono qualcosa avanti a loro ma non sanno cosa: la linearità s’inchiocciola e diventa circolare. L’insufficiente diventa evento, o lo diventa ciò che è grottescamente abbondante, ovvero l’eccedenza deforme”.
In altre parole, per far fronte alla nostra sperduta solitudine dinnanzi al passato, non c’è miglior (altra?) strada da percorrere che quella delle “cose” della natura, delle “cose” della montagna (o “delle somme colline” – vette anch’esse –, per tornare a Fenoglio), dei paesaggi, delle stagioni, delle piogge, dei tormenti del freddo, della splendida luna che si vede solo lassù, e che sono diventate per i miei personaggi la linea di congiunzione tra presente e passato (tra autore “mal pratico” e materia narrata), ma anche per me stesso – e non solo per i partigiani – il veicolo attraverso cui resistere all’oblio, e risollevare, mi pare con una certa efficacia, i veli di un’incolpevole ma pericolosa inesperienza.
Giacomo Verri, scrittore
Pubblicato martedì 26 Maggio 2020
Stampato il 30/06/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/il-paesaggio-partigiano-per-la-memoria/