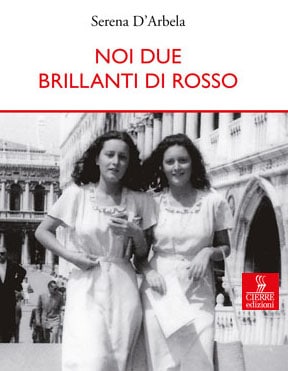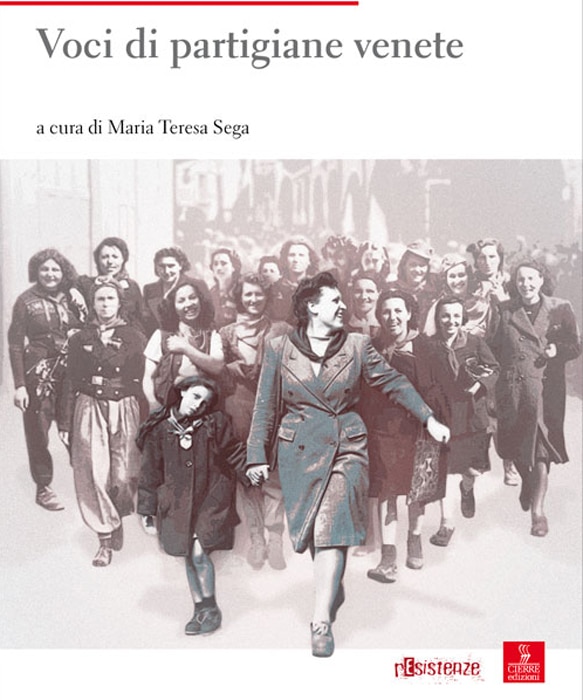“Non potete dire che la cosa non vi riguarda. Perché la cosa vi riguarda eccome”. Sono parole che ricordano quelle di Fabrizio De Andrè nella sua celebre canzone sul maggio del ‘68 francese (“anche se vi credete assolti siete lo stesso coinvolti”) e invece sono quelle scritte nel marzo 1944 da Albert Camus come redattore della rivista clandestina Combat, organo dell’omonimo movimento della Resistenza francese, in occasione dell’ennesimo eccidio di partigiani. Nei suoi appelli contro la passività, l’opportunismo e la rassegnazione c’è molto del clima descritto ne “La Peste”. Il protagonista, il Dottor Rieux (chiaramente un alter-ego dello stesso Camus), insieme ad un ristretto gruppo di suoi collaboratori, senza il conforto di una fede ultraterrena o la certezza in un futuro migliore, decide di restare al suo posto. Senza proclami e pose da eroe, Rieux decide infatti di fare in fondo il suo dovere di medico di fronte all’epidemia che colpisce la sonnacchiosa città di Orano nella costa algerina.
Tra il 1943 e il 1944 proprio gli articoli per Combat si alternano alla redazione del romanzo, uscito nel ‘47 ma la cui lunga gestazione redazionale era cominciata alla fine del ‘41 in una fase in cui le sorti del conflitto sembravano volgere a favore delle forze dell’Asse. Potente allegoria del nazismo e della guerra mondiale (oltre che più generalmente del “male” individuale e collettivo) il romanzo consacrò Camus come uno dei massimi scrittori del suo tempo, segnalandolo anche al pubblico internazionale ed è sicuramente tra i testi che lo spingeranno verso la conquista del Premio Nobel per la letteratura nel 1957.
Sia gli articoli sia il romanzo, come giustamente aveva rilevato su Patria Wladimiro Settimelli , sono sempre sorretti e animati da uno stile che mescola ironia e serietà, razionalità e commozione, con un costante appello all’“onore” individuale e nazionale, inteso prima di tutto come consapevolezza della propria dignità e del proprio ruolo sociale come intellettuale. E su questo aspetto della responsabilità personale, della scelta morale ancora prima che politica, Camus insisterà frequentemente evidenziando come proprio nella tragedia della guerra fosse data la possibilità del riscatto: “Anche se molti scrittori non hanno fatto molto per la Resistenza, noi diremo, al contrario, che la Resistenza ha fatto molto per loro: ha loro insegnato le prix des mots. Rischiare la propria vita, per poco che possa valere, per fare stampare un articolo, una poesia, un dialogo, questo significa apprendere il vero prezzo delle parole. (…) Ciò è vero al punto che solo quelli che non hanno rischiato nulla hanno abusato della parola”.
 L’influsso di questo tipo di cultura militante negli ambienti intellettuali europei del secondo dopoguerra in Europa sarà assai significativo, intrecciandosi in Francia e in Italia con l’accentuazione del tema dell’“impegno” . Non è un caso che Norberto Bobbio, a dieci anni dalla Liberazione, abbia citato proprio Camus per ricordare come “(…) troppo spesso gli uomini di cultura sono rimasti fuori del circo come se lo spettacolo non li riguardasse. Qualche volta sono entrati, ma si sono seduti sulla gradinata a far da spettatori. E se qualche segno di partecipazione hanno dato, è stato quasi sempre per far l’elogio del leone che ha sempre ragione; e se qualche parola hanno rivolto alla vittima è per spiegarle che il suo destino era quello di farsi mangiare. Oggi non più. Oggi, dice Camus, gli uomini di cultura devono rendersi conto che il loro posto non è più sulla gradinata ma dentro l’arena. Essi sanno che se la vittima soccombe anch’essi saranno divorati. Sono, come si ripete oggi, impegnati. Impegnati a far sì che nel futuro vi siano meno vittime e meno leoni”.
L’influsso di questo tipo di cultura militante negli ambienti intellettuali europei del secondo dopoguerra in Europa sarà assai significativo, intrecciandosi in Francia e in Italia con l’accentuazione del tema dell’“impegno” . Non è un caso che Norberto Bobbio, a dieci anni dalla Liberazione, abbia citato proprio Camus per ricordare come “(…) troppo spesso gli uomini di cultura sono rimasti fuori del circo come se lo spettacolo non li riguardasse. Qualche volta sono entrati, ma si sono seduti sulla gradinata a far da spettatori. E se qualche segno di partecipazione hanno dato, è stato quasi sempre per far l’elogio del leone che ha sempre ragione; e se qualche parola hanno rivolto alla vittima è per spiegarle che il suo destino era quello di farsi mangiare. Oggi non più. Oggi, dice Camus, gli uomini di cultura devono rendersi conto che il loro posto non è più sulla gradinata ma dentro l’arena. Essi sanno che se la vittima soccombe anch’essi saranno divorati. Sono, come si ripete oggi, impegnati. Impegnati a far sì che nel futuro vi siano meno vittime e meno leoni”.
Lo stato d’animo di rivolta e di collera di fronte all’ingiustizia e alla violenza perpetrati dagli occupanti nazisti e dai collaborazionisti francesi era stata la molla che aveva spinto Camus ad impegnarsi direttamente nella rete clandestina di Combat, mettendo a frutto le competenze già maturate come redattore di Algerie repubblicain alla fine degli anni Trenta del Novecento. Rivolta e collera che però in lui convissero sempre con l’attenzione e l’approfondimento delle ragioni morali, del significato da dare alla partecipazione alla attività clandestina e alla lotta a morte contro il nazifascismo. Temi che espresse magistralmente ne Les Lettres à un ami allemand uscite nel corso della seconda metà del 1943 per Gallimard, lo stesso editore che l’anno prima aveva stampato Lo straniero e Il mito di Sisifo, due pietre miliari della sua produzione narrativa e filosofica: “Non è cosa da poco battersi disprezzando la guerra [aveva perso il padre nella battaglia della Marna], accettare di perdere tutto mantenendo il gusto della felicità, correre verso la distruzione con in mente una cultura superiore […] abbiamo dovuto sconfiggere il nostro gusto dell’uomo, l’immagine che ci facevamo di un destino pacifico, la nostra profonda convinzione che nessuna guerra sia pagante, là dove ogni mutilazione dell’uomo è irreparabile[…] noi lottiamo per quella sfumatura che separa il sacrificio dalla mistica, l’energia dalla violenza, la forza dalla crudeltà, per quella sfumatura ancora più lieve che separa il falso dal vero, e l’uomo nel quale noi confidiamo dagli stanchi dei che voi adorate”.
 “Un eroe del nostro tempo”, cioè del XXI secolo, cosi il grande storico inglese Tony Judt definiva Albert Camus nel 2001, nella prefazione ad una edizione inglese de La Peste, redatta a pochi mesi dall’attentato alle TwinTowers. Forse una definizione del genere non sarebbe istintivamente piaciuta allo scrittore franco-algerino, così schivo e lontano da ogni spirito celebrativo. Judt però coglieva sicuramente nel segno quando, proprio parlando del Dottor Rieux e dei suoi compagni, notava che sono “persone ordinarie che fanno cose straordinarie per semplice decenza”: una sobria e penetrante definizione che rimanda al nocciolo duro, al “fresco significato” (ancora Judt) che può assumere oggi il capolavoro di Camus contro i relativismi e lo stanco disincanto contemporaneo. Non è un caso che quando si trova costretto a dover giustificare il proprio comportamento Rieux non trova che la parola “decenza” a descriverlo. “Decenza” intesa come consapevolezza che il proprio stare al mondo, senza negarsi momenti di felicità, implica prendere posizione, condividere la sorte dei propri simili e attivarsi contro i “flagelli” naturali e politici. Ma il tema della scelta morale intransigente, della lotta cruenta in Camus non prescinde mai anzi è strettamente legato ad un sentimento di compassione in senso forte per la condizione umana, al suo carattere vulnerabile di fronte alla malattia fisica e morale, alle debolezze e ai compromessi a cui è costantemente sottoposta.
“Un eroe del nostro tempo”, cioè del XXI secolo, cosi il grande storico inglese Tony Judt definiva Albert Camus nel 2001, nella prefazione ad una edizione inglese de La Peste, redatta a pochi mesi dall’attentato alle TwinTowers. Forse una definizione del genere non sarebbe istintivamente piaciuta allo scrittore franco-algerino, così schivo e lontano da ogni spirito celebrativo. Judt però coglieva sicuramente nel segno quando, proprio parlando del Dottor Rieux e dei suoi compagni, notava che sono “persone ordinarie che fanno cose straordinarie per semplice decenza”: una sobria e penetrante definizione che rimanda al nocciolo duro, al “fresco significato” (ancora Judt) che può assumere oggi il capolavoro di Camus contro i relativismi e lo stanco disincanto contemporaneo. Non è un caso che quando si trova costretto a dover giustificare il proprio comportamento Rieux non trova che la parola “decenza” a descriverlo. “Decenza” intesa come consapevolezza che il proprio stare al mondo, senza negarsi momenti di felicità, implica prendere posizione, condividere la sorte dei propri simili e attivarsi contro i “flagelli” naturali e politici. Ma il tema della scelta morale intransigente, della lotta cruenta in Camus non prescinde mai anzi è strettamente legato ad un sentimento di compassione in senso forte per la condizione umana, al suo carattere vulnerabile di fronte alla malattia fisica e morale, alle debolezze e ai compromessi a cui è costantemente sottoposta.
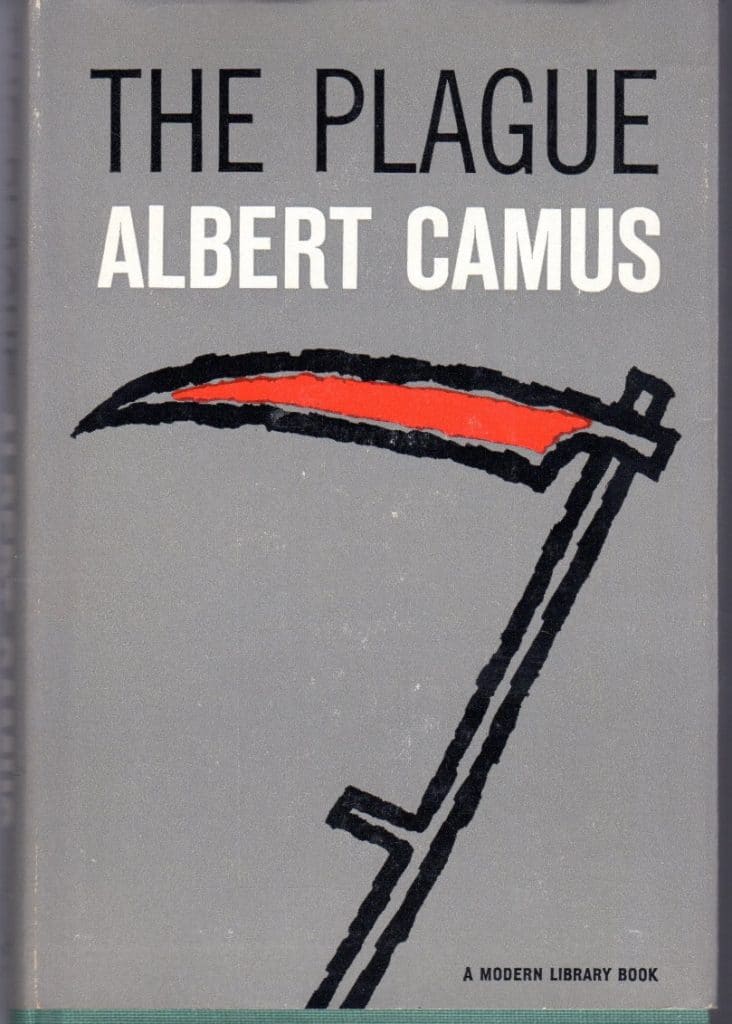 Su questo atteggiamento influivano forse almeno in parte anche le sue assai modeste origini sociali (al contrario di altri esponenti dell’intellighenzia di sinistra francese come Sartre): Camus era infatti cresciuto nel quartiere povero di Belcourt ad Algeri e aveva conosciuto in prima persona la vita delle classi popolari. Anche il precario stato di salute e la tubercolosi che lo accompagnerà tutta la vita (interrotta prematuramente in un incidente stradale nel 1960) lo renderà particolarmente attento e partecipe alle debolezze umane fisiche e morali.
Su questo atteggiamento influivano forse almeno in parte anche le sue assai modeste origini sociali (al contrario di altri esponenti dell’intellighenzia di sinistra francese come Sartre): Camus era infatti cresciuto nel quartiere povero di Belcourt ad Algeri e aveva conosciuto in prima persona la vita delle classi popolari. Anche il precario stato di salute e la tubercolosi che lo accompagnerà tutta la vita (interrotta prematuramente in un incidente stradale nel 1960) lo renderà particolarmente attento e partecipe alle debolezze umane fisiche e morali.
Alla fine il nucleo fondamentale, quello che resta a distanza di 70 anni e oltre le stagioni politiche, è proprio l’appello alla coscienza individuale e insieme alla responsabilità sociale senza proclami condividendo fino in fondo valori tanto più sostanziali e profondi quanto più si riferiscono all’essere umano come “l’altro”, come “il prossimo”: sollecitato da una situazione esterna avversa, l’uomo scopre di essere accomunato agli altri uomini dall’esistenza di sentimenti e aspirazioni simili, a cominciare dal desiderio di reagire alla disperazione e alla morte.
Come aveva già notato acutamente Tony Judt, il richiamo aspro e commosso a un impegno che non deve mai venire meno contro la “peste” nazifascista trova nel memorabile finale del romanzo uno dei momenti più alti e solenni e non smette di mandare un messaggio che proprio oggi non può lasciarci indifferenti: “Fra le grida sempre più forti e sempre più estese […] Rieux si decise a redigere il resoconto che qui si conclude, per non essere tra coloro che tacciono, per testimoniare a favore degli appestati, per lasciare almeno un ricordo dell’ingiustizia e delle violenze che erano state fatte loro, e per dire semplicemente quel che si impara durante i flagelli, che ci sono negli uomini più cose da ammirare che da disprezzare. Ma sapeva tuttavia che questa non poteva essere la cronaca di una vittoria definitiva. Poteva soltanto essere la testimonianza di quel che si era dovuto fare, e che contro il terrore e la sua arma instancabile forse avrebbero ancora dovuto fare nonostante le lacerazioni personali, tutti gli uomini che, non potendo essere dei santi e rifiutando di accettare i flagelli, si sforzano tuttavia di essere dei medici. Ascoltando infatti le grida di esultanza che si levavano dalla città, Rieux si ricordava che quell’esultanza era sempre minacciata. Poiché sapeva quel che la folla ignorava, e che si può leggere nei libri, cioè che il bacillo della peste non muore né scompare mai, che può restare per decenni addormentato nei mobili e nella biancheria, che aspetta pazientemente nelle camere da letto, nelle cantine, nelle valigie, nei fazzoletti e nelle carte e che forse sarebbe venuto il giorno in cui, sventura o insegnamento agli uomini, la peste avrebbe svegliato i suoi topi per mandarli a morire in una città felice”.
Paolo Mencarelli, dell’Istituto storico della Resistenza in Toscana
Bibliografia, i testi citati
- Camus, Questa lotta vi riguarda. Corrispondenze per Combat 1944-47, a cura di J.Lévi-Valensi, Bompiani, 2010
- Settimelli, Il partigiano Camus fa ancora paura alla destra francese, Patria indipendente, luglio 2013
- Judt Prefazione, a A. Camus The Plague, www.theguardian.com/books/2001/nov/17/albertcamus, The Guardian, 17 nov. 2001
- Camus, La peste, Bompiani, 2017
- Bobbio, Ecco perche la resistenza non finisce mai [1955] (ripubblicato su La Stampa 23 Aprile 2015 http://www.libertaegiustizia.it/2015/04/23/ecco-perche-la-resistenza-non-finisce-mai/
Pubblicato venerdì 7 Dicembre 2018
Stampato il 04/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/il-prezzo-delle-parole-e-la-decenza-albert-camus/