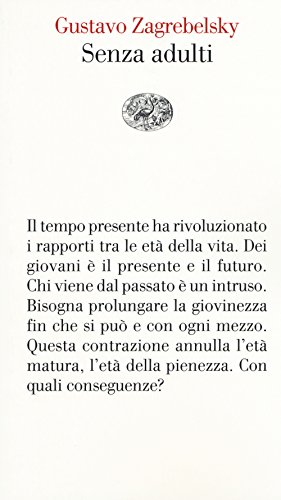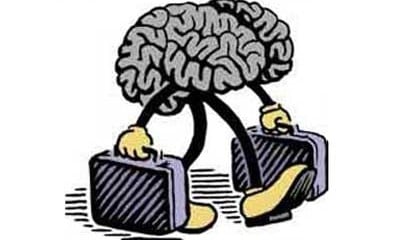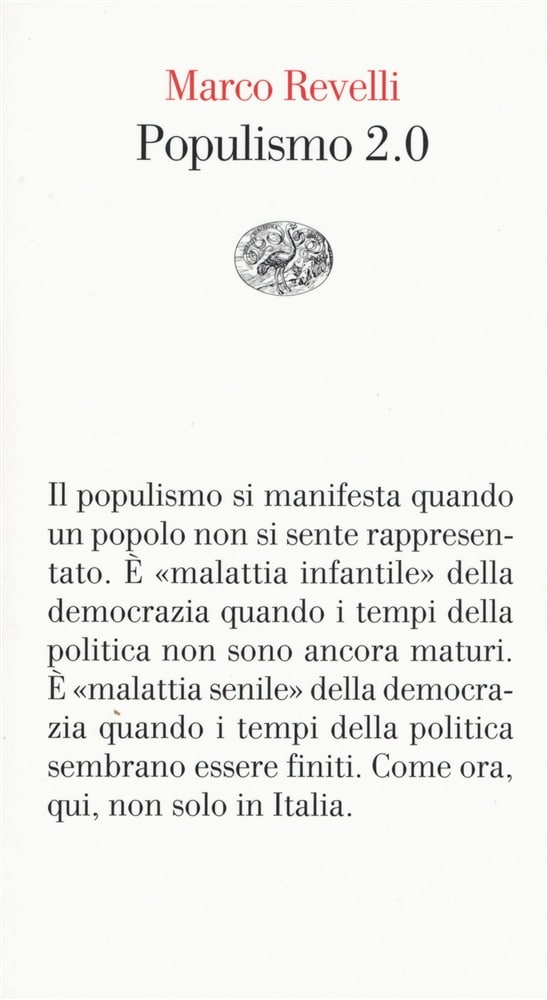 Al termine della lettura del volumetto di Marco Revelli si ha l’impressione, per così dire, di aver trovato – finalmente – un possibile filo conduttore nella torbida, convulsa e velenosa melassa in cui si contrappongono il cosiddetto populismo da un lato e le oligarchie dall’altro, spesso con un singolare scambio dei ruoli e mai mettendo in discussione le strutture portanti del sistema economico-finanziario che regna nel presente eterno e privo di orizzonte in cui ci è dato di vivere al nostro tempo.
Al termine della lettura del volumetto di Marco Revelli si ha l’impressione, per così dire, di aver trovato – finalmente – un possibile filo conduttore nella torbida, convulsa e velenosa melassa in cui si contrappongono il cosiddetto populismo da un lato e le oligarchie dall’altro, spesso con un singolare scambio dei ruoli e mai mettendo in discussione le strutture portanti del sistema economico-finanziario che regna nel presente eterno e privo di orizzonte in cui ci è dato di vivere al nostro tempo.
È la melassa in cui da anni sta sprofondando il nostro Paese e gran parte di quella zona del mondo convenzionalmente chiamata occidente. Il tema del populismo, di cui tante volte si parla – a proposito e, spesso, a sproposito – viene declinato in chiave storica, geografica e sociale, per approdare infine ai lidi peninsulari.
In sintesi: l’Autore riflette sul significato attuale del termine, lo connette ad altri termini-chiave (democrazia, antipolitica), lo “legge” nelle recenti vicende nazionali. Indaga sulle origini del populismo post-novecentesco approfondendo la vicenda americana dal tempo della candidatura di James Weaver alle presidenziali del 1892, fino allo shock dell’elezione di Donald Trump. Poi affronta la questione della Brexit – il “terremoto inglese” – e successivamente i casi UE: Francia, Germania, “gruppo di Visegrád” (Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia). Infine torna nel “bel Paese” analizzando quelli che, a suo avviso, sono i “tre populismi” italiani – “telepopulismo”, “cyberpopulismo”, “populismo dall’alto”: «tre fenomeni fra loro diversi per tempi di “emersione” e di “egemonia”, oltre che per cultura politica (…), ma accomunati da alcuni tratti non solo formali».

L’ultimo capitolo ha nel titolo la sua anima: “L’età del vuoto”, così da un lato scatenando uno spiegabile horror vacui, e dall’altro suscitando – sia pur alla lontana, come una fuggevole percezione della vista – una sommessa sensazione di transitorietà; perché, se è vero che «non si trova nessun protagonista politico, nessun candidato alla rappresentanza di questi “perdenti della new economy”, in grado di proporsi come strumento di una battaglia egualitaria», se è vero che «accade allora che l’esercito dei perdenti si affidi a un vincente, quello che trovano, purché capace di dar voce alla loro rabbia e offrire un’immagine di diversità», come Trump, Johnson o Teresa May, è anche vero che «basterebbero forse dei segnali chiari (…) per disinnescare almeno in parte quelle mine vaganti nella post-democrazia incombente (…). Quello che un tempo si chiamava “riformismo” e che oggi appare “rivoluzionario”». Ma c’è un ostacolo, ammonisce Revelli, perché «si sa, Dio acceca coloro che vuol perdere».
Perché post-democrazia? Il nesso fra il populismo, la democrazia e la sua crisi è ricorrente: una crisi «grave al punto che già da un po’ si è cominciato a parlare di “post-democrazia” (ndr: post-democracy, neologismo inglese coniato dal politologo britannico Colin Crouch; è il titolo di un suo volume, edito in Italia da Laterza), alludendo a una sorta di carattere terminale della patologia in atto: alla sempre più marcata torsione oligarchica che la forma democratica va subendo, diventando sempre meno rappresentativa e sempre più “esecutoria”. E nella sottostante crisi sociale, vero e proprio ipocentro – punto di rottura profondo – del terremoto che sta facendo tremare il nostro ordine politico: nel modo con cui è venuta, velocemente, ridisegnando l’assetto delle classi e dei gruppi sociali, con il diffuso declassamento del ceto medio. Con lo sfarinamento del cosiddetto “mondo del lavoro”».

La lettura che Revelli dà del fenomeno populista è intrinsecamente legata a questa dinamica sociale che punteggia, sia pure in modo difforme da Paese a Paese, la carta geografica degli States e del Vecchio continente. La precipitazione del ceto medio, la rarefazione delle “tute blu”, la crescita esponenziale delle povertà e l’aumento in progressione geometrica delle diseguaglianze hanno creato una miscela esplosiva che ha determinato un repentino cambio della guardia nell’establishment dal Mississippi al Tamigi, e pone problemi inediti e colossali all’UE.
Qual è lo scenario in cui avviene questa mutazione? «La dissoluzione di quegli antichi contenitori (i partiti di massa novecenteschi, i canali della partecipazione politica tradizionale, le forme di aggregazione tardo-industriali). La trasformazione “antropologica” delle masse, nella transizione oramai compiuta da produttori-consumatori a consumatori tout court (…). Ma anche la mutazione culturale delle élites politiche». In questo scenario, date le condizioni economico-sociali, si sprigiona il populismo, che «non è un nuovo (e forse anche vecchio) “soggetto politico” proprio (…). È un’entità molto più impalpabile e meno identificabile entro specifici confini e involucri. È uno stato d’animo, un mood, la forma informe che assumono il disagio e i conati di protesta nelle società sfarinate e lavorate dalla globalizzazione e dalla finanza totale».

Tale “stato d’animo” è eterogeneo e variegato nelle sue manifestazioni e nei profili che assume. Cionondimeno contiene dei fattori comuni. Il primo: «la centralità assorbente (…) che assume il riferimento al popolo, inteso nella sua dimensione “calda” di comunità vivente, quasi una sorta di entità pre-politica e pre-civile, da “stato di natura” russoviano».
Non c’è più dunque «la tradizionale dialettica “orizzontale” tra le diverse culture politiche in cui si articola la cittadinanza, di cui la coppia destra-sinistra è il più pregnante esempio. Ma il confronto, anzi, la contrapposizione “verticale” del popolo tutto intero nella sua incontaminata purezza originaria e di una qualche entità che si pone, indebitamente, al di sopra di esso (una élite usurpatrice, una congrega di privilegiati, un potere occulto) oppure, insinuante, al di sotto (gli immigrati, gli stranieri, le comunità nomadi). Comunque, un elemento “estraneo” e “ostile”, che, con la propria presenza di polo negativo nella nuova dialettica politica, da una parte conferma plasticamente l’unità del popolo “vero”. E, dall’altra, quella contrapposizione di tipo nuovo, determina uno spostamento: (…) dalla spazialità orizzontale (…) a quella verticale, in cui prevale la logica alto-basso».
Perciò il conflitto rimane; ma non è più il virtuoso contrasto fra classi, ceti, generi, così caratterizzandosi come nomenclatura del popolo stesso; è, all’inverso, l’avversione fra un’indistinta entità di popolo – una notte in cui tutte le vacche sono nere – e un “esterno/avverso” che può spaziare da ciò che in altri tempi veniva definito il complotto demoplutogiudaico al rifugiato siriano. Il mondo in cui si agita questo conflitto ha bruciato i ponti alle sue spalle e li ha sostituiti con barriere, filo spinato, recinti. Il territorio che viene difeso non è uno spazio libero, ma un bunker.
Su queste basi Revelli analizza le più recenti vicende politiche e sociali dell’occidente, per poi soffermarsi sulla particolarità del caso italiano, affatto diverso dagli altri, sia perché anticipatore (il primo governo Berlusconi è dell’11 maggio 1994) sia perché complesso e stratificato: “telepopulismo”, “cyberpopulismo”, “populismo dall’alto”.
 Il testimone che viene consegnato al lettore è questa sorta di lente di ingrandimento che consente di distinguere la natura di ciò che avviene sotto i nostri occhi e che sovente appare oscuro e confuso perché è troppo veloce, troppo cangiante, troppo rumoroso e, qualche volta, troppo volgare. Ma è. Ed è bene, quindi, conoscerlo, riconoscerlo, anatomizzarlo. A cominciare dalla nuova struttura economico-sociale del Paese, dall’attuale sistema di corpi intermedi e dall’attuale sistema politico. L’insieme di questi tre fattori – struttura economico sociale, e quindi il lavoro e il welfare, corpi intermedi e partiti, questi ultimi nella loro capacità di rappresentanza e nel loro rapporto con lo Stato – nel dopoguerra e fino agli anni 70 del secolo scorso hanno contribuito in modo determinante alla costruzione della coesione sociale, cioè dei legami tra individui o comunità o ceti, volti a “rimuovere gli ostacoli”, per dirla con l’articolo 3 della Costituzione, causati dalla diseguaglianza economica, culturale, etnica. Ma dagli anni 80 in poi, e sempre più rapidamente negli ultimi anni a causa della crisi del sistema economico-sociale, della progressiva dissoluzione di tanti corpi intermedi (le “formazioni sociali” di cui all’articolo 2 della Costituzione), della trasformazione profondissima del sistema dei partiti, parti rilevantissime delle ragioni della coesione sociale sono venute meno, determinando un progressivo ma rapido imbarbarimento generale dei rapporti sociali.
Il testimone che viene consegnato al lettore è questa sorta di lente di ingrandimento che consente di distinguere la natura di ciò che avviene sotto i nostri occhi e che sovente appare oscuro e confuso perché è troppo veloce, troppo cangiante, troppo rumoroso e, qualche volta, troppo volgare. Ma è. Ed è bene, quindi, conoscerlo, riconoscerlo, anatomizzarlo. A cominciare dalla nuova struttura economico-sociale del Paese, dall’attuale sistema di corpi intermedi e dall’attuale sistema politico. L’insieme di questi tre fattori – struttura economico sociale, e quindi il lavoro e il welfare, corpi intermedi e partiti, questi ultimi nella loro capacità di rappresentanza e nel loro rapporto con lo Stato – nel dopoguerra e fino agli anni 70 del secolo scorso hanno contribuito in modo determinante alla costruzione della coesione sociale, cioè dei legami tra individui o comunità o ceti, volti a “rimuovere gli ostacoli”, per dirla con l’articolo 3 della Costituzione, causati dalla diseguaglianza economica, culturale, etnica. Ma dagli anni 80 in poi, e sempre più rapidamente negli ultimi anni a causa della crisi del sistema economico-sociale, della progressiva dissoluzione di tanti corpi intermedi (le “formazioni sociali” di cui all’articolo 2 della Costituzione), della trasformazione profondissima del sistema dei partiti, parti rilevantissime delle ragioni della coesione sociale sono venute meno, determinando un progressivo ma rapido imbarbarimento generale dei rapporti sociali.
Né serve – mi pare – pensare di “fare come nel 900”, perché ogni esperienza che si limiti a riprodurre il passato senza misurarsi col presente è, per definizione, monca, senza respiro e perciò fallimentare. La vera sfida – certo, a partire dalla memoria attiva – è sul cambiamento, sulla trasformazione oggi, nelle date condizioni attuali, nell’ambito di una prospettiva progettuale, nello spirito di realizzare la Costituzione del 1948.
Aveva proprio ragione Antonio Gramsci quando, su L’Ordine Nuovo dell’aprile 1919, scriveva “Studiate perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza”. Perché se è vero che viviamo “nell’età del vuoto” – vuoto di valori, di orizzonti, di umanità – sta a ciascuno di noi, per quanto può, per quanto vuole, per quanto deve, provare a riempirlo.
Pubblicato giovedì 15 Giugno 2017
Stampato il 04/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/la-forma-informe-del-disagio-della-protesta/