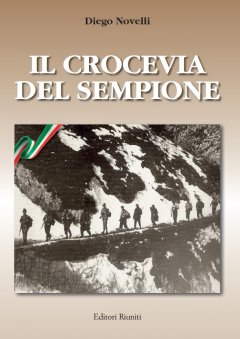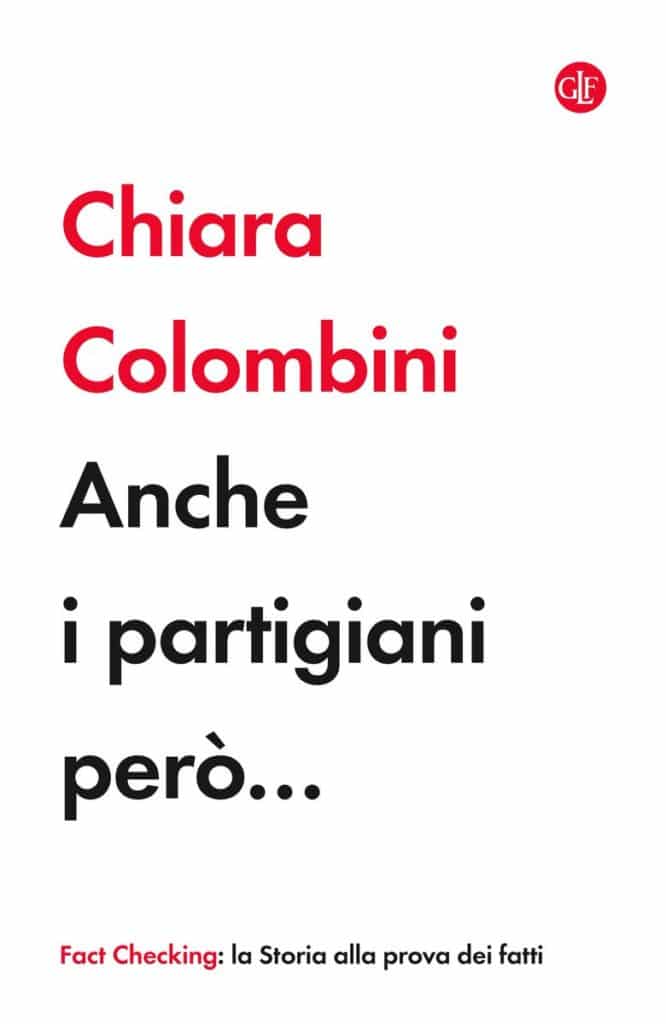 È opinione corrente che la denigrazione ‒ e, in molti casi, addirittura la criminalizzazione ‒ della Resistenza abbia preparato il terreno alla sempre più sfacciata riabilitazione del ventennio, e abbia dunque facilitato il diffondersi del veleno dell’ideologia fascista nel corpo sociale. Un’altra opinione vuole che le fortune del revisionismo di destra siano state in qualche misura favorite dalla scarsa attenzione prestata dalla storiografia di ispirazione democratica alla lotta di Liberazione, magari nella convinzione che la conoscenza e la memoria di essa costituissero un patrimonio ormai stabilmente acquisito alla cultura e alla coscienza civile del Paese.
È opinione corrente che la denigrazione ‒ e, in molti casi, addirittura la criminalizzazione ‒ della Resistenza abbia preparato il terreno alla sempre più sfacciata riabilitazione del ventennio, e abbia dunque facilitato il diffondersi del veleno dell’ideologia fascista nel corpo sociale. Un’altra opinione vuole che le fortune del revisionismo di destra siano state in qualche misura favorite dalla scarsa attenzione prestata dalla storiografia di ispirazione democratica alla lotta di Liberazione, magari nella convinzione che la conoscenza e la memoria di essa costituissero un patrimonio ormai stabilmente acquisito alla cultura e alla coscienza civile del Paese.
A ben vedere, però, gli storici non hanno mai smesso di occuparsi della Resistenza. Fondazioni, istituti e centri di ricerca, singoli studiosi (in più d’un caso, occorre ricordarlo senza falsa modestia, per impulso dell’Anpi) ne hanno indagato approfonditamente ogni aspetto, ne hanno ricostruito criticamente le vicende, spogliando questo evento capitale del Novecento italiano della veste apologetica (e persino agiografica) che lo aveva lungamente addobbato; laddove, paradossalmente, nostalgici più o meno confessi, giornalisti dimentichi degli obblighi deontologici, pubblicisti autoproclamatisi esperti della materia confezionavano una leggenda di segno opposto, manipolando e distorcendo spregiudicatamente la realtà dei fatti, ignorando deliberatamente o travisando le fonti documentarie al fine di sminuire o negare la portata, il valore e il significato della lotta di Liberazione.

Per altro verso, non è del tutto esatto ritenere che le mistificazioni prodotte sul conto della Resistenza abbiano creato un clima favorevole alla rivalutazione del fascismo: è piuttosto vero il contrario. L’immediato e straordinario successo di pubblico ottenuto da Il sangue dei vinti di Giampaolo Pansa, pubblicato nel 2003, testimonia che questo libro dava espressione a un sentimento latente, ma esteso. Un sentimento che affondava le sue radici nel passato remoto – nella continuità fra gli apparati dello Stato repubblicano e quelli del regime, nelle divisioni del fronte antifascista causate dalla guerra fredda, nel rifiuto di fare fino in fondo i conti con il fascismo –, ma che aveva tratto alimento dai profondi mutamenti del quadro politico intervenuti negli anni Novanta (primi fra tutti, la dissoluzione dei partiti che avevano scritto la Costituzione ed edificato la Repubblica, l’entrata in scena del populismo berlusconiano, lo “sdoganamento” dei neofascisti dell’Msi trasmigrati sotto le bandiere di Alleanza nazionale) e, in subordine, dal clamore suscitato da nuove interpretazioni storiografiche del ventennio, a cominciare dalla monumentale biografia di Mussolini scritta da Renzo De Felice e apparsa fra il 1965 e il 1997.
Se un appunto può essere mosso alla cultura democratica di quegli anni è di avere forse sottovalutato l’ondata revisionista, di avere confidato nell’intrinseco potere di persuasione di un discorso scientificamente fondato, di essersi appartata dal dibattito pubblico, di non avere contrastato con la dovuta energia la crescita esponenziale delle false, strumentali e faziose narrazioni della Resistenza. Narrazioni, occorre aggiungere, cui hanno fatto da cassa di risonanza certi giornali e palinsesti televisivi, e che hanno trovato un micidiale strumento di propagazione nei social network.

La situazione però sta cambiando, perché all’interno della storiografia di orientamento democratico va facendosi largo la consapevolezza che il racconto della lotta di Liberazione non può e non deve rivolgersi soltanto agli addetti ai lavori o agli antifascisti, ma eleggere a destinataria una platea più vasta, soprattutto giovanile, che della Resistenza ignora tutto o che di essa possiede scarse e confuse cognizioni. Gran parte del merito di questa svolta va attribuita a una giovane, agguerrita leva di studiosi da Chiara Colombini a Francesco Filippi, da Eric Gobetti a Carlo Greppi, i cui contributi si segnalano per l’afflato etico-politico e per la capacità di coniugare rigore dell’analisi, efficacia argomentativa e taglio divulgativo.

Per la casa editrice Laterza è da poco uscito un volumetto di Chiara Colombini dall’intrigante titolo Anche i partigiani però…, che si prefigge ‒ e lo scopo, conviene dirlo da subito, è egregiamente raggiunto ‒ di mostrare le menzogne, le falsificazioni, le distorsioni, le rimozioni su cui poggia l’immagine della Resistenza contrabbandata dalla cultura di destra, nonché le contraddizioni che la costellano (un solo esempio: come si concilia la tesi secondo cui i partigiani erano tutti comunisti con quella secondo cui la Resistenza fu un “calderone” “in cui si trovano casualmente gomito a gomito sia scalzacani senza idee sia gruppi con interessi diversi”?). La disamina condotta dall’autrice muove da tre premesse di ordine generale. La prima: la Resistenza non tollera definizioni univoche perché fu un fenomeno complesso, nel quale “si incontrano, convivono, si scontrano e si mescolano” differenti motivazioni, esperienze e ideali, e che assume connotazioni specifiche a seconda delle fasi e dei territori in cui si sviluppa. La seconda: i partigiani non erano eroi mitologici, “cavalieri senza macchia”, ma esseri umani, con i loro vizi e le loro virtù. La terza: la Resistenza va collocata nel contesto suo proprio, nello scenario di un conflitto militare di intensità e proporzioni inaudite, e di una guerra civile; giudicarla col senno di poi, col metro dei valori su cui poggia l’odierna sensibilità democratica, appare ingiusto e moralistico.

In questo quadro, Colombini confuta persuasivamente i principali stereotipi ‒ attinti a piene mani dalla memorialistica dei reduci di Salò ‒ attraverso cui la lotta di Liberazione è rappresentata dal revisionismo di destra, che è appunto aduso a dipingere i partigiani come fuorilegge, terroristi, assassini e per giunta vigliacchi, “rubagalline”, a negare il carattere popolare e di massa del movimento resistenziale (i partigiani erano “quattro gatti”) e il suo apporto alla sconfitta del nazifascismo.
Ad esempio, sempre ai revisionisti è riconducibile la visione di una Resistenza non soltanto inutile, ma addirittura controproducente: la guerra venne vinta dagli Alleati e non dai “ribelli”, che ottennero il solo effetto di provocare uno scontro fratricida e di scatenare le ritorsioni dell’esercito del Reich ai danni dei civili). Non potendo illustrare estesamente le puntuali repliche di Colombini ai “capi d’accusa” mossi alla Resistenza, sia consentito spendere poche parole su un solo tema, per il peso rilevante che esso ha avuto e continua ad avere nel discorso pubblico: il tema della violenza, di cui i partigiani furono attori o che innescarono con le loro azioni.

In proposito, l’autrice ricorda opportunamente che le stragi più efferate compiute dai tedeschi non furono rappresaglie, ma vennero dettate dall’intento di seminare il terrore per consolidare il controllo del territorio (anche a costo di desertificarlo), e di infliggere una punizione esemplare a una popolazione considerata complice oggettiva dei “banditi”. E sottolinea, per converso, che la violenza partigiana ebbe un “carattere difensivo”, che essa va commisurata alla ferocia della “guerra totale” pianificata dal nazifascismo, e che venne comunque disciplinata da un codice di condotta e persino da un sistema di regole che vietavano “eccessi e giudizi sommari”. Quanto alla “resa dei conti”, che si consumò fra l’aprile del 1945 e l’autunno dell’anno seguente con l’eliminazione fisica di persone compromesse con il regime, di repubblichini e di collaborazionisti, la Colombini precisa che le uccisioni non sono sempre imputabili ai partigiani, ed esorta a non dimenticare il clima infuocato dell’immediato dopoguerra come pure la rabbia accumulata a seguito delle angherie e delle vessazioni subite dagli oppositori del fascismo e dai ceti più umili nell’arco del ventennio.
Occorre amaramente constatare che la denuncia della violenza partigiana strombazzata dal revisionismo di destra fece breccia persino nella sinistra postcomunista. Traumatizzati dagli eventi del 1989 e dal collasso del socialismo reale, colti dall’ansia di chiudere con il passato, di darsi una nuova identità per accreditarsi come forza di governo affidabile, coloro che per decenni si erano proclamati gli autentici eredi della Resistenza scelsero di sacrificarla sull’altare della “memoria condivisa”, che omologa torti e ragioni, confonde le responsabilità, mette sullo stesso piano carnefici e vittime. E comprendere in quale misura ciò abbia concorso a rendere marginale la Resistenza nella memoria pubblica, è questione di rilevanza politica non secondaria.
Ferdinando Pappalardo, vice presidente nazionale Anpi, presidente Comitato provinciale Anpi Bari
Pubblicato lunedì 15 Marzo 2021
Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/perche-le-bugie-sulla-resistenza-hanno-le-gambe-corte/