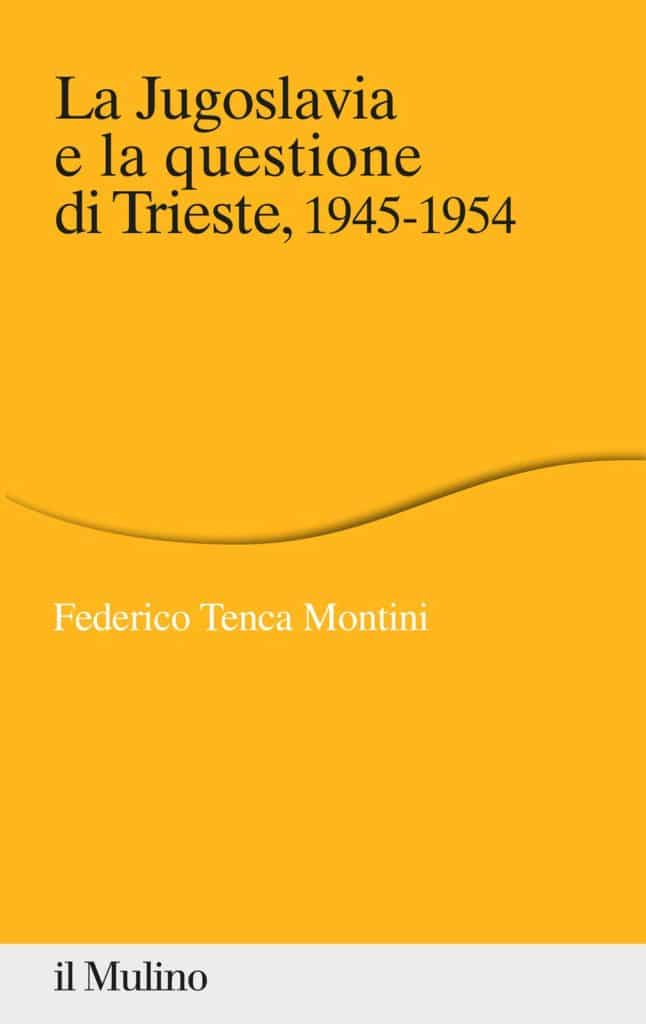 Il nome di Trieste è indissolubilmente legato a una certa idea di frontiera, come spazio geografico di incontri, di ibridazione e di cooperazione tra comunità diverse per lingua, religione e cultura ma anche come luogo di tensioni e conflitti che in momenti di crisi si manifestano oltre la dimensione locale e si proiettano direttamente sul piano delle relazioni tra Stati.
Il nome di Trieste è indissolubilmente legato a una certa idea di frontiera, come spazio geografico di incontri, di ibridazione e di cooperazione tra comunità diverse per lingua, religione e cultura ma anche come luogo di tensioni e conflitti che in momenti di crisi si manifestano oltre la dimensione locale e si proiettano direttamente sul piano delle relazioni tra Stati.
Per anni, sotto la dominazione asburgica, Trieste è stata la città multietnica per eccellenza, dove l’italiano era la koiné alla quale si ricorreva in prevalenza come lingua d’uso nella sfera pubblica, salvo poi rientrare nei ranghi del multilinguismo quando si veniva ai rapporti privati, personali e familiari, mescolandosi con il croato, lo sloveno, il tedesco e perfino l’yiddish; e per molto tempo, l’autonomismo, e non il nazionalismo è stata la cifra che ha connotato le vicende politiche di territori, nei quali l’appartenenza statale è stata solo una delle determinanti del carattere e delle aspirazioni nazionali.
 Le cose, come è noto, cambiano con la fine della prima guerra mondiale: Trieste, più ancora di Trento, diviene la città simbolo della vittoria italiana, dell’unità nazionale realizzata ma anche e sempre più di un imperialismo insieme debole e pretenzioso, orientato verso l’area adriatica e balcanica ma frustato dall’insorgere di una nuova realtà statale, il Regno di Serbi, dei Croati e degli Sloveni, poi Jugoslavia, la cui sola esistenza vanificava le ambizioni espansionistiche che avevano trovato sanzione nel Patto di Londra del 1915.
Le cose, come è noto, cambiano con la fine della prima guerra mondiale: Trieste, più ancora di Trento, diviene la città simbolo della vittoria italiana, dell’unità nazionale realizzata ma anche e sempre più di un imperialismo insieme debole e pretenzioso, orientato verso l’area adriatica e balcanica ma frustato dall’insorgere di una nuova realtà statale, il Regno di Serbi, dei Croati e degli Sloveni, poi Jugoslavia, la cui sola esistenza vanificava le ambizioni espansionistiche che avevano trovato sanzione nel Patto di Londra del 1915.

Poco meno di trent’anni dopo, nel maggio del 1945, Trieste diventava nuovamente la città simbolo non più del trionfo, ma dell’ignominiosa catastrofe della guerra mussoliniana. Dopo due anni di occupazione della Slovenia e del Montenegro, durante la quale l’Italia fascista aveva dato prove di efferata violenza nella repressione della Resistenza slovena e nel terrore applicato sistematicamente contro la popolazione civile, in una misura tale da non avere nulla da invidiare agli alleati nazisti; dopo l’8 settembre e l’annessione di fatto del Friuli e della Venezia Giulia da parte del Terzo Reich con la creazione dell’Adriatische Kunstenland, il 1° maggio 1945 la città veniva occupata dalle forze dell’Esercito popolare di liberazione jugoslavo, ovvero da milizie composte da quegli stessi slavi su cui per un ventennio si era esercitata la violenza fisica e morale del regime fascista, che proprio contro la popolazione slovena e croata dei territori annessi dopo il 1918 aveva praticato una politica di sistematica discriminazione e di italianizzazione forzata, destinata a lasciare un lungo strascico di odio e di risentimento.

Con l’ingresso della IV armata e del IX Korpus sloveno dell’esercito jugoslavo (che precedette di un solo giorno l’arrivo dei reparti della II divisione neozelandese appartenente all’VIII Armata britannica), Trieste divenne l’oggetto di una contesa tra gli Alleati che, nei suoi termini militari e diplomatici, anticipava quello che la città sarebbe diventata negli anni successivi: un confine ideologico oltre che politico, uno dei punti di frizione tra Oriente e Occidente, lungo il quale si giocò una complessa partita diplomatica che si sarebbe protratta per un decennio dalla fine della seconda guerra mondiale e che avrebbe trovato definitiva soluzione solo trent’anni dopo, con il Trattato di Osimo del 1975.
Com’è noto, dopo quaranta giorni di occupazione della città di Trieste, l’esercito jugoslavo si ritirò a est della linea Morgan (dal nome del generale britannico Willian Duthie Morgan che gestì i rapporti con la Resistenza jugoslava per conto del suo diretto superiore, il generale Alexander, comandante delle truppe alleate in Italia), che divideva in due parti la Venezia Giulia, cedendo, con gli accordi di Belgrado e di Duino, alla fortissima pressione politica e militare anglo-americana, ma anche subendo l’invito alla prudenza rivolto da Stalin a Tito, la cui politica aggressivamente espansionistica iniziava fin da allora a impensierire i sovietici.

Da questo episodio prende l’avvio il volume di Federico Tenca Montini, La Jugoslavia e la questione di Trieste, 1945-1954 (Il Mulino, 2020), una ricerca sulla storia diplomatica della vicenda triestina vista soprattutto da Belgrado e condotta attraverso un accurato lavoro di scavo degli archivi, e in particolare degli archivi diplomatici della ex Jugoslavia. Si tratta dunque di una ricerca importante soprattutto perché sottrae la problematica relativa alla questione triestina a uno sguardo esclusivamente o prevalentemente nazionale – e alle polemiche più o meno esplicitamente strumentali che a esso si accompagnano – per riportarlo sul piano delle relazioni diplomatiche, dove diversi attori giocarono ruoli differenti a seconda delle circostanze, degli interessi e dell’indirizzo seguito da ciascuno dei governi in carica.
Nel periodo di cui tratta il lavoro di Federico Tenca Montini, sembra di potere affermare che le relazioni dirette italo-jugoslave occuparono un ruolo secondario (emblematico, a questo proposito, il fallimento delle trattative dirette condotte tra il vice ministro degli esteri jugoslavo Aleš Bebler e il capo della delegazione italiana presso le Nazioni Unite Gastone Guidotti, tra il novembre 1951 e il marzo 1952), e comunque subalterno rispetto allo scenario principale, quello della internazionalizzazione della questione di Trieste e dei rapporti multilaterali che si istaurarono tra i due contendenti e gli altri interlocutori: Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, in primo luogo, mentre, come si può evincere chiaramente dai vari passaggi della vicenda diplomatica, il ruolo dell’Unione Sovietica si appanna e diventa marginale, salvo qualche sporadica iniziativa, dopo l’espulsione della Jugoslavia dal Cominform, il 28 giugno 1948.

Un elemento di continuità della politica jugoslava estera nel dopoguerra è costituito dall’obiettivo di impedire il ritorno di Trieste sotto la sovranità italiana, un motivo legato certamente a considerazioni di prestigio internazionale, ma anche alla consapevolezza del ruolo cruciale che la città giuliana avrebbe potuto svolgere come nodo di collegamento dell’area adriatica con il retroterra mitteleuropeo e con quello balcanico. Un’area, quest’ultima, nella quale il regime del maresciallo Tito aspirava ad affermare la propria egemonia, perseguendo le politiche che avrebbero prima allarmato i sovietici e poi suscitato le forti preoccupazioni non solo italiane ma anche degli ambienti del Patto Atlantico.
Il punto è, e il lavoro di Tenca Montini spiega bene questo profilo, che l’andamento spesso ondivago delle posizioni occidentali sulla questione di Trieste dipese molto dal mutamento della collocazione internazionale della Jugoslavia, alla quale corrispose la scelta dei Paesi occidentali di coltivare, dopo lo scisma di Tito, un rapporto di collaborazione economica e militare senza mettere in discussione il regime comunista (keep Tito afloat, tenere Tito a galla, secondo l’indicazione del ministro degli esteri britannico Anthony Eden), poiché si riteneva essenziale l’apporto di Belgrado al contenimento e all’indebolimento del blocco sovietico. Si può sostenere, per questo aspetto, che la disponibilità americana e inglese a venire incontro alle rivendicazioni jugoslave trovò un limite soprattutto nella contrastante esigenza di non minare la credibilità dei governi centristi italiani nel loro ruolo di diga anticomunista e di mantenere alto il prestigio che essi avevano conseguito presentandosi all’opinione pubblica interna come i paladini dell’italianità di Trieste.
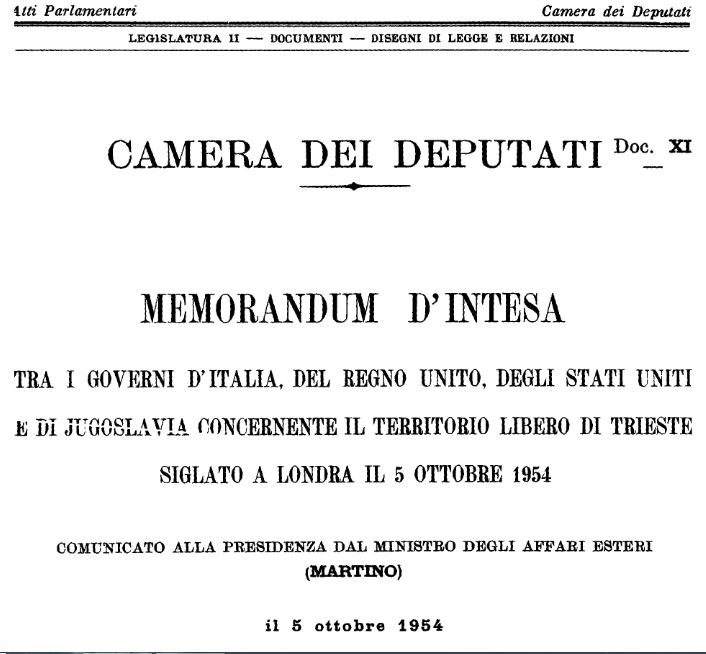 Per questo aspetto, peraltro, si può affermare che le opinioni pubbliche giocarono un ruolo non trascurabile nella contesa tra i due Paesi, come l’autore ricorda in diversi passaggi del suo lavoro, ricostruendo in primo luogo le mobilitazioni popolari in Jugoslavia, in origine spontanee ma poi abilmente guidate dal regime, di protesta contro la Nota bipartita angloamericana dell’8 ottobre 1953, percepita come un tradimento da parte di Belgrado, dato che annunciava unilateralmente il ritiro delle truppe alleate dalla zona A, prefigurandone il passaggio all’amministrazione italiana (e prevedendo, in una clausola segreta resa nota solo al governo italiano, di non opporsi al passaggio definitivo della zona B alla Jugoslavia).
Per questo aspetto, peraltro, si può affermare che le opinioni pubbliche giocarono un ruolo non trascurabile nella contesa tra i due Paesi, come l’autore ricorda in diversi passaggi del suo lavoro, ricostruendo in primo luogo le mobilitazioni popolari in Jugoslavia, in origine spontanee ma poi abilmente guidate dal regime, di protesta contro la Nota bipartita angloamericana dell’8 ottobre 1953, percepita come un tradimento da parte di Belgrado, dato che annunciava unilateralmente il ritiro delle truppe alleate dalla zona A, prefigurandone il passaggio all’amministrazione italiana (e prevedendo, in una clausola segreta resa nota solo al governo italiano, di non opporsi al passaggio definitivo della zona B alla Jugoslavia).
Sul versante italiano, d’altra parte, il timore di un definitivo abbandono della zona B alla Jugoslavia rinfocolò le tensioni nazionaliste, alimentate anche dalla condotta delle autorità municipali (in particolare del sindaco Gianni Bartoli), che innescarono i sanguinosi disordini triestini del 4, 5 e 6 novembre 1953, nel corso dei quali si verificarono numerose aggressioni contro il cinema inglese, la sede del partito indipendentista e la tipografia slovena, di cui furono protagonisti soprattutto gli esponenti del Movimento sociale italiano.

In questo scenario, animato da forti tensioni e da un alimentato sciovinismo al quale non erano estranee, da ambo le parti, motivazioni di politica interna, si inquadrano i diversi momenti della vicenda diplomatica relativa a Trieste: come è noto, con il Trattato di pace del 1947, Trieste e la zona costiera circostante furono erette a Stato (il Territorio libero di Trieste, da qui in avanti abbreviato in TlT nell’articolo), temporaneamente diviso, fino all’entrata in funzione degli organi di governo, in una zona A, comprensiva di Trieste, posta sotto l’amministrazione del comando alleato e la zona B, a sud di Trieste, posta sotto l’amministrazione militare jugoslava. A causa dei contrasti sorti tra gli Alleati e dei veti avanzati dai diversi Paesi sui nomi proposti alla carica di governatore, il TlT non entrò mai in funzione e lo status quo si protrasse con alterne vicende fino al Memorandum di Londra. Negli anni in cui la Jugoslavia restò nell’orbita dell’Unione Sovietica, la politica degli Alleati occidentali fu dominata, come si è detto, dalla preoccupazione di favorire la stabilità del governo italiano guidato, a partire dal maggio 1947, dalla Dc: di certo, la cosiddetta Dichiarazione tripartita (20 marzo 1948) con la quale i governi di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti chiedevano la restituzione all’Italia dell’intero TlT svolse un ruolo non trascurabile nell’affermazione del partito cattolico alle elezioni del 18 aprile 1948: si trattò, peraltro, di una mossa propagandistica, che servì solo a riaccendere le tensioni tra Est e Ovest e che gli Alleati occidentali dovettero prontamente rimangiarsi quando la Jugoslavia, sganciatasi dal blocco orientale, divenne improvvisamente un potenziale alleato, la cui vicinanza alle potenze atlantiche spostava, tra l’altro, notevolmente a est il confine con il blocco antagonista.

Nei sei anni che separano la Nota tripartita dal Memorandum di Londra, si susseguono diversi tentativi di composizione della questione triestina, sempre all’insegna dell’intento occidentale di consolidare la Jugoslavia in funzione antisovietica e, al tempo stesso, di sostenere i governi centristi italiani nel loro impegno di contenimento del più grande partito comunista dell’Occidente capitalistico. Quest’ultimo, peraltro, aveva subìto anch’esso gli effetti della svolta di Belgrado: dall’accordo tra Tito e Togliatti del novembre 1946, che proponeva una composizione del contenzioso tra i due Paesi attraverso la cessione di Gorizia alla Jugoslavia e di Trieste all’Italia (proposta che si scontrò con la reazione ostile della maggior parte dei partiti politici italiani).
Il Pci sarebbe passato, dopo il 1948, a un sostanziale allineamento alle posizioni sovietiche di condanna delle “deviazioni” di Tito, accompagnato da una attenta vigilanza ideologica sui non pochi iscritti e dirigenti del partito che avevano militato nelle file della Resistenza jugoslava. In questo ambito si inquadra anche la vicenda dei deputati comunisti dissidenti Valdo Magnani, con un passato di partigiano in Jugoslavia, e Aldo Cucchi, oggetto di una pesante campagna diffamatoria da parte dei vertici del Pci e accusati, senza in realtà alcun presupposto, di posizioni filotitine.

Al tempo stesso, la presa di distanza del Pci dalla Jugoslavia aveva anche ridotto la possibilità di utilizzare la questione di Trieste in chiave anticomunista nel dibattito politico interno. L’insuccesso elettorale della Dc nelle elezioni politiche del 1953, con il mancato raggiungimento del quorum che avrebbe fatto scattare il premio di maggioranza previsto dalla legge truffa, dimostrava che l’uso della questione di Trieste in funzione anticomunista non aveva la stessa efficacia che in passato. Ciò peraltro non comportò un ridimensionamento della rilevanza di quest’ultima nel dibattito pubblico: al contrario, la ripresa dell’oltranzismo antislavo da parte del Governo Pella (costituitosi all’indomani delle elezioni e sostenuto della destra monarchica e missina) con la concentrazione di truppe italiane sulla frontiera orientale (fine estate 1953) giustificata da argomenti pretestuosi, fu l’estremo tentativo del governo italiano di avvalersi di una situazione internazionale ritenuta favorevole, per cercare di reinserire l’Italia nel gioco diplomatico attraverso una manifestazione di forza.

Nella valutazione del Presidente del consiglio italiano, ricorda Tenca Montini, pesava l’idea di condizionare il voto favorevole dell’Italia alla Ced a sostegno degli alleati occidentali a una soluzione vantaggiosa del contenzioso con la Jugoslavia, tanto più che quest’ultima aveva iniziato un prudente riavvicinamento all’Urss (a pochi mesi di distanza dalla morte di Stalin), che non mancava di impensierire le diplomazie di Parigi, Londra e Washington.
In generale, si può affermare che la Jugoslavia agì nella consapevolezza del proprio rafforzamento nello scacchiere europeo e atlantico (forse in alcuni momenti sopravvalutato) all’indomani della rottura con Mosca e cercò di avvalersi della sua posizione di vantaggio anche per risolvere a suo favore la questione di Trieste. Comprendendo che Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia non avrebbero mai acconsentito all’annessione della città giuliana alla Jugoslavia, Tito, Kardelj e Bebler, il viceministro degli esteri che più di altri esponenti del governo jugoslavo fu impegnato su questo tema, si mossero soprattutto per conseguire il risultato di impedirne il passaggio all’Italia, coltivando anche il progetto di una rivitalizzazione del Territorio libero di Trieste attraverso una gestione in forma di condominio italo-jugoslavo, come presupposto per la costruzione graduale di una posizione di preminenza per Belgrado.

Per questo aspetto il Memorandum di Londra, giunto al termine di una trattativa tra Jugoslavia, Gran Bretagna e Stati Uniti nella quale il ruolo dell’Italia fu nel complesso marginale, condusse a una soluzione di certo non del tutto gradita alla diplomazia jugoslava, ma anche accolta come una via di uscita da una situazione che rischiava di trascinarsi ancora per anni; con l’assegnazione della zona A all’amministrazione civile italiana e della zona B alla Jugoslavia, il Memorandum poneva fine alla finzione del TlT e al tempo stesso, come suggerisce Tenca Montini in conclusione del suo lavoro, assolveva a un’altra importante funzione, quella, cioè, di chiudere un contenzioso che, visto da Belgrado, appariva il lascito ormai gravoso di una contesa circoscritta all’assetto dell’area alto-adriatica e balcanica, nel momento in cui maturava un profondo mutamento di indirizzo della politica estera jugoslava, con l’accentuazione della posizione di equidistanza dai blocchi e l’avvicinamento ai Paesi asiatici e africani di recente indipendenza e ai movimenti di liberazione nazionale nei Paesi coloniali, e con l’inizio di quell’intenso lavorio diplomatico che avrebbe portato nel 1955 alla conferenza di Bandung e poi alla conferenza di Belgrado che, nel 1964, tenne a battesimo il Movimento dei Paesi non allineati.

Come l’autore chiarisce nelle pagine iniziali e come spiega anche Jorže Pirjevec nell’interessante prefazione al volume, il lavoro di Tenca Montini colma molte lacune di conoscenza storica, fornendo una ricostruzione particolarmente dettagliata degli eventi, che consente di mettere a fuoco aspetti meno noti o meno studiati della storia del confine italo-jugoslavo (oggi italo-sloveno) nel dopoguerra, soprattutto sul versante diplomatico. Questo risultato, come si è detto, è stato conseguito soprattutto grazie a un lavoro di scavo condotto sugli archivi della ex Jugoslavia che non ha precedenti, almeno nella storiografia in lingua italiana, e che non si è limitato a un semplice lavoro di filologia documentaria, ma ha ricostruito l’azione diplomatica del governo jugoslavo nel complesso rapporto con la pluralità degli attori coinvolti con maggiore o minore intensità nel difficile sforzo di escogitare soluzioni idonee a spegnere un focolaio di tensione che in alcuni momenti aveva rischiato di compromettere i difficili equilibri costruiti in Europa del secondo dopoguerra. Nel complesso, sembra di potere osservare che la giusta priorità assegnata dall’autore anche ai dettagli delle vicende diplomatiche e della politica portata avanti da Belgrado ha comportato, in alcuni passaggi del volume, una certa asimmetria nella trattazione, per quanto riguarda alcuni temi relativi all’Italia. Accenniamo qui a due ordini di considerazioni.
Una prima questione riguarda l’analisi della posizione del Pci, considerato che anche l’accordo tra Tito e Togliatti del 1946 va interpretato alla luce dei dilemmi posti a un partito comunista forte di un notevole sostegno elettorale dalla sua collocazione nella sfera di influenza occidentale – come peraltro Tenca Montini chiarisce – ma anche con riferimento alla lunga e complessa vicenda del rapporto tra i comunisti italiani e i comunisti sloveni nel periodo della Resistenza, alle difficoltà nelle quali si trovò il Pci nei confronti delle pretese annessionistiche di un movimento di Liberazione che si andava trasformando in un regime a partito unico, oscillando tra la difesa dell’unità nazionale e gli obblighi di solidarietà internazionalista del movimento comunista, e indebolito dalle ambiguità delle posizioni sovietiche, frenate nel sostegno pieno alle pretese jugoslave soltanto dal desiderio di non incrinare l’unità dell’alleanza contro le potenze dell’Asse.
Un secondo tema, peraltro introdotto nel lavoro di Tenca Montini soprattutto con riferimento alla persistente attività terroristica antislava a opera di gruppi neofascisti nel dopoguerra, riguarda la politica condotta dai governi centristi nell’area giuliana e friulana, e soprattutto l’attività dell’Ufficio zone di confine, istituito presso la Presidenza del Consiglio con l’incarico di prestare assistenza alle popolazioni, ma diventato anche il tramite del finanziamento e del supporto alle formazioni paramilitari anticomuniste sorte subito dopo la conclusione del conflitto per iniziativa di ex partigiani delle brigate Osoppo (formazioni dalla quali sarebbero stati reclutati anche alcuni “gladiatori” dello Stay behind italiano) e, soprattutto dei gruppi neofascisti che trovarono nell’area alto-adriatica, un terreno privilegiato di iniziativa e di proselitismo, grazie al favore loro accordato negli ambienti militari e di governo.
Tra l’altro, il tema della continuità delle politiche antislave nell’Italia repubblicana, del sostegno che i governi centristi assicurarono alla galassia anticomunista e neofascista che agì nell’area friulana e giuliana per almeno un decennio dalla fine della guerra, è rimasto a lungo marginale nella ricerca storica, soprattutto se lo si paragona al grande lavoro di ricostruzione delle drammatiche vicende del confine italo-sloveno del 1943-1945: un avvio di ricerca su questo aspetto potrebbe riservare non poche sorprese e, di certo, aggiungere qualche elemento di riflessione sulla presenza del nazionalismo italiano nell’area alto-adriatica, sulla sua attività legale e illegale e sulla difficoltà per la democrazia italiana di liquidare il gravoso lascito del “fascismo di confine”.
Pubblicato venerdì 7 Maggio 2021
Stampato il 05/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/quel-confine-freddo-bollente/








