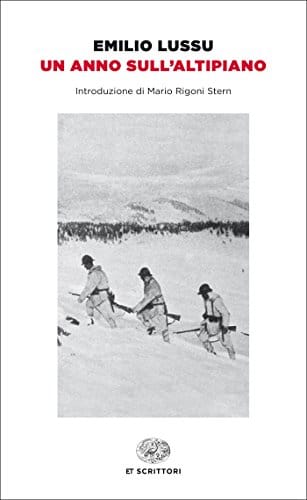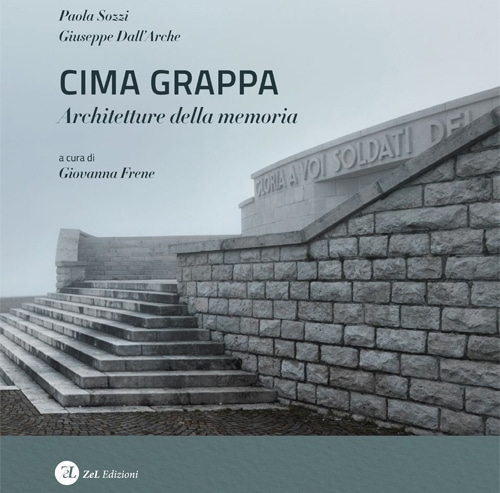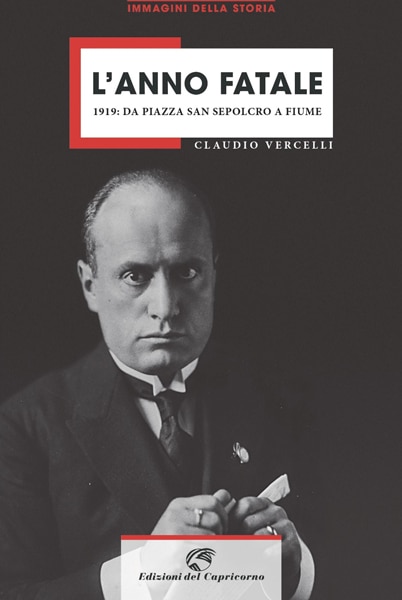Ha tutta la dolcezza di una pagnotta appena sfornata, formato minuto, colori tenui, carta vellutata piacevole al tatto, questo intimo racconto che Margherita Oggero dedica alla memoria della sua vita in famiglia, alla sua infanzia e ai cibi del cuore. Non a caso esce nella “Piccola biblioteca di cucina letteraria” che, a cura di Giovanni Nucci, troviamo tra la “Narrativa Slow” di Slow Food editore.
Ha tutta la dolcezza di una pagnotta appena sfornata, formato minuto, colori tenui, carta vellutata piacevole al tatto, questo intimo racconto che Margherita Oggero dedica alla memoria della sua vita in famiglia, alla sua infanzia e ai cibi del cuore. Non a caso esce nella “Piccola biblioteca di cucina letteraria” che, a cura di Giovanni Nucci, troviamo tra la “Narrativa Slow” di Slow Food editore.

L’immagine di pace domestica evocata dall’illustrazione di copertina, tavola apparecchiata con tovaglia a quadretti, forchetta e cucchiaio, coltello e pane e l’immancabile schiscetta di chi pranza fuori casa, viene contraddetta, quasi annullata, dalla forza dolorosa della parola guerra del titolo. Parola già dal suono fastidiosa, tanto gutturale quanto graffiante, che, nell’abbracciare la morbida rotondità della parola pane risulta ancor più inaspettata, dura. Ancora di più, l’idea di guerra – sangue morte distruzione – appartiene a un mondo senza pace né cibo, senza speranza né profumi, senza futuro né colori. Un mondo, quindi, senza pane.

Certamente voluto il gioco letterario con il celebre capolavoro di Tolstoj, forse un omaggio della scrittrice torinese a uno dei pilastri della letteratura mondiale o forse, perché no, una “carezza lontana” a un mondo perduto in cui le parole erano ancora l’essenza di ciò che descrivevano. Margherita Oggero ha un suo modo tutto particolare di posare lo sguardo sulle vicende della gente comune, con un occhio di riguardo per chi vive nella difficoltà, ai margini, fuori dai riflettori, e di narrarne le vite con pacata e sorniona curiosità quasi affettuosa.

Uno stile inconfondibile dal quale sono nati, tra gli altri, il romanzo La collega tatuata, da cui è stato tratto il film Se devo essere sincera con Luciana Littizzetto e Neri Marcorè, ma anche le sceneggiature della serie televisiva Provaci ancora prof con Veronica Pivetti, oltre ai romanzi Una piccola bestia ferita (2003), L’amica americana (2005), Così parlò il nano da giardino (2006), Qualcosa da tenere per sé (2007), Il compito di un gatto di strada (2009), la ragazza di fronte (2015) Non fa niente (2017 e 2019) e La vita è un cicles (2018).

Ora quello stesso sguardo, quella carezza leggera di mano tra i capelli, quella tenerezza con cui inventa e fa vivere tutti i suoi personaggi di fantasia, li ha trasferiti qui, nella storia di un pezzetto della sua vita, nel racconto di un’infanzia tanto lontana quanto presente e viva. Margherita torna bambina: una bambina vivace e simpatica nella Torino dei primi anni Quaranta, e ci racconta di una vita fatta di piccole ma indimenticabili cose, come un solo cappottino di lapin che perde il pelo ma scalda tanto, una pallina viola con cui giocare, gli zoccoletti di legno che le piacciono perché fanno “molto rumore”.

In questa Torino di freddi ballatoi e calda solidarietà umana ritorna a casa il papà di Margherita: arriva dalla campagna di Russia e la bambina non l’ha mai visto, richiamato alle armi mentre lei nasceva. “Quando mio padre tornò a casa io non lo riconobbi”: inizia così il libro. E Guerra e pane è davvero: non solo perché lei non può ritrovare in quell’uomo “sporco, con la faccia ispida di barba, magro come un palo della luce e insicuro nei passi” l’idea di papà che si era creata ma anche perché, di colpo, sembra che le porti via l’amore di mamma. Inoltre il padre, pelle o ossa per la gran fame e pochi denti per mangiare, viene nutrito a brodi e semolini ma soprattutto a suon di panada, uno dei piatti che Margherita detesta.

“Alla panada feci da subito guerra”: ecco il cuore del racconto, l’anello di congiunzione tra l’amore per il padre, l’odiosa guerra che lo restituisce malconcio e la povera panada (buonissima zuppa della tradizione piemontese a base di pane raffermo e brodo di carne che prende tutto il sapore dalla lenta cottura sulla stufa economica), il potagè che diventa il pretesto per dichiarare tutto il disagio della bambina per il nuovo venuto, per quella presenza che non riesce ad accettare.

Dal racconto di Margherita Oggero riemerge una cucina povera ma dagli ingredienti genuini, recuperati con amore anche in tempo di guerra: quanta fatica fanno mamma e figlia a cavallo della bici del nonno per trovare al mercato nero un poco di zucchero o le ossa “vestite” per il brodo di carne! Poi la bimba si fa grande, arriva all’asilo dalle suore e la buona cucina di famiglia diventa il pranzo da asporto: ogni bambino custodiva gelosamente nel suo barachin un pasto completo, primo, secondo e contorno, cucinato in casa la sera prima. Scaldati a bagnomaria, “le paste e fagioli e gli agnolotti, gli spezzatini con purè e le frittate alle erbette” diventano golosi pranzetti in compagnia.

Benedetta la nostra pietanziera degli anni dell’asilo: tornata velocemente di moda in questo tempo di pranzi in piedi e cibi salutari ne racconta la storia Grazia Novellini nell’appendice “Dalla gavetta al barachin, mangiare fuori casa in guerra e pace”. Concludono questo delicato pamphlet, che “cucina” con amore sapori e affetti familiari e li condisce con un pizzico di poesia, che non guasta mai, con le ricette più significative, narrate con dettagliata precisione.

Oltre alla più volte citata panada, perno del racconto per la sua morbida e vellutata semplicità, un abbraccio di altri tempi, la quasi scomparsa minestra di semolino, sia nella versione brodosa e da svezzamento che nella più succulenta polenta solida da fritura dossa, la frittura dolce del fritto misto alla piemontese, quindi riso, latte e castagne, vera magia dell’incontro tra la pianura più piatta, le risaie del mare a quadretti, e le boscose Prealpi che vi si specchiano. Regina indiscussa della cucina vercellese, poi, che Margherita Oggero impara a conoscere quando, da bambina, frequenta la “bassa” vercellese, è la panissa. Più che una ricetta, il simbolo di una terra: la panissa, qui presentata dall’autrice nella versione con riso superfino Carnaroli e fagioli di Saluggia, lardo e cotenna e salam ‘d la doja (salame sotto grasso), essendo un piatto che coniuga parte vegetale e animale, mondo di campagna e mondo di città, ha generato, come potete immaginare, molte varianti, forse tante quante sono le cuoche e i cuochi che si cimentano, in pubblico e in privato, nella sua lunga e tradizionale preparazione. Quale la migliore? Quella che si cucina con calma, attenzione e amore, come quando si legge un buon libro. Un libro come questo.
Elisabetta Dellavalle, giornalista, collabora anche con la Stampa
Pubblicato sabato 25 Giugno 2022
Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/una-memoria-da-mangiare/