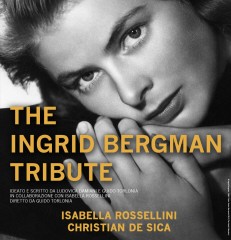A tre anni da Bella Addormentata, Marco Bellocchio torna alla Mostra del Cinema di Venezia con la sua ultima fatica, Sangue del mio sangue: una storia ambientata nelle antiche prigioni di Bobbio, borgo natio nel quale cinquant’anni fa, non a caso, il regista piacentino girò il suo film d’esordio, I pugni in tasca.
A tre anni da Bella Addormentata, Marco Bellocchio torna alla Mostra del Cinema di Venezia con la sua ultima fatica, Sangue del mio sangue: una storia ambientata nelle antiche prigioni di Bobbio, borgo natio nel quale cinquant’anni fa, non a caso, il regista piacentino girò il suo film d’esordio, I pugni in tasca.
Sangue del mio sangue è un film atipico, inaspettato; un film che nasce dal desiderio di concedersi una libertà. «Non è un film all’americana», basato su una solida impalcatura drammaturgica, dove tutto deve corrispondere, dove tutto deve essere spiegato. «Volevo andare per la mia strada, fare quello che mi piace fare. La libertà è lo spirito di questo film» ha dichiarato il regista. Libertà dagli schemi, dalle definizioni, dalla metafisica, dalla complessa necessità intellettuale e politica alla quale Bellocchio ci ha abituati.

Situato in due diverse epoche, quella secentesca e quella contemporanea, il film prende le mosse dalla storia, già trattata ne La Monaca di Bobbio – cortometraggio realizzato nel 2009 insieme agli studenti del laboratorio Fare Cinema – di Benedetta (Lydia Liberman, che in più di una scena ricorda la Giovanna D’Arco di Dreyer), suora di clausura rea di aver sedotto e reso folle il suo confessore, il sacerdote Fabrizio Mai, gemello di Federico, interpretato da Pier Giorgio Bellocchio, che a Bobbio si reca in cerca di un riscatto. Ma la riabilitazione morale del fratello, e della famiglia tutta, sarà possibile soltanto laddove la giovane accetti di confessare il suo patto con Satana: cosa che non avverrà mai. Liberamente ispirato a quello della monaca di Monza, il personaggio di Benedetta è l’incarnazione del concetto di libertà, una libertà sostenuta con dolore, che non si arrende nemmeno di fronte alla minaccia di essere murata viva.
Oltre ai numerosi rimandi biografici, nel film sono presenti molti dei topoi della cinematografia di Bellocchio: il doppio e, più nello specifico, la gemellarità (si pensi Gli occhi, la bocca), il desiderio, la possessione femminile (Il diavolo in corpo, La visione del sabba), la famiglia (I pugni in tasca). Nonostante l’evidente diversità nello spirito, nelle intenzioni, la connessione visiva con il primo film del regista resta forte: l’interno della sala da pranzo delle sorelle Perletti (le due donne, interpretate da Federica Fracassi e Alba Rohrwacher, che prestano ospitalità a Don Federico), già utilizzato per le riprese di Sorelle Mai (2010), è – per dirne una – lo stesso de I Pugni in tasca, nonché la vera sala da pranzo della famiglia Bellocchio. Si direbbe una resa dei conti, la chiusura di un cerchio, un ritorno pacificato alle origini: un ponte tra passato e presente, che si ricongiungono attraverso i luoghi, le memorie, le allusioni.

Dal dominio della Chiesa cattolica nel Seicento al dominio democristiano in Italia. Alla grevità della prima sezione, sostenuta dalla fotografia caravaggesca di Daniele Ciprì e dalle musiche di Carlo Crivelli, si contrappone l’ironia della seconda parte, ambientata nella Bobbio dei nostri giorni, nella quale un sedicente ispettore del demanio (lo stesso Federico Mai/Pier Giorgio Bellocchio) con magnate russo al seguito (Ivan Franek) giunge nel tentativo di acquistare le prigioni del paese. Una Bobbio a misura di mondo, specchio di un’Italia paesana e corrotta, seppure in via di globalizzazione, che della dimensione del paese ha forse trattenuto solo il peggio; una sorta di regno autarchico (torna il tema della clausura) le cui fila sono mosse da uno stratega che vive nascosto nei sotterranei del vecchio carcere-convento: il Conte Basta (evoluzione, perdente, di quegli stessi inquisitori che condannarono la suora), magnificamente interpretato – manco a dirlo – da Roberto Herlitzka, metafora dell’immobilismo, di un vampirismo ambientale e “isolazionista”, come lui stesso ha a dire, che succhia il sangue alla possibilità di un cambiamento, di un rinnovamento autentico. Allo sguardo dei sacerdoti, nella Bobbio di oggi si sostituisce l’obiettivo dei telefoni cellulari e la follia assume i toni della disperazione che esplode in seguito alle difficoltà della vita (quelle di Filippo Timi nei panni del matto del villaggio e della moglie del Conte Basta, interpretata da Patrizia Bettini).

Un film che rimane, in più di un’occasione, volutamente in superficie, poiché tenta di continuo uno scarto dal consequenziale, che lascia intuire, intravedere, senza espor(si) mai del tutto. Un film spezzato, frammentato, come questo Paese, come la contemporaneità. Un film che sembra sancire, in fin dei conti, il trionfo della bellezza (si pensi non soltanto alla monaca, ma anche all’inspiegabile potere che gioca sul conte la grazia femminea della giovane Elena). Una bellezza che può cambiare il mondo, che può restituire uno slancio vitale, e che trionfa, luminosissima, nel finale, spogliata da qualsiasi pregiudizio o peccato, nuda nella figura di Benedetta, fuori dalla sua prigione di mattoni.
Azzurra Sottosanti, studiosa di filosofia e discipline storico-critiche, scrittrice di cinema e musica per vari periodici, assistente di produzione, esperta di promozione culturale
Pubblicato giovedì 1 Ottobre 2015
Stampato il 06/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/red-carpet/loscurantismo-la-follia-la-liberta-la-bellezza/