
Alla metà del 1942 la crisi del fronte interno sotto i rovesci delle fortune della guerra e di fronte alle crescenti difficoltà degli approvvigionamenti per la popolazione civile e per l’economia di guerra era ormai potenzialmente aperta. Già il 28 marzo 1942 Ciano aveva registrato nel suo Diario la prima manifestazione per il pane a Venezia; e in quello stesso giorno, quasi a smentire antiche parole d’ordine del regime (l’esaltazione del ruralismo) e il ruolo subalterno deliberatamente accettato nell’alleanza con la Germania nazista nel momento in cui aveva definito la partecipazione italiana alla guerra prevalentemente in termini di fornitura di potenziale demografico, Mussolini nel suo rapporto ai segretari federali dell’Emilia si lasciava andare ad una ammissione tanto tardiva quanto sorprendente: «Noi oggi abbiamo dovuto mettere una remora alla nostra politica contro l’urbanesimo per ragioni evidenti: dobbiamo fare aeroplani, cannoni, mitragliatrici, carri armati, e questa è una guerra di mezzi meccanici, che sarà vinta dagli ingegneri». Le affermazioni di Mussolini erano il frutto di una tardiva resipiscenza sui modi della rovinosa condotta della guerra – e presto la completa disfatta dell’armata italiana in Russia e le ripetute sconfitte in Africa ne avrebbero dato l’irrevocabile conferma – e insieme la risposta ai sintomi di sfaldamento della cristallizzazione dell’equilibrio tra citta e campagna, sul quale il regime si era illuso di ammortizzare le spinte della conflittualità sociale e in tal modo di assicurarsi una stabilità di consensi sufficiente per mantenere l’aggregazione del blocco di potere e del blocco sociale che si erano stretti intorno al fascismo al potere.
Gli sviluppi della guerra furono determinanti per rovesciare questi equilibri al pari della incapacità degli organi di dominazione del potere fascista di conservare il controllo della situazione, certo più della incidenza diretta delle forze antifasciste, la cui lenta aggregazione nella clandestinità non trovava ancora la spinta sufficiente per assumere una iniziativa politica volta decisamente ad abbattere il regime. Fino agli scioperi del marzo del 1943 è indubbio che l’iniziativa rimase al regime fascista; successivamente, essa passò alle componenti conservatrici del blocco di potere e all’ala frondista del fascismo messi in stato d’allarme dal risveglio brusco ma non improvviso delle masse operaie. Prima ancora di far fronte al risveglio operaio, il regime fascista aveva acquisito la consapevolezza dello sgretolamento del consenso dei ceti medi che aveva rappresentato la base principale della sua stabilità sociale. Attraverso le segnalazioni che da ogni parte d’Italia prefetti e autorità di polizia inviavano a Roma (come è stato dimostrato fra l’altro da un ben noto e pionieristico studio condotto da Nicola Gallerano sui materiali dell’ Archivio centrale dello Stato) il regime fascista fu reso avvertito di un duplice sotterraneo processo in atto nella società italiana: da una parte il distacco, anche soltanto per stanchezza, dal regime di consistenti settori della piccola e media borghesia; dall’altra, l’emergere di una forza concorrenziale rispetto al regime che, senza porsi direttamente sul terreno politico, esercitava il peso di tutta la sua autorità morale e sociale: la Chiesa cattolica. Una delle manifestazioni più significative delle inquietudini che incominciavano a minare il regime e le sue basi di massa fu rappresentato dallo sgretolamento interno del partito fascista, diviso tra una componente di abbandono e di vero e proprio distacco ed una componente mirante a rivitalizzarlo, a restituirgli (o a dargli addirittura, a seconda dei punti di vista) un ruolo di centralità, con un equivoco richiamo alle origini, per consentirgli di governare e superare la crisi.

Più che per i suoi riflessi istituzionali, la crisi del partito fascista accelerata dalle crepe del fronte interno e dal clima di crescente sfiducia per le sorti della guerra, è interessante per i fermenti che lasciava intravedere pur in mezzo alle generazioni interamente cresciute sotto il fascismo. Nel tentativo di ridargli autorità e di farne un fattore non più solo burocratico ma propulsivo della vita nazionale, alla fine del 1941 Mussolini attuò uno dei rituali cambi della guardia, portando alla segreteria del PNF un uomo nuovo delle generazioni più giovani, Aldo Vidussoni, con gesto polemico nei confronti del vecchio fascismo, quasi a volere sfidare lo scetticismo serpeggiante e la cautela della vecchia guardia, peraltro largamente screditata dal malcontento diffuso e dai meschini scontri di potere e di personalismi che avevano caratterizzato la vita interna del partito e del regime. Negli elementi giovanili di questa fronda fascista, che tuttavia non è possibile assimilare acriticamente a un nuovo antifascismo tout court – un’avvertenza che deve valere soprattutto oggi, di fronte alla tendenza così diffusa di dimenticare che i «fascisti critici» o addirittura i «fascisti del dissenso» pur sempre fascisti erano e rimanevano – si rifletteva la crisi di una generazione interamente vissuta nel clima fascista che andava in parte aprendosi a esperienze diverse e ad una riflessione autocritica. Ma anche una generazione, il cui compito, quando non si fosse incontrata con le avanguardie dell’antifascismo, non doveva essere facilitato dalla diaspora nella quale si andava disperdendo la fronda del vecchio fascismo: dall’estremismo filonazista di un Farinacci, al frondismo filomonarchico di un Grandi; al frondismo di un Bottai, che propone di abolire l’obbligo di iscrizione al PNF per i pubblici impieghi nell’illusione di «ridare all’iscrizione il suo proprio valore di libero atto associativo»; al comportamento così contraddittorio di un Ciano, antitedesco a parole ma nei fatti fra i primi complici dell’alleanza e comunque legato da una indefettibile fedeltà personale a Mussolini.

Attraverso il convergere centrifugo della crisi del partito fascista verso le diverse posizioni dei suoi singoli esponenti venivano alla luce la fragilità della struttura del partito e la fine della sua capacità di gestire e di mediare le spinte contrastanti che si agitavano nella società e nel Paese. Era l’inizio del processo di franamento del partito fascista che si sarebbe rivelato nello sbandamento definitivo e nella autoliquidazione di fronte al colpo di stato del 25 luglio del 1943. Ancora alla fine del 1942 la spinta alla frattura tra fascismo e spirito pubblico più che dalle forze antifasciste provenne dalle sconfitte militari, dalle difficoltà alimentari, dai bombardamenti aerei che scardinavano la vita delle città, che disgregavano comunità familiari e sconvolgevano ambienti di lavoro, relazioni e abitudini personali. Ma alla periferia del Paese, lungo il confine orientale, era già penetrata la guerra partigiana, come risposta all’aggressione fascista della Jugoslavia e all’annessione della provincia di Lubiana, che fece esplodere la rivolta latente della popolazione slovena della Venezia Giulia sottoposta ad una ventennale politica di snazionalizzazione; non bisogna dimenticare che tra il 1941 e il 1942 il Tribunale speciale per la difesa dello Stato raggiunse il massimo di intensità della sua attività di fronte alle manifestazioni di crescente insofferenza per le condizioni imposte dalla guerra e non solo per episodi di vera e propria sovversione antifascista e che proprio a Trieste, nel dicembre del 1941, il Tribunale speciale aveva pronunciato, in un clima di repressione senza precedenti, altre cinque condanne a morte.
Tutto ciò sta a confermare come di fronte al franamento delle sue possibilità di controllare una situazione sempre più ingovernabile, il regime fascista tentò di usare l’unico strumento che gli rimaneva, quello della repressione, una volta dimostratasi irrecuperabile la perdita di credibilità prodotta dalla pessima condotta della guerra e dalla tangibile disarticolazione di ogni struttura organizzativa dello stato. Consapevole della crisi interna, Mussolini, accentuando l’aspetto personalistico della dittatura, si trovò ad oscillare tra l’uso di strumenti di mediazione politica e il puro e semplice intervento repressivo, che veniva apertamente suggerito dagli alleati tedeschi, i quali del resto non avevano mai perdonato al regime fascista lo spazio di agibilità che esso aveva lasciato soprattutto alla monarchia e alla Chiesa cattolica. Ma come era fallito il tentativo di rivalutare il partito fascista, nel quale si dimostrava irrealizzabile ormai ogni ricambio generazionale, non avrebbe avuto migliore fortuna il «cambio della guardia in grande stile», come lo definì Bottai, con il quale all’inizio di febbraio del 1943 Mussolini tentò con un radicale rimpasto del governo di dare un segnale di maggiore concentrazione di poteri e di maggiore intransigenza verso ogni manifestazione di cedimento. Non può sfuggire che tutto ciò si verificava proprio parallelamente alla capitolazione della VI armata della Wehrmacht a Stalingrado: il rimpasto del gabinetto era destinato quindi a fare fronte alla pesante svolta della guerra, al presumibile inasprimento del distacco tra fronte interno e regime e alla pressione crescente dei nazisti per un irrigidimento terroristico del fascismo italiano. Mussolini si disfece tra gli altri di collaboratori come Ciano (che fu mandato ambasciatore presso la Santa Sede), Bottai, Grandi, Buffarini Guidi, Pavolini, Ricci e si circondò di vecchi fascisti (tra gli altri Acerbo, De Marsico) che davano apparentemente maggiori garanzie di fedeltà al dittatore, alla dittatura e all’alleanza con i nazisti. In questo periodo infatti Hitler non mancò di sottolineare nelle sue lettere a Mussolini il confronto tra i sacrifici cui erano sottoposti i soldati e il popolo tedeschi e la disciplina che si aspettava dagli alleati: un messaggio indiretto ma sufficientemente esplicito nel senso di incoraggiare una nazificazione anche del fascismo italiano.
È noto che questo orientamento della Germania nazista trovò ulteriore accentuazione dopo la crisi sempre più manifesta che la sconfitta di Stalingrado segnalò nel fronte interno italiano e soprattutto dopo gli scioperi del marzo del 1943 nel triangolo industriale dell’Italia del nord. Se il fascismo cercò di contenere la spinta operaia sfociata ora nella protesta di massa con parziali concessioni economiche, di fronte anche al discredito cui furono fatti oggetto responsabili di governo come il ministro Cianetti inviati a placare la protesta popolare, rivelando anche l’impossibilità ormai di ricorrere puramente e semplicemente alla maniera forte, in un estremo tentativo di ricomporre un qualche rapporto di compatibilità tra masse e regime, gli esponenti del regime nazista non apprezzarono per nulla gli sforzi di moderazione del fascismo italiano. E dal loro punto di vista avevano ragioni da vendere, poiché la moderazione di Mussolini e compagni non era una prova di forza e di autorità ma un segno di debolezza e di disorientamento. Per questo l’incontro di Klessheim, presso Salisburgo, dei primi di aprile tra Mussolini e i capi nazisti, l’ultimo incontro con Hitler prima dello sbarco alleato sul territorio italiano, ebbe un’importanza storica: in questa occasione infatti Hitler e Himmler (il quale ben conosceva lo stato della situazione interna italiana) non si limitarono a suggerire a Mussolini di passare alla trasformazione terroristica sul modello tedesco del regime italiano; essi offrirono direttamente a Mussolini i mezzi per realizzare questo obiettivo, vale a dire l’invio di istruttori delle SS per costituire un apparato di repressione e di sicurezza interna senza la cui esistenza – né Hitler né Himmler valutavano la milizia fascista come una forza in qualche misura apprezzabile e i fatti del 25 luglio avrebbero dato loro pienamente ragione – non solo non sarebbe stata possibile la repressione interna ma non sarebbe stata garantita, di conseguenza, neppure l’affidabilità dell’Italia come partner dell’alleanza e della guerra nazista. Storicamente è in questo progetto di nazificazione del fascismo italiano che vengono poste le premesse della Repubblica Sociale neofascista che nascerà dopo l’8 settembre all’ombra dell’occupazione tedesca.

Si incrociavano a questa punto, nella crisi del fronte interno e del regime fascista, i tentativi di salvataggio in extremis compiuti peraltro senza convinzione dallo stesso regime e le pressioni centrifughe in direzione del rovesciamento del fascismo ad opera delle forze antifasciste da una parte e delle componenti del blocco di potere che aveva sostenuto il fascismo dallo altro. Momento di accelerazione e di spinta irrevocabile per l’assunzione di una iniziativa di dissociazione dal fascismo fu senza dubbio alcuno l’ondata degli scioperi del marzo del 1943, la prima dopo vent’anni di dominazione fascista. II risveglio della classe operaia indicava la sua disponibilità per un’azione politica contro la guerra e contro il fascismo, alla quale tuttavia le forze antifasciste non erano ancora preparate, nonostante la partecipazione dei comunisti, l’unica forza politicamente qualificata e determinante, alla preparazione degli scioperi. Lo sciopero rappresentò così un punto di riferimento obbligato per verificare i ritardi di preparazione dell’antifascismo all’interno, ma lo fu anche per collocare in una giusta prospettiva i tentativi di dissociazione dal regime fascista che a partire da quest’epoca si moltiplicarono negli ambienti dell’alta borghesia civile e militare gravitanti intorno alla monarchia. La debolezza del movimento antifascista nel suo complesso fece sì che gli stessi comunisti per segnalare alla monarchia la loro disponibilità ad assecondare un colpo di stato, una sorta di ritorno allo statuto che avesse come protagonista la monarchia, dovessero passare attraverso intermediari moderati, non ultimo dei quali lo stesso Ivanoe Bonomi, che il 2 maggio 1943, ricevuto finalmente da Vittorio Emanuele III, cercò di incoraggiare il sovrano a compiere la duplice operazione di liquidare il fascismo e di sganciare l’Italia dai vincoli dell’alleanza con la Germania.
Dal colloquio con Bonomi il re non trasse la conclusione che lo sbocco della crisi andasse ricercato nella convergenza con l’antifascismo, vuoi per la sua oggettiva debolezza, vuoi per i timori che un troppo spiccato orientamento politico, che non poteva non recare i segni di un rinnovamento profondo della società italiana, avrebbe prima o poi messo definitivamente alle corde anche la monarchia. L’intervento, del resto assai cauto, di Bonomi fu un’ulteriore riprova per il sovrano che bisognasse dare corpo ad una alternativa moderata di fronte al crollo ormai prevedibile a breve scadenza del regime fascista. Gli ambienti militari e della corona non respinsero i contatti con singoli esponenti antifascisti, ma coltivarono tenacemente il progetto di una soluzione moderata che non coinvolgesse movimenti di massa. La monarchia, le forze della grande industria, le gerarchie ecclesiastiche miravano essenzialmente a sbarazzarsi del fascismo prevenendo l’intervento di una soluzione politica in cui la parte di protagonista della classe operaia potesse preludere anche alla rimessa in discussione del più generale equilibrio economico-sociale. La paura delle masse che dominerà il governo Badoglio dopo il 25 luglio 1943, e che porterà ai sanguinosi scontri tra reparti dell’esercito e manifestanti, era emblematica dell’ottica con la quale il sovrano e le forze che sulla monarchia facevano perno per esautorare il fascismo pensavano di fronteggiare la crisi. E non a caso era la stessa ottica che ispirava anche i dissidenti fascisti, in particolare la fronda facente capo a Dino Grandi, che pensavano di liquidare non il fascismo ma semplicemente Mussolini per presentarsi addirittura agli anglo-americani come alternativa e soluzione di ricambio rispetto alla gestione di Mussolini.

La situazione interna della primavera del 1943 – non si dimentichi che il 13 maggio gli ultimi soldati dell’Asse avevano lasciato il suolo africano e che si attendeva ormai l’imminente offensiva degli anglo-americani contro la penisola italiana – fu dominata essenzialmente dalla paura del sovrano, dei militari, della Chiesa, di non riuscire a controllare e gestire la crisi di trapasso determinata dal crollo inevitabile del fascismo. D’altronde il re apparve abbastanza accorto da non rimettersi unicamente nelle mani della fronda fascista: egli optò piuttosto per la soluzione della dittatura militare. Pensava appunto ad un governo autoritario appoggiato essenzialmente ai militari. Fece perciò circolare abilmente il nome del Maresciallo Badoglio, che più tardi cercò anche di assumersi la paternità dell’iniziativa contro il regime, che non incontrava neppure l’ostilità degli antifascisti. Nei confronti di questi ultimi Vittorio Emanuele tenne le porte aperte, senza peraltro deflettere mai da una linea di rigorosa esclusione dell’antifascismo più qualificato da ogni fase determinante e deliberante del lento processo che avrebbe portato al colpo di stato del 25 luglio. Probabilmente non è infondata l’opinione di Bonomi, secondo il quale il re era orientato nei confronti del movimento antifascista in senso molto più ostile di quanto non lo fosse lo stesso Badoglio, il quale forse non avrebbe respinto la presenza nella soluzione della crisi di una componente politica antifascista. In altri termini, l’iniziativa del sovrano, che mirava a salvare essenzialmente la monarchia, non intendeva valorizzare alcun elemento di una piattaforma antifascista che potesse spaventare tedeschi e fascisti.
Se quindi l’azione del sovrano mirava a un superficiale cambio della guardia al vertice, indice sintomatico della predilezione per una soluzione autoritaria mirante a perpetuare una sorta di fascismo senza Mussolini, altre forze legali perseguivano soluzioni altrettanto moderate, ma con altri strumenti e con maggiore lungimiranza. Tale fu certo il tentativo sviluppato dalla Chiesa cattolica attraverso soprattutto l’Azione cattolica di assicurarsi una presenza attiva nel Paese, anche nei centri del maggiore disagio sociale, nel momento della crisi dell’organizzazione statale e politica del regime. Su questo tentativo ha richiamato negli ultimi anni opportunamente l’attenzione la storiografia e di esso sarà certo necessario approfondire tutti gli addentellati per ritrovarvi le premesse del peso che il partito cattolico avrebbe avuto dopo il fascismo nell’Italia del dopoguerra. In questa fase può essere forse ancora prematuro parlare di un tentativo dell’Azione cattolica, l’unica organizzazione di massa legale esistente al di fuori delle organizzazioni ufficiali fasciste, di preparare la successione al regime fascista. Ma è un fatto, che fu notato anche dalla polizia fascista, che sin dalla metà del 1942 l’Azione cattolica era andata sviluppando un’attività politica generale che eccedeva certamente i suoi compiti e le sue finalità istituzionali. Lo aveva segnalato già allora un rapporto della questura di Roma, le cui osservazioni trovano convalida in ricerche di carattere più puntuale, anche se localmente circoscritte, che mettono in evidenza il preciso tentativo di recuperare, nel momento in cui franava il tessuto organizzativo e politico del fascismo sul piano sociale, l’influenza della Chiesa e della dottrina cattolica tra la classe operaia: non fu infatti casuale il moltiplicarsi degli interventi del clero proprio dinanzi ai segni di risveglio della classe operaia evidenziati dagli scioperi del marzo, a cominciare dal discorso agli operai di Pio XII del 13 giugno 1943. Tanto meno casuale doveva essere l’offerta di collaborazione da parte dell’Azione cattolica al governo Badoglio dopo il colpo di stato del 25 luglio, offerta che si collocava in una ben più lontana linea di sganciamento dal fascismo e ormai di successione aperta, secondo quanto documentato da T. Sala.

La pubblicazione nell’ultimo decennio (ndr: questo articolo è del 1983) dei documenti della Santa Sede per il periodo della seconda guerra mondiale consente di sottolineare anche il parallelismo tra queste mosse della gerarchia e dell’Azione cattolica e l’opera della Santa Sede. Questa non solo appare costantemente al corrente dei passi compiuti dall’ambiente militare, dai moderati dell’antifascismo e dagli stessi frondisti fascisti presso il re; ma si fa anche ripetutamente interprete presso gli anglo-americani delle preoccupazioni per la sorte dell’Italia, perorando la causa di un nuovo governo appoggiato alla monarchia. Prima e dopo il 25 luglio 1943 la costante nella linea della Santa Sede fu rappresentata dalla preoccupazione, acuita dalle conseguenze dei bombardamenti aerei alleati, di prevenire la minaccia del comunismo. Sin dalla prima decade di maggio del 1943, uno dei più autorevoli dignitari vaticani, mons. Tardini, così sintetizzava le sue riflessioni sull’opportunità di un intervento della Santa Sede di fronte alla crisi italiana: «… sotto l’aspetto economico e sociale, si aggiungerà tra poco la fame, la desolazione, la miseria generale a causa dei continui e spietati bombardamenti che distruggono case e cose, scompagineranno le comunicazioni e renderanno quasi impossibili i rifornimenti, seminando ovunque morte e rovine». E così incalzava, il 18 agosto 1943 il segretario di stato, cardinale Maglione, in un messaggio al delegato apostolico a Washington: «… stato d’animo del popolo inasprito da questo crudele trattamento, è sempre più favorevole al comunismo, la cui propaganda, fatta da abili agenti, ottiene notevoli risultati. Recenti movimenti, in occasione caduta fascismo, hanno dimostrato che in Italia il comunismo è organizzato e dispone di mezzi economici e di armi …».
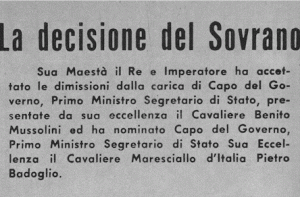 Purtroppo, tuttavia, il movimento antifascista (e spesso nei documenti vaticani l’accentuazione del pericolo comunista tende a coinvolgere in realtà non solo un partito e un’ideologia ma quello che stava diventando un diffuso sentimento antifascista) era in uno stadio di preparazione molto più arretrato di quanto non ritenessero coloro che ne paventavano l’aperto irrompere sulla scena politica. I frutti del patto d’unione antifascista sottoscritto nell’emigrazione a Tolosa sin dall’ottobre del 1941 tra il partito comunista, il partito socialista e il movimento di «Giustizia e Libertà» (che nel luglio del 1942 diede vita al Partito d’azione) si sarebbero prodotti soltanto dopo l’armistizio dell’8 settembre, nella confluenza nella Resistenza armata. II quadro della frammentazione in questa fase delle forze dell’antifascismo non sarebbe completo se non ricordassimo le incertezze della Democrazia cristiana sulla sua stessa natura organizzativa ancora dopo il 25 luglio 1943 e sul non risolto nodo programmatico, a cavallo tra tradizione prefascista e istanze di rinnovamento, oltre ai problemi derivanti dalla fluidità dei rapporti con il mondo cattolico tipica di questa partito. E se non ricordassimo infine anche quella area dell’antifascismo moderato, liberale e conservatore, che non a caso funse da tramite con l’ambiente della corte, interessato a servirsene essenzialmente per ridurre e con tenere la portata dell’antifascismo come movimento di massa.
Purtroppo, tuttavia, il movimento antifascista (e spesso nei documenti vaticani l’accentuazione del pericolo comunista tende a coinvolgere in realtà non solo un partito e un’ideologia ma quello che stava diventando un diffuso sentimento antifascista) era in uno stadio di preparazione molto più arretrato di quanto non ritenessero coloro che ne paventavano l’aperto irrompere sulla scena politica. I frutti del patto d’unione antifascista sottoscritto nell’emigrazione a Tolosa sin dall’ottobre del 1941 tra il partito comunista, il partito socialista e il movimento di «Giustizia e Libertà» (che nel luglio del 1942 diede vita al Partito d’azione) si sarebbero prodotti soltanto dopo l’armistizio dell’8 settembre, nella confluenza nella Resistenza armata. II quadro della frammentazione in questa fase delle forze dell’antifascismo non sarebbe completo se non ricordassimo le incertezze della Democrazia cristiana sulla sua stessa natura organizzativa ancora dopo il 25 luglio 1943 e sul non risolto nodo programmatico, a cavallo tra tradizione prefascista e istanze di rinnovamento, oltre ai problemi derivanti dalla fluidità dei rapporti con il mondo cattolico tipica di questa partito. E se non ricordassimo infine anche quella area dell’antifascismo moderato, liberale e conservatore, che non a caso funse da tramite con l’ambiente della corte, interessato a servirsene essenzialmente per ridurre e con tenere la portata dell’antifascismo come movimento di massa.
Nel loro rifiuto di fare fronte comune con l’antifascismo la corte e le forze che intorno ad essa gravitavano avevano apparentemente recepito la lezione degli scioperi del marzo. Ma il rifiuto di prendere atto dell’indissolubilità dei due momenti – smantellamento del fascismo e lotta contro i tedeschi – che erano impliciti nel movimento di massa degli scioperi comportò il fallimento della stessa politica e strategia del governo Badoglio sino alla disfatta dell’8 settembre, nella medesima misura in cui preparò il terreno per la formazione della piattaforma unitaria dei comitati di liberazione destinati dopo l’8 settembre a guidare la lotta contro i tedeschi e contro la repubblica di Salò.
(da Patria indipendente N° 12/13 del 24 luglio 1983)
Pubblicato giovedì 8 Settembre 2016
Stampato il 05/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/ultime-news/25-luglio-la-crisi-del-1943-le-sconfitte-militari-e-le-difficolta-interne/






