
Diversi anni fa ho intrapreso una lunga serie di interviste alle donne partigiane, per cercare di ricostruire la memoria femminile della Resistenza nel Vicentino. Lo scopo era di restituire a quelle donne verso le quali, io più giovane, nutrivo un profondo sentimento di gratitudine, la specificità del ruolo svolto durante la guerra di Liberazione. Si trattava di rendere il protagonismo che spettava loro e che la storiografia, resistenziale e non, aveva sempre negato, respingendole al focolare domestico da cui si erano allontanate, o strappate a causa degli eventi.
Solo attorno agli Novanta del secolo scorso, grazie in particolare al lavoro di Anna Bravo, la nuova storiografia ha inaugurato un filone di studi capace di accogliere nuovi rapporti e rilevanze tra il genere femminile e quello maschile, e, con un approccio senz’altro suggestivo, ha saputo trasformare i concetti sulla natura e sulle forme della Resistenza.

Finita la guerra, nonostante i sogni di cambiamento di molte donne, l’idea della inconciliabilità tra l’essere femminile e la politica, intesa come scelta civile e di partecipazione, si tradusse in costruzioni simboliche stereotipate che sarebbero durate fino ai nostri giorni.
A dispetto dell’evidenza, pochi protagonisti del tempo sembrarono capaci di vedere nell’agire delle donne qualcosa di diverso dal prolungamento del ruolo di cura e assistenza, dilatato fuori dallo spazio privato della famiglia. La logica conseguenza di questo costrutto ideologico ha sancito un diverso status: la donna che cucinava per i partigiani, curava i feriti in montagna o in casa, portava messaggi di collegamento tra un distaccamento e l’altro, trasportava armi e viveri, era chiamata staffetta. Gli stessi compiti se svolti da un uomo avevano un rilievo diverso: si trattava di un addetto alla sussistenza della formazione, quindi di un partigiano combattente. Le donne che invece avevano accettato la logica della guerriglia armata, imbracciato un fucile, giustiziato le spie, ucciso i nemici, guidato un gruppo di uomini all’assalto, vissuto in montagna nei distaccamenti partigiani, vennero rimosse dal vissuto e dalla memoria, come se quella violenza potesse contaminare la purezza dell’ideale angelico femminile.

Le donne che ho incontrato in questi anni erano, e alcune lo sono tuttora, dotate di un coraggio e di una personalità straordinaria, testimoni di una Resistenza intesa come etica della libertà e della ribellione al sopruso. Ma queste donne erano, soprattutto, custodi, quasi in senso religioso, di una grande sofferenza subita sia fisica che morale, patita e taciuta per lunghi decenni come una vergogna.
Mi piacerebbe pensare che questo silenzio sia stato indotto per difendere le generazioni successive dalle brutture della guerra, invece capisco che quella sofferenza subita, e della quale hanno portato i segni per tutti gli anni a venire, fino a poco tempo fa, non ha un nome.
«Accetti di fare la staffetta – dichiarò Eleonora Candia, era il 1995, a un giornalista – sapendo che se ti prendono ti torturano, ti mettono in galera e possono anche farti fuori con un colpo di pistola alla testa. Ma lo fai lo stesso perché gli ideali superano la paura. E per qualunque ideale che si decide di inseguire arriva sempre il momento in cui bisogna pagare». E molte partigiane pagarono un prezzo altissimo.
 La tortura cominciò ad essere utilizzata a Vicenza sicuramente fin dal luglio 1944 a Palazzo del Littorio sede delle squadre della Federazione prima, della Compagnia della morte poi e infine della Brigata Nera. Il 24 luglio 1944 Elisa Marostegan e Clara Tabia furono picchiate con lo scudiscio, con pugni e calci; le martoriarono con fiammiferi accesi fra i denti e fra le dita dei piedi. «Verso le donne, [è stato usato] il ferro da stiro, qualcuno ebbe la stessa natura scottata e i casi di violenza non sono rari. Oggi stesso la signorina Lovato Anna, da San Quirico di Valdagno, fu seviziata da un ufficiale tedesco e poi portata in carcere».
La tortura cominciò ad essere utilizzata a Vicenza sicuramente fin dal luglio 1944 a Palazzo del Littorio sede delle squadre della Federazione prima, della Compagnia della morte poi e infine della Brigata Nera. Il 24 luglio 1944 Elisa Marostegan e Clara Tabia furono picchiate con lo scudiscio, con pugni e calci; le martoriarono con fiammiferi accesi fra i denti e fra le dita dei piedi. «Verso le donne, [è stato usato] il ferro da stiro, qualcuno ebbe la stessa natura scottata e i casi di violenza non sono rari. Oggi stesso la signorina Lovato Anna, da San Quirico di Valdagno, fu seviziata da un ufficiale tedesco e poi portata in carcere».
Nel settembre del 1944 il procuratore Alfonso Borrelli, con l’aiuto delle perizie mediche del dottor Nello De Megni, riuscì a istruire un procedimento penale contro gli elementi più violenti della brigata nera di Vicenza, che però riuscirono a sottrarsi all’ordine di arresto, trasferendosi in altra città. Nel febbraio 1945, di fronte ad un numero ingente (attorno alle 150 persone) di uomini e donne violentati e seviziati dall’UPI della GNR e dalla banda del maggiore Carità, le indagini del procuratore Borrelli portarono alla raccolta di numerose denunce da parte delle vittime, ognuna delle quali accompagnata dalla perizia medica eseguita sempre dal dr. De Megni, parte delle quali giunsero sul tavolo dello stesso Mussolini.
Nelle diverse sedi, gli interrogatori degli arrestati, partigiani o sospettati di esserlo, venivano condotti usando le peggiori torture: mani, scarponi, bastoni, nerbo di bue, nastro cinese, fiammiferi e sigari accesi, corrente elettrica, violenze e umiliazioni sessuali. Veniva definito “interrogatorio scientifico”:
«Non mi si dette neppure il tempo di parlare – denunciò Olimpia Menegatti, la “mamma” dei partigiani della città, arrestata il 20 dicembre 1944 – che mi si applicarono ai pollici delle mani i fili della macchina a 230 volt e continuarono a torturarmi per più di un’ora, senza poter dire nulla, sia perché non sapevo niente di quello che mi chiedevano sia perché le scosse erano così forti che impedivano di parlare. Vista l’inutilità di ciò, mi fecero spogliare, mi applicarono i fili sulla scapola destra, senza tener conto né della mia età, né del disturbo al cuore che avevo accusato. Poiché io non potevo certo dire delle cose che non sapevo, mi tagliarono i capelli e mi sputarono in faccia continuando a insultarmi e a dirmi parolacce. Infine, mi legarono i fili delle scosse [elettriche] agli alluci, e facendomi stare ritta in piedi mi facevano le scosse, in modo che io continuavo a cadere e a battere il capo in terra. Come chiusura dell’interrogatorio mi diedero un fortissimo ceffone in viso. Trasportata a S. Michele vi giunsi stremata e quasi svenuta, tanto che al corpo di guardia mi misero su di una branda dove rimasi due ore, fino a che ebbi la forza di fare le scale».
La pratica della tortura continuò fin quasi ai giorni della Liberazione ed era talmente connaturata al sistema da essere adottata ovunque esistesse un distaccamento di militari della Rsi o dell’occupante tedesco.

Wilma Marchi (Nadia) e Luigina Castagna (Dolores), partigiane della brigata garibaldina Stella, vennero arrestate l’una il 29 dicembre 1944 e l’altra il 12 gennaio 1945 e nella sede della brigata nera di Valdagno si ritrovarono insieme, con tutte le altre compagne che in quei giorni venivano arrestate in seguito ad una delazione.

«La Wilma l’hanno picchiata così tanto – mi ha raccontato Luigina nell’intervista «che sulla sua pelle non c’era neanche un ago bianco, erano in due. Le hanno tirato su il vestito fin sopra la testa e uno per parte armati di bastone l’hanno picchiata. Eravamo in cella insieme e l’ho vista tornare dopo le botte. […] con la Wilma, la bastonavano fino a quasi a farla crepare dal dolore, ma non la ammazzavano. Lei diceva: “‘Copème’ (Ammazzatemi) almeno per piacere, che sia finita!”. “No, prima di farti morire vogliamo che tu parli”. E allora la smettevano, ti buttavano una secchia di acqua addosso per farti rinvenire. Se penso a quello che hanno fatto alla Wilma mi viene da piangere ancora adesso perché la bontà di quella ragazza era infinita».
Ricorda Rosina Benetti (Oriemma): «Io mi sono preparata e li [i brigatisti] ho seguiti, sono andati a prendere mia sorella [Lidia (Giaira)] e la cugina Cesira [Lolita]. Ci hanno portato a Recoaro in una stanza, poi sono arrivati quelli della brigata nera di Valdagno […] e allora hanno cominciato a picchiarci con un bastone, con le mani, un po’ di tutto… ci prendevano una alla volta e ci portavano in una stanza vicina per interrogarci perché volevano sapere dei partigiani, sempre la solita domanda “dov’erano i partigiani”. Cesira aveva la faccia gonfia dalle botte. Alla sera tardi ci trasferirono a Valdagno a Palazzo Festari e cominciarono gli interrogatori e le torture. […]. A seconda della bugia che dicevamo ci mandavano le scosse elettriche: dovevano tenere in mano dei manici attraverso i quali mandavano la corrente. […] Tutti mi picchiavano con sberle, pugni… Mia sorella Giaira era stata scottata con il ferro da stiro, stirata si dice, e anche se erano venuti a medicarla la mattina dopo, stava molto male».
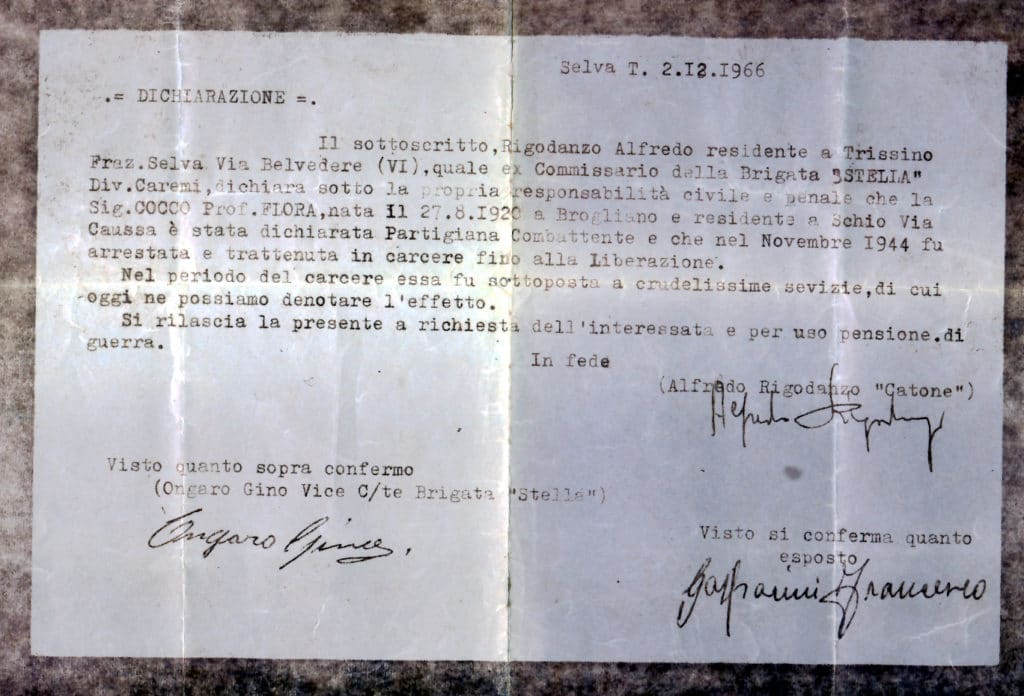
Per le donne che venivano arrestate non c’era molta scelta: o parlare e tradire per sempre i propri compagni, o non parlare, andando incontro alla tortura. All’inizio la decisione di non parlare è scontata, per chi lotta credendo negli ideali della Resistenza con tutta l’anima, ma poiché la soglia del dolore è molto soggettiva, il corpo e la psiche umana hanno limiti molto diversi da una persona all’altra. Il risultato è che moltissime parlano:
«Qualcosa bisogna pur dire» affermerà Maria Gallio, perché la smettano o diano un attimo di tregua al proprio corpo lacerato dalle ferite e dalle botte o sconvolto dalle scosse elettriche o dalle violenze sessuali.
«Bisognerebbe provare gli interrogatori – ha sostenuto con forza Wally Pianegonda, torturata invece a Rovereto –. Quando hai le braccia piene di percosse o di scabbia e negare e avere la spia davanti che continua a dire: “Tu sei stata là al comando perché ti ho vista io, hai portato una volta le sigarette, l’altra gli incartamenti”. E io continuavo a rispondere: “Io non ti ho mai visto, tu sei diventato matto!”. È difficile continuare a negare con una spia davanti, nella stanza degli interrogatori, con tutto quello che c’è dentro, con le botte che piovono da tutte le parti. […] Dalle botte ero ormai impazzita. Al mattino quando sentivo la carceriera con le grosse chiavi che tintinnavano, contavo i passi con il cuore che mi saltava in gola, man mano che aumentavano. Contando i passi, sapevo se toccava a me o a un altro. Io diventavo matta, anche due volte al giorno mi portavano via. […] Uno degli ultimi interrogatori ci portarono tutte insieme nella stanza dove assistemmo all’interrogatorio della mamma: sempre le stesse domande. Cominciarono a picchiarla con violenza. Prima sui piedi le diedero 35 cinghiate: aveva pezzi di carne che si staccavano e più tardi rischiò la cancrena. Erano colpi forti perché il torturatore si era inginocchiato per picchiare più forte. Poi la denudarono e la misero sopra un tavolo e la picchiarono con la cinghia dappertutto, sulla schiena, sulle gambe. Le misero una calza di lana in bocca perché non parlasse: lei continuava a dirci di stare zitte, di non parlare. […] Dopo ci fecero uscire, sentimmo sparare un colpo: “Adesso abbiamo ucciso la vostra mamma, siete contente?”. Ci vennero a dire che nostra madre era morta. Invece per fortuna lo avevano fatto per spaventarci. Fu portata in una cella ancora più fredda, senza pagliericcio per terra e a pane e acqua. E pensare che la neve veniva dentro dalla finestra senza vetri. Appena riuscì ad avere un po’ di forze si fasciò i piedi piagati con la sottoveste».

Molte furono le donne, ma anche gli uomini, resi invalidi fisicamente o deturpati moralmente per le sevizie patite. C’è stato anche chi ha eroicamente resistito, oltre ogni limite umano, salvando i propri compagni. Maria Setti sarà ricoverata all’ospedale psichiatrico di Montecchio Precalcino a causa delle violente percosse e delle continue scosse di corrente elettrica.
“Sostenuta da uno che non conoscevo ritornai alle carceri verso le due di notte – scrive Maria Setti, staffetta del gruppo di Antonio Giuriolo e dei Piccoli Maestri, nella denuncia presentata a Borrelli –. Non potevo camminare. Due persone mi portarono nella cella. Nella notte ho cercato di trascinarmi alla finestra per gettarmi giù. Le ragazze che erano con me si sono accorte. Volevo uccidermi e lo voglio tuttora piuttosto che vedere quella gente. Il giorno dopo ci fu l’ordine di portarmi in una cella scura, sola, con un prete. Non ho più dormito, ero scossa giorno e notte da convulsi, gridavo dalla paura. Avevo la febbre. Mi prepararono, non potendo muovermi, ma dopo del tempo fui rimessa nel mio giaciglio forse per la pietà del carceriere. Non potevo inghiottire neanche l’acqua: avevo forti sforzi di vomito con sputo di sangue. Un dolore al cervello e alla nuca che non capivo nulla. Se non sono morta lo devo forse alle compagne di cella”.
Queste donne subiscono violenza fisica e morale, vengono denudate sotto gli occhi di uomini che sghignazzano, offendono e umiliano.
“Alla prima risposta negativa – scrisse Rina Somaggio, partigiana della divisione Vicenza, nella sua denuncia al procuratore Borrelli – mi fu tolto il vestito e in seguito alle successive negazioni fui con la forza denudata e mi furono tolte anche le mutande a brandelli. Io gridavo perché non volevo essere toccata e il Ten. Di Fusco voleva portarmi sulla strada per essere vista dai passanti. Erano presenti a questo fatto: il Tenente Usai della S.S. italiana iniziatore della vergognosa azione. Marchesi esecutore trionfante dell’ordine […] e altri quattro o cinque che conosco solamente di vista, facevano da spettatori. Il Ten. Usai fece apprezzamenti di ogni genere sulla mia figura. Mi accusò di essere l’amante del Prof. Segato; alla mia ripulsa mi minacciò di prendersi la prova. Con un bastoncino mi percosse il sedere. Mentre stavo in queste condizioni non potevo certo rispondere alle domande che mi venivano rivolte; mi raccontarono sudicie barzellette; con una forbice mi tagliarono i peli nella parte inferiore del pube e con dei fiammiferi si divertivano a bruciarmi gli altri peli, sempre essendo tenuta con la forza. Io cercavo di nascondere con le braccia e le mani le mie nudità e fui minacciata di essere incatenata se non avessi messo le mani dietro la schiena. Il boia Marchesi mi stava sempre vicino con una pompa da auto e mi rivolgeva dei gesti significativi. Poi fui spinta in un angolo in malo modo e vista da tutti, fui oggetto dell’obiettivo fotografico”.
Ho chiesto a molte di loro dove trovassero la forza per affrontare quei momenti. Maria Gallio mi ha risposto: «Trenta giorni a San Michele… la forza me l’hanno data le mie compagne, il mio entusiasmo con cui vivevo i miei anni giovanili pieni di speranze e ideali, la voglia di uscire da un baratro, la speranza che un giorno la causa per la quale lottavamo io e i miei amici vincesse».

Wally e Adriana Pianegonda, al termine dell’intervista, in un unico racconto a due voci mi hanno detto: «Adesso abbiamo raccontato la nostra storia, ma è difficile comunicare quello che noi abbiamo sofferto… entrare nel campo di concentramento di Bolzano ha significato la liberazione, la liberazione da un incubo… eppure mi sentivo sola, completamente sola e costretta a diventare adulta tutto in un momento… avrei voluto essere io l’artefice della mia vita… invece mi sono trovata in balia di esseri mostruosi. Eppure… se dovessi tornare indietro la mia esperienza non la venderei a nessuno… avevo un ideale che mi sosteneva… ho pagato a caro prezzo la fede in un ideale giovanile, ma alla fine mi sono sentita ricca dentro… la libertà che abbiamo conquistato per noi, per le generazioni che sarebbero venute ci ha ripagato di tutta la nostra sofferenza».
Sonia Residori, storica, è dottore di ricerca all’Università di Verona
Il prossimo 25 aprile è prevista l’uscita del suo libro “Sovversive, ribelli e partigiane. Le donne vicentine tra fascismo e resistenza (1922 – 1945)”
Tra i suoi lavori:
Partigiani del Grappa. Il rastrellamento nazifascista del settembre 1944 (2020), graphic novel con il disegnatore F. Simioni.
«Nessuno è rimasto ozioso». La prigionia in Italia durante la Grande Guerra (2019);
L’ultima valle. La Resistenza in val d’Astico e il massacro di Pedescala e Settecà (30 aprile – 2 maggio 1945) (2015);
Una legione in armi. La Tagliamento tra onore, fedeltà e sangue (2013);
Il “Guerrieri giusto” e l “Anima Bella”: l’identità femminile nella Resistenza vicentina (1943-’45) (2008);
Il massacro del Grappa: vittime e carnefici del rastrellamento (21 – 27 settembre 1944) (2007);
Il coraggio dell’altruismo. Spettatori e atrocità collettive nel Vicentino 1943-’45 (2004);
E all’alba venne il gelo. La deportazione di quattro fratelli nei lager nazisti di Antonio Costella(2001);
Donne in guerra. La quotidianità femminile nel Polesine del secondo conflitto mondiale (1996).
Pubblicato lunedì 8 Marzo 2021
Stampato il 04/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/8-marzo-tutto-lanno/lultima-battaglia-delle-donne-partigiane/







