
Carlo Greppi nel suo volume L’antifascismo non serve più a niente ricorda che Piero Calamandrei, poco dopo l’approvazione della Costituzione, aveva dedicato un numero della rivista da lui fondata, Il Ponte, al carcere visto attraverso gli occhi degli antifascisti: decine di deputati e senatori nel ventennio fascista avevano vissuto questa esperienza di dolore e ciò spiegava l’obiettivo della Carta di migliorare il sistema carcerario della neonata Repubblica.
I costituenti, infatti, proprio a seguito della sofferenza subita durante gli anni passati nelle prigioni fasciste hanno scritto parole illuminate sulla funzione della pena, sancendo il divieto di trattamenti inumani. Essi sono andati anche oltre affermandone la finalità rieducativa, la pena doveva cioè mirare al recupero del condannato, al suo reinserimento nella società.

Affrontiamo oggi il tema complesso del carcere nel nostro Paese. Tema che la destra cavalca da sempre, proponendo e/o attuando politiche securitarie che alimentano il populismo penale e lo scollamento tra realtà e percezione nell’opinione pubblica rispetto al tasso di criminalità nel Paese, in diminuzione da diversi anni a fronte di un crescente aumento della popolazione carceraria.
Un dato: alla fine del 2015 i detenuti erano oltre 50.000. All’inizio del 2020 se ne contavano più di 60.000, con l’effetto di aggravare il problema annoso del sovraffollamento carcerario. Soltanto in connessione con l’emergenza sanitaria da Covid si è registrata una diminuzione dei detenuti di diverse migliaia di unità, dovuta al calo dei reati di strada, al rallentamento dell’attività nei tribunali e a misure che ne hanno favorito l’uscita.

La situazione di sovraffollamento nelle carceri italiani è tra le peggiori in Europa e ha già comportato per il nostro Paese una condanna nel 2013 per violazione dell’art.3 della Convenzione Europea dei diritti umani (Cedu), per aver violato cioè il divieto di “trattamenti inumani e degradanti”, restringendo i detenuti in celle con uno spazio personale pari a soli 3 metri quadri ciascuno.
È dello scorso aprile l’ulteriore conferma che le carceri italiane nel 2020 erano tra le più sovraffollate d’Europa. Secondo il rapporto Space del Consiglio d’Europa che fotografa annualmente la situazione dei sistemi penitenziari degli Stati membri, alla fine di gennaio 2020 in Italia c’erano 120 detenuti per ogni 100 posti, dietro solo alla Turchia che faceva registrare 127 carcerati ogni 100 posti.
 È appena il caso di ricordare che nel periodo della prima ondata covid si fingeva di ignorare il problema dell’assoluta impossibilità di adottare le misure di distanziamento nelle carceri, tanto più in quelle caratterizzate da sovraffollamento e che, alla data del 9 dicembre 2020, si registrava un tasso di positività negli istituti penitenziari del Paese pari all’1,96% sul totale della popolazione detenuta rispetto all’1,17% dei positivi sul totale della popolazione italiana.
È appena il caso di ricordare che nel periodo della prima ondata covid si fingeva di ignorare il problema dell’assoluta impossibilità di adottare le misure di distanziamento nelle carceri, tanto più in quelle caratterizzate da sovraffollamento e che, alla data del 9 dicembre 2020, si registrava un tasso di positività negli istituti penitenziari del Paese pari all’1,96% sul totale della popolazione detenuta rispetto all’1,17% dei positivi sul totale della popolazione italiana.
Nel nostro Paese, anche a causa dell’amplificazione mediatica, il divario tra realtà e percezione è sensibile ed è fortemente diffusa nell’opinione pubblica la cultura “forcaiola”, che fa propri gli slogan del genere “alla fine in carcere non ci va nessuno” o “buttiamo via la chiave e lasciamoli marcire in prigione”. Una cultura che vorrebbe il carcere come un luogo di sola afflizione, come vendetta pubblica ma comunque vendetta, in cui si retribuisca il male con altro male possibilmente maggiore. In base al rapporto Censis di fine 2020, quasi la metà degli italiani sarebbe favorevole all’introduzione della pena di morte nel nostro ordinamento.
Ma se è vero che il profilo civile di uno Stato, il livello di democrazia di un Paese si misura proprio in base al grado di tutela della dignità e dei diritti umani fondamentali delle persone che espiano in carcere il reato commesso, da dove e da cosa dobbiamo partire o ripartire?

Lo chiediamo a Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze, già componente di due commissioni di riforma dell’ordinamento penitenziario del ministero della Giustizia e autore, insieme al giornalista Edoardo Vigna, del volume Vendetta pubblica. Il carcere in Italia, pubblicato nel 2020 per Laterza. «Ė proprio dalla Costituzione che dobbiamo ripartire – afferma Bortolato –. Oggi, nel nostro Paese, la pena non può che essere ricondotta alla funzione indicata nell’articolo 27 della Carta, ovvero un’utilità rieducativa intesa in un disegno più grande di reinserimento sociale. I Costituenti hanno avuto una visione ‘lunga’ che andava oltre la contingenza, quella che spesso manca ai politici di oggi. Questo significa, innanzitutto, che per la nostra Costituzione nessuno è irrecuperabile. Nemmeno la pena dell’ergastolo – che tendenzialmente è in contraddizione con il principio rieducativo – può essere esclusa da una finalità di reinserimento sociale».
 A cosa serve o dovrebbe servire la pena nel nostro ordinamento?
A cosa serve o dovrebbe servire la pena nel nostro ordinamento?
Classicamente, nella storia, la pena ha avuto diverse funzioni: quella retributiva – il “male per male” quale unica risposta al reato – quella della prevenzione speciale – per difenderci dal soggetto pericoloso impedendogli di fare del male – quella della deterrenza generale – la pena che spaventa il popolo e lo induce a non delinquere – quella della difesa sociale che è oggi diventata ‘detenzione sociale’ – la pena cioè che ci separa da coloro che non vogliamo vedere, che poi sono quei soggetti che provengono dalle fasce più disagiate della società. La Costituzione, pur non prendendo posizione sulle funzioni storiche della pena, impone che, qualunque funzione possa avere la pena assegnatale dalla legge, essa debba tendere al reinserimento sociale anche perché, prima o poi, le pene finiscono. Ora, l’interesse della società è che il reo non torni a delinquere, questa è l’utilità della pena e tutto dovrebbe essere orientato a questo scopo.

Il sistema carcerario italiano offre questa possibilità?
Il modello attuale basato sulla riabilitazione ha certamente dei limiti, ma è il fondamento culturale dell’ordinamento penitenziario che nasce, ispirato dal principio costituzionale, solo nel 1975. Lo scopo è quello di offrire al condannato il massimo di opportunità per riabilitarsi attraverso gli strumenti del trattamento: il lavoro, l’istruzione, la cultura, i rapporti con la famiglia. Siccome i reati sono causati perlopiù da una deprivazione sociale, bisogna agire sulle cause che li hanno determinati per poter ragionevolmente aspettarsi che la recidiva non si verifichi più. La stragrande maggioranza dei detenuti ha, se va bene, la licenza elementare oppure non ha mai avuto un lavoro. Il problema è che gli strumenti del trattamento sono insufficienti per tutti, solamente una piccolissima parte di questa popolazione carceraria può accedere ai trattamenti e allo strumento principale per l’opera riabilitativa che è il lavoro. Su 54.000 detenuti solo 15.000 lavorano e di questi la maggior parte per un mese all’anno. È con questo che dobbiamo fare i conti.
Lei scrive che il carcere è un luogo violento e “patogeno” non solo dal punto di vista sanitario e parla di “contagio criminale”. Cosa intende con questa espressione?
Si tratta di quella promiscuità che è foriera di nuove alleanze fra detenuti. Spesso in cella, per quanti sforzi si facciano per tenerli separati, si trovano delinquenti con livelli di pericolosità differenti e allora ad esempio un detenuto ‘non primario’, portatore di una cultura criminale più elevata, cerca adepti in galera per insegnare loro come commettere reati più remunerativi. Bisognerebbe prevedere un maggior numero di istituti penitenziari a custodia ‘attenuata’ ed a circuiti fortemente differenziati per rimediare a questo, per evitare cioè che il carcere diventi la principale scuola del crimine.

Stentano ad affermarsi le misure alternative al carcere e i benefici premiali. Potrebbero invece essere applicati anche in un’ottica di “altruismo utilitaristico” per la collettività?
L’immutabilità della pena è il peggior nemico della sicurezza: pena certa deve poter dire solo pena tempestiva, non pena immutabile. Le misure alternative sono proprio quelle che rendono la pena – irrogata dal giudice – ‘flessibile’, che la modificano in senso quantitativo o qualitativo – anche solo temporaneamente (come il permesso-premio) – al fine di consentire un effettivo reinserimento sociale. Attraverso alcuni utili strumenti del trattamento (possibilità di svolgere un lavoro, obbligo di riparare il danno, lavori di utilità pubblica, rientro in famiglia e quant’altro sia ritenuto utile) il condannato espia la pena in forme diverse dal carcere perché si è dimostrato, statistiche alla mano, che chi espia la pena in tutto o in parte in misura alternativa torna a delinquere solo nel 19% dei casi, chi la espia tutta in carcere invece delinque nel 68 % dei casi una volta uscito. La pena, anche per la vittima, deve essere qualcosa di utile, che ripari una ferita, non essere la brutale espressione di una vendetta sociale che crea ulteriori ferite, spesso insanabili. Uno Stato che volesse veramente mettere insieme sicurezza sociale e reinserimento delle persone che finiscono in carcere dovrebbe investire nelle misure alternative e non lasciare, ad esempio, che a occuparsi di carcere nel sistema giudiziario italiano vi sia solo una sparuta compagine di poco più di 200 magistrati di sorveglianza, senza mezzi e con uffici al collasso.
 Da anni, negli ambienti più illuminati, si discute sul diritto, per i detenuti, all’affettività. Ė un tema affrontato nel suo libro.
Da anni, negli ambienti più illuminati, si discute sul diritto, per i detenuti, all’affettività. Ė un tema affrontato nel suo libro.
Esprimere una detenzione che sia solamente una privazione dei diritti fondamentali non consente al condannato di uscire dal carcere, come tutti noi vorremmo, diverso da come vi è entrato. Non è utile a nessuno un carcere che sia solo una ‘vendetta pubblica’: questo è il senso del titolo che io e Edoardo Vigna abbiamo voluto dare al nostro libro. In questa prospettiva uno spazio fondamentale dovrebbe avere il diritto all’affettività. Quando una persona entra in carcere, lascia dietro di sé degli affetti, dei figli, una compagna o un compagno, ulteriori vittime innocenti del reato che ha commesso. Non consentire ai detenuti di esercitare compiutamente il proprio diritto all’affettività, che comprende ma non esaurisce anche quella alla sessualità, è una violenza gratuita. La persona è isolata per sempre e la mancanza di questa dimensione ha l’effetto di consolidare un’esclusione che non farà che peggiorare il suo stato. Il deserto affettivo che caratterizza la quasi totalità dei detenuti è foriero di recidiva perché incattivisce l’uomo, privandolo di un suo diritto fondamentale, che non ha nulla a che vedere con la legittima privazione della libertà personale, e impedisce di alleviare le inevitabili tensioni carcerarie. Ė ora che si affronti questo tema, il sesso in carcere non può continuare ad essere un tabù. L’affettività è una dimensione naturale dell’essere umano e fa parte del concetto di dignità sociale che l’art. 3 della Costituzione garantisce a tutti, anche ai delinquenti, in quanto cittadini. Nel resto dell’Europa non è così. In Spagna e nei Paesi del Nord Europa al detenuto è consentito intrattenere relazioni affettive e sessuali all’interno del carcere, sottratto al controllo visivo degli agenti, con buona pace della morale e soprattutto della sicurezza.

Qual è il suo pensiero sull’ergastolo ostativo? Il giudice Gian Carlo Caselli ha espresso netta contrarietà alla concessione della libertà condizionale ai condannati non pentiti, perché rischierebbe di crollare tutta l’architettura antimafia.
È difficile condensare in poche parole una questione molto complessa. L’ergastolo ostativo è in netta contrapposizione sia al principio di umanità sia al principio rieducativo, tanto da spingere prima la Cedu e poi la Corte Costituzionale a dichiararlo illegittimo con la sentenza n. 253 del 2019 e con la recente ordinanza n. 97 dell’aprile scorso. Anche qui il punto di partenza è che nessuna persona è irrecuperabile o quanto meno deve esserle data la possibilità di dimostrarlo nei fatti con comportamenti da cui potersi desumere quel sicuro ravvedimento che è il presupposto della liberazione condizionale, cioè una misura che, dopo 26 anni di ininterrotta espiazione, può portare all’estinzione dell’ergastolo. Ora, questo ravvedimento – dice la Corte – non può essere legato necessariamente alla collaborazione con la giustizia poiché le ragioni di una mancata collaborazione possono essere altre e diverse dal fatto di essere ancora ‘intraneo’ all’associazione mafiosa. Lo Stato, in un’ottica utilitaristica di politica criminale, chiede al condannato di svelare aspetti della criminalità ancora poco noti in cambio di benefici e dunque questi vive una scelta drammatica che contrappone la sua libertà a quella degli altri. Dal punto di vista morale la pretesa della collaborazione con la giustizia è qualcosa che stride con i principi classici dell’etica e della libertà. Ciò non toglie che lo strumento della collaborazione, in un periodo emergenziale come quello degli anni 90, abbia consentito di conseguire risultati importanti in tema di lotta alla mafia. Peraltro la legislazione speciale sui ‘pentiti’ di mafia’ resta in vigore ancora oggi e non viene minimamente messa in discussione, mentre forme destinate a finire con la morte del detenuto sono intrinsecamente in contrapposizione con l’articolo 27 della nostra Costituzione cui va ricondotta anche la pena perpetua per i mafiosi. Tuttavia la questione è stata per il momento ‘congelata’ dalla Corte che l’ha rimessa al legislatore. Io penso che a fronte di un sicuro ravvedimento, possibile per chiunque, non possa mai essere negata la speranza di accedere alla liberazione condizionale la cui esistenza nel nostro ordinamento, tra l’altro, è l’unica dimostrazione, per la Corte stessa, che la pena perpetua in astratto è di per sé rieducativa. Se il legislatore sarà in grado di ricondurre la questione in termini più coerenti con la Costituzione, il problema si supererà ma vedo che già le prime proposte avanzate in merito vanno in senso nettamente contrario. La speranza e la fiducia che la stessa saggezza che ha mosso la Corte possa assistere anche il Parlamento non devono comunque mai venire meno.
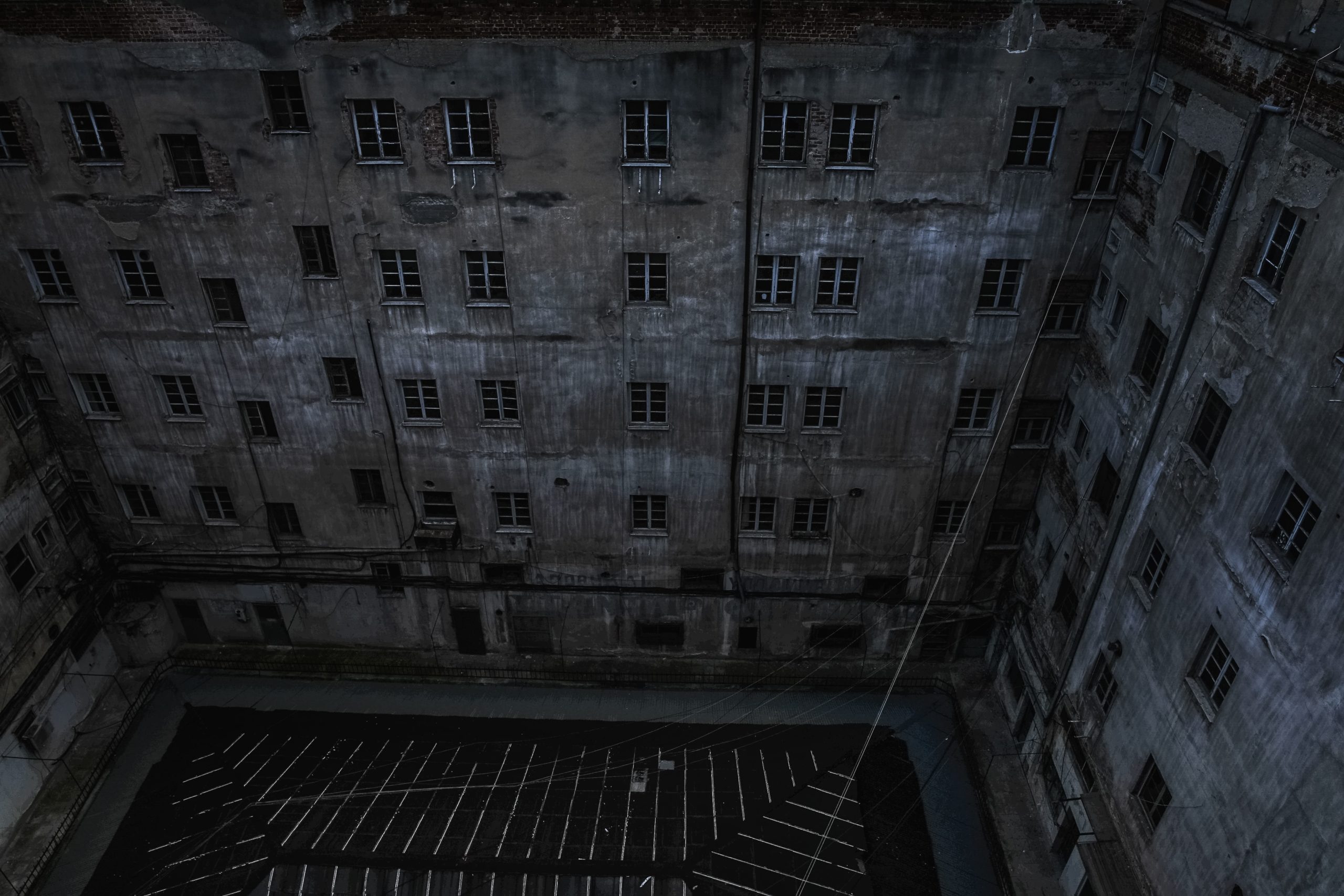
Ė realistico proporre il paradigma della “giustizia riparativa” al posto di quella “rieducatica”, “un progetto” invece che una “pena detentiva” non solo per i minorenni? Quale può essere, a suo avviso, il futuro in concreto di questo istituto nell’ordinamento penale italiano?
Il nostro libro si conclude con un capitolo che parla della giustizia riparativa come passaggio ulteriore rispetto al modello rieducativo. È un paradigma di giustizia alternativa o, se si vuole, complementare, a quello classico, per il quale si ipotizza che la risposta al reato non debba solamente essere detentiva e cioè il carcere. Il reato non può essere considerato solamente come una conseguenza della violazione di una norma astratta, ma deve essere concepito come una ferita, una lacerazione sociale. E come si può porre rimedio a questa lacerazione? I processi di mediazione tra vittima e colpevole ad esempio, oppure le opere di riconciliazione sociale fatte in Sudafrica dopo l’apartheid, in cui lo Stato rinuncia in tutto o in parte alla sua pretesa punitiva purché il condannato sia sollecitato, su un presupposto di verità, a realizzare forme di riparazione che possono spaziare dalle scuse formali al risarcimento del danno, oppure a forme di lavoro gratuito a favore della collettività. In quella esperienza, il colpevole doveva ammettere il proprio reato e anche confessarne altri non scoperti, e si trattava di reati comuni ancorché motivati da odio razziale e non solo ‘politici’, e ciò apriva la strada alla riconciliazione pubblica e privata. Un grande esempio: quando uscì dal carcere Mandela disse “pace” e non “guerra”. Questo, ovviamente, non è un paradigma applicabile a tutti i tipi di reato e a tutti i livelli di pericolosità, ma sicuramente è uno sguardo possibile che va lanciato nel tentativo di superare lo stato attuale, quello di una giustizia che per buone o cattive ragioni alla fine lascia sempre tutti insoddisfatti.
Maria Cristina Paoletti, presidente sezione Anpi di Mestre “Erminio Ferretto” e membro dell’associazione Giuristi Democratici – Venezia
Pubblicato giovedì 24 Giugno 2021
Stampato il 15/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/primo-piano/carceri-non-reprimere-ma-aiutare-a-reinserire/







