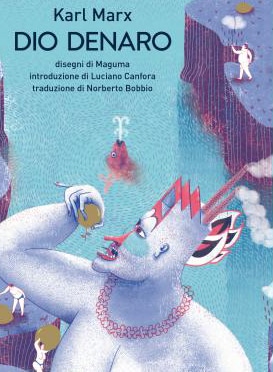L’amico fucilato è un libretto di piccolo formato che contiene quattro racconti scritti da Silvio Villa immediatamente dopo il termine del conflitto mondiale e pubblicati per la prima volta tra il 1919 e il 1922. Ma chi era costui? Non uno scrittore professionista né un tale che lo diventerà in futuro (di lui si rintracciano solo tre pubblicazioni tra il 1919 e il 1927), ma neppure un quasi anonimo testimone di qualche evento della Grande Guerra che volle consegnare alla carta l’urgenza di un racconto per consentire alla coscienza di mettere ordine al tumulto dei ricordi o per trovare nella scrittura un antidoto all’irrequietezza dello spirito.
L’amico fucilato è un libretto di piccolo formato che contiene quattro racconti scritti da Silvio Villa immediatamente dopo il termine del conflitto mondiale e pubblicati per la prima volta tra il 1919 e il 1922. Ma chi era costui? Non uno scrittore professionista né un tale che lo diventerà in futuro (di lui si rintracciano solo tre pubblicazioni tra il 1919 e il 1927), ma neppure un quasi anonimo testimone di qualche evento della Grande Guerra che volle consegnare alla carta l’urgenza di un racconto per consentire alla coscienza di mettere ordine al tumulto dei ricordi o per trovare nella scrittura un antidoto all’irrequietezza dello spirito.
No, Silvio Villa fu qualcosa d’altro. Innanzitutto scrisse in lingua inglese, probabilmente seduto – possiamo immaginarcelo – nel lussuoso studio di una qualche sua proprietà, attorniato da dipinti e oggetti di valore, una bella scrivania in legno intarsiato e abat-jour coi paralumi di seta gialla. Nato nel 1882 a Villanova d’Asti, l’ingegnere Silvio Villa, prima e dopo la guerra, visse negli Stati Uniti, dove si era stabilito nel 1906 seguendo il fratello maggiore Alfonso Pietro. Negli States fu dapprima nel New Jersey per far suoi i meccanismi industriali della produzione della seta e frequentare una scuola serale di business administration, e più tardi si stabilì a New York come vicepresidente della A.P. Villa & Bros. con sede al 95 di Madison Avenue. Silvio Villa, in poche parole, era un uomo ricco, molto ricco, un capitano d’industria che di mattina lasciava un appartamento di Manhattan al 247 di Fifth Avenue per comparire, la sera, tra i “più bei nomi della gioventù dorata di New York” riunita a cena.
A seguire la girandola di ambienti frequentati dai Villa – così scrupolosamente riportati da Francesco Pacifico nella postfazione al libro – si ha l’impressione di leggere la vita e le opere di un Jay Gatsby giunto dal vecchio continente per cogliere nella Grande Mela il profumo del successo. “Nell’ottobre del 1917, entrambi i fratelli figuravano nell’elenco delle 298 persone che a New York erano proprietarie di beni immobili per un valore superiore ai centomila dollari (pari a qualcosa come sette milioni e mezzo di dollari odierni)” e dieci anni più tardi, nei ruggenti anni del jazz cantati da Francis Scott Fitzgerald, i nostrani magnati della seta risultavano gli italoamericani di New York che pagavano la più alta income tax (ovvero la più salata tassa sul reddito delle persone fisiche).
Un vero e proprio pezzo grosso, socio della Silk Association of America, patrocinatore della Italian Emigrants Association, amico del tenore Enrico Caruso, Silvio Villa partecipava a balli, pranzi, aperitivi, parties, lo si trovava alle prime del Metropolitan e alle inaugurazioni dei più grandi transatlantici varati nelle acque della Upper New York Bay. Insomma, una vita prestigiosa, fatta di agi e di lussi, interrotti solamente da quei due anni di richiamo alle armi, dall’autunno del 1916 alla fine delle ostilità, che trascorse come ufficiale del Genio sul fronte orientale.
Con un background di questo tipo è facile cader preda di meschini pregiudizi; ci si attende il ritratto di un uomo spregiudicato pronto a far leva sul proprio prestigio per occupare, anche nel frangente della guerra, un posto di privilegio nel cuore della sofferenza. E invece le pagine belliche di Villa risultano delicate, malinconiche, a tratti dimesse (in contrasto, a quanto pare – ma io non ho potuto averla tra le mani – con l’elegante edizione stampata privatamente nel 1919 a cura dell’editore Brentano’s di New York) e le esperienze che la voce narrante rievoca in prima persona (sebbene nei panni di un certo Carletto) sono lo specchio di una profonda umiltà del sentire e di un onesto senso del dovere nei confronti della patria.
I racconti – s’è detto – sono quattro, e i primi tre (La linea, La fine di un giorno perfetto, La tentazione), a dire il vero, sono poco più che bozzetti tratteggianti aspetti minimi della vita al fronte attraverso annotazioni paesaggistiche, stralci di dialogo e riflessioni sul senso di ciò che avviene agli animi umani (in senso universale e ungarettiano), nel cuore della lotta o durante le lunghe gestazioni dei tempi morti in cui è fin troppo facile, per il soldato, soppesare sogni e malinconie di antichi amori o di lontane speranze.
Si sente, in Villa – ancorché in una veste semplificata – quella premura che fu in molti artisti partecipanti al Primo conflitto mondiale, in specie quelli che non vi aderirono con la dannata ostinazione dei nazionalisti. Mi viene in mente, in questo senso, il Baldini di Nostro Purgatorio (autore e opera troppo spesso dimenticati), le sue vedute aeree, il lavorìo, l’astrazione dall’immediatezza del reale contemplato, invece, dall’alto, adottando una vera e propria poetica della lontananza come condizione necessaria per tracciare linee nitide attorno al profilo dell’uomo. La prosa di Villa sa di questo, sa di pudore che non svela tutta intera la ripugnante realtà della guerra e, a un tempo, non tace quello che c’è da dire, ovvero “la più grande passione mai provata da esseri umani”, rivendicando per sé, nonostante la distanza – spesso anche fisica – tra il soggetto narrante e la trincea, il diritto a narrare e a rinominare, come un novello Adamo, le affezioni della vita, a partire dalla dicotomia amore-odio:
Là, davanti a me, a quattro miglia, si trovava il limite fatale, oltre il quale la legge di Cristo non si applicava! Noi eravamo da questa parte, e dall’altra c’era il “nemico”. Nostro compito e dovere era sterminarlo, annichilirlo, e ridurre alla fame le sue donne e i suoi figli. Niente amore per loro, solo tanto odio!
Odio! Mi ripetei quella parola, cercando di suscitare i sentimenti che le corrispondevano, ma fui stupito di non esserne capace.
La fine di un giorno perfetto prende le mosse da un episodio quasi modesto e famigliare (se inserito nella parabola di guerra), una gara di lancio di bombe a mano tra due fanterie, vissuta dai soldati come festa e occasione per praticare un “bello sport”, se non che, “ogni tanto, qualcuno sbagliava il lancio e la bomba scoppiava in campo aperto, ferendo qualcuno”. Ma a un tratto due aeroplani nemici iniziano a scendere innescando l’agitazione nei ‘giocatori’. Giunti a mille piedi, i velivoli subiscono il fuoco delle mitragliatrici italiane, ma invano; dal ventre degli aerei vengono sganciate delle bombe che cadono troppo lontano, finché da un angolo di cielo non sbuca fuori “un piccolo monoplano dei nostri” che colpisce con successo uno degli apparecchi nemici che precipita. Ed ecco di nuovo la pietas del soldato impadronirsi del narratore:
Doveva morire lì, senza nessuno intorno a sé se non soldati nemici, che lo guardavano morire allo stesso modo in cui si guarda un cane rabbioso in agonia. Benché fosse un austriaco, mi dispiaceva per lui.
Un afflato di compassione che invischia gli accorsi al capezzale di rottami mentre sopra le loro teste, come avvoltoi, “i compagni del morto volavano in cerchio tra bianchi sbuffi di fumo”. Gli italiani dicono una preghiera, “una di quelle rudi preghiere abruzzesi imbevute dello spirito mistico di quella terra ove la memoria dei santi è ancora viva”.
Nel terzo racconto, La tentazione, troviamo il narratore impegnato al servizio dei riflettori prima sul Carso, poi in Val d’Astico, sulle Alpi venete, un incarico dagli esiti fantozziani, se non che quella è la vita vera: “L’unico danno accertato che arrecammo al nemico consistette nel causare la morte di una delle loro mule, che una notte venne abbagliata dal nostro fascio di luce e, inciampando, precipitò in un burrone”.
Un compito che il narratore e il compagno d’armi svolgono con zelo e precisione, come monaci del deserto, quello dell’anima – verrebbe da dire – sulle pendici aspre dei monti, lontano dalla civiltà. Così la cittadina di Vicenza (il più vicino centro urbano) cambia quasi in miraggio, “esercitava sulla mia fantasia un fascino pari a quello di Parigi, di Roma, del Cairo o di qualsiasi meravigliosa città di sogno”. Ecco dunque la prima tentazione. Ma non l’unica né la più straziante. Sceso nella cuna del Palladio, il narratore finisce tra gli artigli di un’altra tentazione, più sottile, più passionale che prende le sembianze muliebri di Donna Clara, moglie di un colonnello di cui è ospite a cena, che finisce per parlargli di un’altra donna, un vecchio e lontano amore romano, col quale lei potrebbe rimetterlo in contatto. Ma alla fine Carletto sa che rimarrà al proprio posto, forte di un amore per le cose ben fatte e di un patriottico senso del dovere che è lo stesso che anima le pagine dell’ultimo e più importante racconto, Claudio Graziani (nell’originale statunitense del 1919 sottotitolato An Episode of War) che è però il primo esperimento letterario di Villa. La pagina si apre con l’urgenza della testimonianza:
Chiunque abbia avuto una parte, per quanto piccola, in una qualche sconosciuta tragedia, ne porta con sé tutto il peso, ed è sempre ossessionato, senza rendersene conto, dal desiderio di farla conoscere […]. Non gli serve sapere come si racconta o come si scrive. È il racconto in sé quello che verrà dalle sue labbra.
Con una dichiarazione d’intenti che lo porrebbe al di qua di ogni pretesa artistica (quando in vero la prosa svela qua e là un grazioso estro), il racconto fa riemergere dalle nebbie del ricordo la figura di un ragazzo alto e biondo, bello come un dio, fratello piccolo di un intimo amico del narratore; il solito Carletto (così nell’edizione definitiva del ’22, in cui Claudio Graziani diventa il XXIII capitolo del volume The Unbidden Guest; mentre nel 1919 uno spirito d’autobiografismo più marcato lasciava al narratore il nome di Silvio) che coi suoi uomini si trova, questa volta, a Edolo, in Val Camonica, e qui, dopo anni, ritrova quell’antico bambino trasformato in capitano degli Arditi, “una profonda ferita sopra l’occhio sinistro, e sul petto tre nastri azzurri, ciascuno con la stella d’argento”.
Il ritratto dell’eroe, uno di quelli che si sarebbe potuto leggere nei romanzi d’appendice, la cui serena asprezza marca meravigliosamente la metamorfosi di quanto ancora albergava nella memoria di Carletto: “Lui rise: «Non ti piace il sapore del sangue austriaco sul pane, vero?»
Quella battuta così brutale mi impressionò. Ripensai al ragazzo biondo che, in una nuvola di boccioli rosa, alzava la testa verso sua madre che lo chiamava dall’alto. Non riuscivo a connettere quell’immagine con quell’uomo così solido davanti a me, ricoperto di medaglie e di cicatrici, che mi porgeva un pugnale col quale aveva ucciso i suoi nemici”.

(ANSA/S&M Studio)
I due uomini seduti di fronte nella stanza fumosa di un rifugio montano si raccontano la loro guerra personale. È soprattutto Claudio ad aver molto da dire, le azioni feroci, l’audacia, il coraggio, la tensione. Graffianti le parole dedicate a Caporetto, il fronte sfondato, il nemico che avanza implacabile: “Era come se d’improvviso, mentre stavi con la tua ragazza tutto raccolto in quell’amore per lei, una mano, alle tue spalle, le avesse sfigurato il volto con un coltello”.
E così, tra un dialogo e l’altro, il racconto caracolla all’epilogo tragico: la richiesta da parte di un colonnello inesperto di portare gli Arditi a compiere un’impresa suicida, il rifiuto di Claudio Graziani, l’insubordinazione, l’arresto e la fucilazione. E, va detto, Silvio Villa non sarà l’unico a testimoniare gli abusi perpetrati dai comandi superiori con esecuzioni sommarie; ma ciò che meraviglia, come sottolinea Francesco Durante nella Postfazione, è la tempestività con cui la denuncia arriva: siamo infatti nel 1919, l’anno che vedrà le prime inchieste giornalistiche su Caporetto pubblicate dal quotidiano socialista l’Avanti!, sul caso del generale Andrea Graziani, che proprio durante la disfatta italiana si macchiò di decine di fucilazioni, l’anno in cui, per farla breve, venne abolita la censura postale e giornalistica in vigore dal 23 maggio 1915 e in cui si accedeva per la prima volta ai dati raccolti dalle commissioni d’inchiesta sulle azioni militari italiane.
Un tempismo che sbalza il racconto di Villa al di qua delle altre e – certamente – più celebri e letterariamente riuscite testimonianze dei soprusi subiti da parte degli alti comandi militari (siamo due anni prima del racconto La paura di Federico de Roberto, e diciannove prima dell’Emilio Lussu di Un anno sull’altipiano e del suo recalcitrante tenente Ottolenghi), ma un tempismo che, proprio perché così prossimo agli eventi, nasconde forse sotto l’eco sinistra di quel nome – Graziani – il volto non di un personaggio fittizio ma di un uomo vero, un compagno d’armi, un biondo ragazzo di cui forse mai nessuno potrà conoscere la vera identità.
Giacomo Verri, scrittore
Pubblicato venerdì 6 Marzo 2020
Stampato il 18/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/della-morte-e-della-compassione/