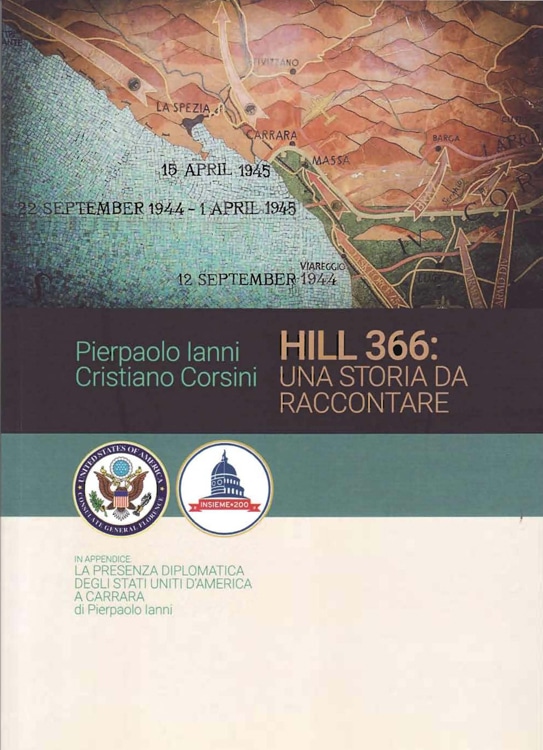Titolo spiazzante, nel quale tre parole “nazista”, “salvò” ed “ebrei” stridono fra loro. Soprattutto è quel ‘salvò’ che proprio non ci aspettiamo tra quel ‘nazista’ e quegli ‘ebrei’ mentre dalla sobria copertina in bianco e nero proprio lui ci guarda, il protagonista, con la calma pacata – il completo e la cravatta scura sulla candida camicia, gli occhiali e la matita, lo sguardo tranquillo e fermo – di un professore, uno studioso, forse un luminare della medicina. E invece no. Lui è Georg Ferdinad Duckwitz, il ‘nazista’, appunto. Il nazista che salvò gli ebrei di Danimarca. L’unico. Storia eccezionale, la sua, che lo scrittore e studioso Andrea Vitello raccoglie tra le righe di una conferenza di Claudio Fava che ascolta negli anni dell’università: ”Il tema centrale era quello della lotta alla mafia, mostrato attraverso la vita di Peppino Impastato. Il messaggio che affiorava dalle parole dell’oratore era in particolare uno: ci si può sempre opporre a un potere, anche quando questo sembra invincibile”. Tra gli altri, Fava cita la storia dei danesi che salvano i loro concittadini ebrei dalla deportazione, non abbandonandoli al loro destino, come invece stavano facendo tutti gli altri in Europa, e l’interesse dell’autore si fa via via più forte, fino a parlarne con Moni Ovadia, che gli consiglia la ricerca tra i Giusti delle Nazioni e lo presenta a Gabriele Nissim, presidente di Gariwo la ‘foresta dei Giusti’.
Titolo spiazzante, nel quale tre parole “nazista”, “salvò” ed “ebrei” stridono fra loro. Soprattutto è quel ‘salvò’ che proprio non ci aspettiamo tra quel ‘nazista’ e quegli ‘ebrei’ mentre dalla sobria copertina in bianco e nero proprio lui ci guarda, il protagonista, con la calma pacata – il completo e la cravatta scura sulla candida camicia, gli occhiali e la matita, lo sguardo tranquillo e fermo – di un professore, uno studioso, forse un luminare della medicina. E invece no. Lui è Georg Ferdinad Duckwitz, il ‘nazista’, appunto. Il nazista che salvò gli ebrei di Danimarca. L’unico. Storia eccezionale, la sua, che lo scrittore e studioso Andrea Vitello raccoglie tra le righe di una conferenza di Claudio Fava che ascolta negli anni dell’università: ”Il tema centrale era quello della lotta alla mafia, mostrato attraverso la vita di Peppino Impastato. Il messaggio che affiorava dalle parole dell’oratore era in particolare uno: ci si può sempre opporre a un potere, anche quando questo sembra invincibile”. Tra gli altri, Fava cita la storia dei danesi che salvano i loro concittadini ebrei dalla deportazione, non abbandonandoli al loro destino, come invece stavano facendo tutti gli altri in Europa, e l’interesse dell’autore si fa via via più forte, fino a parlarne con Moni Ovadia, che gli consiglia la ricerca tra i Giusti delle Nazioni e lo presenta a Gabriele Nissim, presidente di Gariwo la ‘foresta dei Giusti’.

“Fu la dritta fondamentale”, ricorda Andrea Vitello, perché dalle ricerche in tal senso emerge subito come Duckwitz sia stato l’unico nazista insignito nel 1971 dallo Yad Vashem del titolo di ‘Giusto tra le Nazioni’, onorificenza che dal 1962 è concessa ai non ebrei riconosciuti come ‘giusti’ e rispettosi di Dio. Una storia che andava raccontata, quindi, perché, oltre all’eccezionalità del ‘caso’ Duckwitz, porta alla luce la forza di un’intera collettività, il popolo danese, che si rifiuta di obbedire alla Germania, che impone la deportazione dei cittadini di religione ebraica, senza temere per il proprio destino. “Ad assumersi ogni rischio dell’opposizione al moloch nazifascista fu la soverchia maggioranza dei danesi, dal Re al più umile dei cittadini”, così Moni Ovadia nella prefazione che aggiunge: “I danesi consideravano il rifiuto del razzismo, la democrazia e l’uguaglianza dei cittadini un carattere nazionale della Danimarca, (…) un elemento intrinseco dell’identità del popolo e di tutti i suoi cittadini, senza distinzioni. (…) Questo volume dovrebbe essere letto da tutti coloro che respingono l’idea di odio dell’uomo contro il suo simile, chiunque egli sia”.

L’opera, poderosa nelle sue quasi 200 pagine, risulta interessante da molteplici punti di vista. Innanzitutto si legge con impressionante velocità, quasi some un romanzo d’avventura, nonostante l’argomento trattato sia storicamente complesso e a tratti drammatico. Questo grazie alla fluidità stilistica dell’autore che, attento alle fonti storiche e storiografiche, sa descrivere la complessità del momento con pacata determinazione. La narrazione si dipana ordinatamente attraverso cinque punti fondamentali, spesso arricchiti da appendici fotografiche capaci di creare forti connessioni emotive: l’inquadramento storico, cui dedica il capitolo I, ‘La Danimarca prima e durante l’occupazione’; le singole vicende umane, spesso tragiche, dei cittadini danesi che organizzarono fattivamente il trasporto via mare di quasi 8.000 ebrei danesi verso la sicura Svezia nel capitolo II ‘Il salvataggio degli ebrei in Danimarca’; quindi nel capitolo successivo il dovuto omaggio a quanti, circa 460, non riuscirono a fuggire e vennero deportati a ‘Theresienstadt’ (qui le immagini a corredo ci fanno annegare nell’orrore e nelle ambiguità di un campo di sterminio reso ‘unico’ dalla propaganda nazista)cui fanno seguito la cronaca de ‘La liberazione della Danimarca e il ritorno degli ebrei, capitolo IV, e l’illuminato ‘La normalità del bene’, il capitolo finale con cui l’autore chiude, con l’evidente omaggio ad Hannah Arendt, la sua appassionata narrazione storica.

Cinque sezioni che portano il lettore ad addentrarsi nei fatti di Danimarca dal 1933 al 1945, dalla ‘calma apparente’ di un’Europa che non ha ancora compreso appieno la potenza letale del pensiero nazista e che, purtroppo, lo lascia libero di agire ed espandersi, alla fine dell’incubo e a quel 9 maggio 1945 in cui Re Cristiano X — il sovrano che leggenda vuole portasse la stella gialla di David sull’uniforme durante le passeggiate a cavallo per le vie di Copenaghen — riapre il parlamento, simbolo della ritornata democrazia nel Paese.
Due, quindi, le direttrici di questo preciso e coinvolgente lavoro: la coesione di un popolo che, tranne sparute minoranze filonaziste, testimonia con fatti concreti la sua ferma intolleranza all’antisemitismo e la vicenda storica e umana di Georg Ferdinad Duckwitz che, inviato dal Reich all’ambasciata tedesca a Copenaghen, si spese in ogni modo nell’organizzare il salvataggio dei danesi di religione ebraica verso la Svezia.
Nel 1940 la Danimarca aveva accettato la ‘protezione’ tedesca, il Re aveva trattato la resa purché la capitale non venisse distrutta, ma era riuscita a restare neutrale nel conflitto e a mantenere fermi i propri confini territoriali: qui non vengono attuate le Leggi di Norimberga, nonostante la pressioni tedesche, e la popolazione, man mano che la guerra procedeva, dimostrava coraggiosamente il suo sdegno: ”Nel gennaio del 1943, durante un Festival studentesco a Gislev, gli studenti danesi invitarono tutti i presenti a partecipare al canto di due inni nazionali che stavano a cuore ai danesi. I tedeschi presenti non si meravigliarono di sentire l’inno di Danimarca, ma provarono grande disappunto quando partì il secondo: non era, come presumevano, quello tedesco. Gli studenti sventolavano le bandiere con la stella di David e cantavano Hatikvah, ovvero l’inno nazionale sionista”. Andrea Vitello sa come interessare il lettore. L’immagine delle bandiere ebraiche che sventolano sulle teste attonite dei nazisti è di grande forza empatica, quasi un ossimoro estetico con le tanto attese croci uncinate. È in questo clima di solidarietà e antisemitismo che il governo danese riceve, e respinge, l’ultimatum tedesco del 28 agosto 1943 che imponeva lo stato di emergenza alla nazione. Ciò sancisce la fine della cooperazione pacifica tra i due Stati e mentre il generale Hermann von Hannecken impone la legge marziale e il disarmo delle forze locali ancora in servizio, il plenipotenziario del Reich, l’SS Werner Best, chiede rinforzi a Berlino per procedere alla cattura e alla deportazione degli ebrei danesi nei campi di concentramento.

Ma non aveva considerato Duckwitz che, integrato ormai nella comunità danese, non agì come ci si aspettava – era convinto sostenitore della politica di cooperazione tra Germania e Danimarca – anzi. Vitello ne riporta un pensiero contenuto nel suo diario della sera del 29 agosto 1943, che fa trasparire tutta la sua frustrazione. Si deve cercare con grande difficoltà di “non perdere la propria compostezza e di non piangere. Un duro lavoro di quattro anni finisce nel nulla a causa della stupidità e della irragionevolezza. Adesso gli abitanti dell’ultimo stato d’Europa ci odieranno dal profondo dei loro cuori. È molto difficile essere un tedesco”.
È molto difficile essere un tedesco. Quanta verità in queste parole, quanta amarezza nella consapevolezza dell’appartenere a una nazione in preda al delirio hitleriano. I fatti si susseguono freneticamente e mentre arrivano in Danimarca i mille agenti delle SS di Rolf Gunther, il vice di Eichmann, Duckwitz incontra a Stoccolma il primo ministro svedese Albin Hansson per chiedergli l’accoglienza di quasi 8.000 ebrei danesi che sarebbero arrivati via mare. “Mi assumerò la responsabilità per tutto quello che sto per fare. Sono consolato dalla mia forte fede che le buone azioni non possono mai essere sbagliate”: così, nella concitazione del momento, essenziale per la vita di migliaia di persone, Duckwitz si rafforza nelle sue convinzioni e, avvisato il capo del partito socialdemocratico danese Hans Hedtoft dell’imminente deportazione — il raid era previsto per la notte tra l’1 e il 2 ottobre — immediatamente venne allertata la comunità ebraica per organizzarne la fuga via mare.

Lasciamo alla curiosità dei lettori l’approfondimento delle tante e belle storie di ‘normale eroismo’ di cittadini di ogni età e lavoro qui narrate, dalle esemplari vicende dei medici del Bispebjerg Hospital di Copenaghen, fino alle azioni coraggiose di pescatori e giornalisti, ma anche studenti e giovanissimi atleti e poi insegnanti e ricercatori del dipartimento di biochimica del Rockefeller Institute di Copenaghen, ma non solo. Anche la Chiesa luterana danese, nel nome del suo vescovo Hans Fuglsang-Damgaard, reagisce fortemente, inviando agli occupanti tedeschi una dura lettera di condanna della deportazione nella quale si legge che ‘la persecuzione degli ebrei si oppone alla visione degli esseri umani e all’amore del prossimo’. Una rete fitta e coesa di mutuo soccorso permette, risolvendo situazioni pericolose e complesse, a quasi 8000 ebrei danesi di raggiungere la Svezia via mare. Un’operazione complessa che non si conclude con l’arrivo in Svezia ma che prosegue con l’organizzazione della loro accoglienza, dell’ospitalità e dell’inserimento dei rifugiati ebrei danesi nella vita sociale, culturale e religiosa svedese.

Questo saggio racconta così una vicenda umana ‘esemplare’ da ogni punto di vista, sia individuale che collettiva e che, nel rappresentare la solidità morale di una delle più antiche democrazie d’Europa ne svela le radici più profonde, come sottolinea Andrea Vitello nel capitolo finale, ‘La normalità del bene’: “In Danimarca la discriminazione e il razzismo istituzionalizzati, non solo nei confronti degli ebrei, ma di qualsiasi altra persona, erano sempre stati respinti dal Parlamento. La società si era evoluta all’insegna dell’empatia e della tolleranza, includendo senza discriminazioni persone e comunità, compresa quella ebraica. (…) Come avrebbero potuto convivere con se stessi se avessero aiutato i nazisti?” .
E, a proposito delle scelte controcorrente e coraggiose del ‘nazista che salvò gli ebrei’, così l’autore chiude il suo lavoro: “Duckwitz rappresenta un esempio di disobbedienza agli ordini. Possiamo chiederci perché l’abbia fatto. Egli avrebbe potuto semplicemente ubbidire agli ordini, giustificandosi poi, come fecero i nazisti al processo di Norimberga, e Eichmann al processo di Gerusalemme, con l’impossibilità di venir meno al giuramento di fedeltà verso Hitler e agli ordini dei suoi superiori. (…) In sostanza i nazisti, ubbidendo acriticamente agli ordini, compivano quello che la filosofa Hannah Arendt definì ‘la banalità del male’. L’espressione non vuole indicare che gli atti compiuti siano ‘banali’ ma piuttosto si riferisce alle persone che compivano tanti atti, considerate persone ‘banali’ che rinunciano alla caratteristica che ci distingue dagli animali, ovvero la facoltà del pensiero, la ragione. (…) Alla luce di questa affermazione risulta chiaro che Duckwitz ha sempre mantenuto vigile la sua coscienza e al momento opportuno ha avuto il coraggio di fare tutto quello che poteva per salvare gli ebrei, poiché riteneva sbagliati gli ordini che gli erano stati impartiti”.

Ecco, il suo comportamento ‘normalmente’ e umanamente critico ha contribuito a realizzare la ‘normalità del bene’ in Danimarca. “Preferisco morire con un ebreo che vivere con un nazista”, è l’illuminante affermazione del pastore della Chiesa di Frederiksberg che sintetizza al meglio l’animo dei danesi, fermamente antinazista. Nella sua postfazione ‘Il valore della reputazione morale’ Gabriele Nissim – saggista e scrittore, fondatore e presidente di Gariwo, Gardens of the Righteous Worldwide, con cui ha promosso la Giornata dei Giusti in Europa e in Italia e ha costruito il Giardino dei Giusti nel mondo – mette a confronto la figura di Duckwitz, riconosciuto Giusto tra le Nazioni) con quella esemplare del bulgaro Dimitar Peshev, il vicepresidente del parlamento che, grazie alla firma di 43 deputati della maggioranza di governo, riesce a bloccare il trasferimento nei campi di concentramento dei 48.000 ebrei bulgari ma non quelli di Tracia e Macedonia. La sua vicenda umana passa poi dalla destituzione al carcere duro alla liberazione e, infine alla morte nel 1973. Giusto tra le Nazioni nel 2013, lo stesso Nissim ne racconta la storia ne ‘L’uomo che fermò Hitler’ uscito per i tipi di Mondadori nel 1998.

Vicende simili, che l’autore mette a confronto con quanto accadde nel resto d’Europa, soprattutto in Italia: “I tedeschi in Bulgaria e in Danimarca non hanno fatto un colpo di stato per portare avanti le deportazioni, bensì hanno rinunciato. Tutta via in altri paesi non ci sono stati membri dell’élite politica che si sono opposti ai tedeschi. Pensiamo all’Italia dove nessun importante politico fascista si è opposto prima alle leggi razziali del 1938 e poi alle deportazioni iniziate nel 1943. In Italia ci sono stati tanti salvatori di ebrei, ma se anche un politico fascista si fosse opposto alle deportazioni, queste si sarebbero bloccate. (…) Duckwitz e Peshev rappresentano quindi l’ambiguità del bene di quelle figure di mezzo che fanno parte dell’èlite politica ma che decidendo di cambiare idea risultano decisive per far cambiare situazione nei rispettivi stati (…) Due figure da prendere d’esempio e da far studiare, perché sono l’emblema di come le cose sarebbero potute andare in modo diverso”.
Elisabetta Dellavalle
Pubblicato martedì 20 Gennaio 2026
Stampato il 06/03/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/quel-diplomatico-tedesco-che-divenne-un-giusto-a-copenhagen/