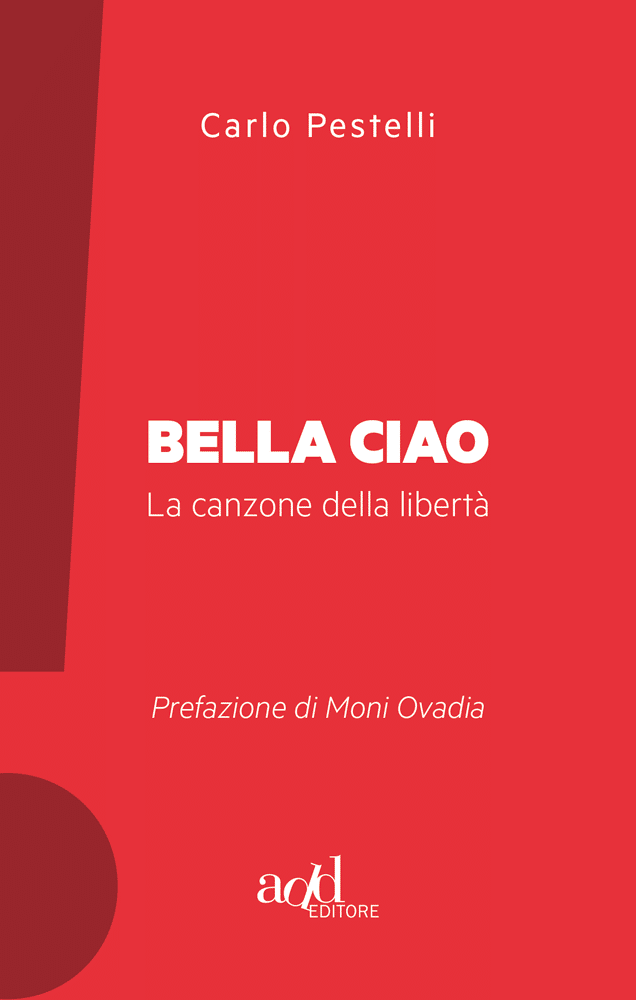Mauro Carrero scrive le note di copertina di Nagìra in una stanza sopra la stazione ferroviaria di Nova Gorica, nel febbraio di quest’anno; e il luogo è doppiamente simbolico: per prima cosa poiché si tratta di una stazione ferroviaria, semplice ma lampante metafora dell’idea di viaggio – insieme punto di partenza o di arrivo, o ancora nodo fondamentale di passaggio – o meglio, dell’attitudine al cambiamento, alla tensione verso qualcosa di nuovo. Il terzo album del cantautore piemontese è infatti uno slancio verso inediti orizzonti musicali e nuove frontiere dell’intelletto. E qui salta fuori il secondo significato simbolico celato dalla stazione di Nova Gorica, quello di rappresentare un territorio di confine e di scambio tra lingue e culture diverse, tra un mondo passato e uno presente o futuro, tra una dimensione che prima c’era e ora ha lasciato spazio a qualcosa di nuovo. “Un luogo – scrive ancora Carrero – in qualche modo tappa finale di un viaggio iniziato quasi due anni fa, nella reclusione della pandemia, in un’altra stanza dall’altro lato d’Italia, attraverso queste canzoni”.
Mauro Carrero scrive le note di copertina di Nagìra in una stanza sopra la stazione ferroviaria di Nova Gorica, nel febbraio di quest’anno; e il luogo è doppiamente simbolico: per prima cosa poiché si tratta di una stazione ferroviaria, semplice ma lampante metafora dell’idea di viaggio – insieme punto di partenza o di arrivo, o ancora nodo fondamentale di passaggio – o meglio, dell’attitudine al cambiamento, alla tensione verso qualcosa di nuovo. Il terzo album del cantautore piemontese è infatti uno slancio verso inediti orizzonti musicali e nuove frontiere dell’intelletto. E qui salta fuori il secondo significato simbolico celato dalla stazione di Nova Gorica, quello di rappresentare un territorio di confine e di scambio tra lingue e culture diverse, tra un mondo passato e uno presente o futuro, tra una dimensione che prima c’era e ora ha lasciato spazio a qualcosa di nuovo. “Un luogo – scrive ancora Carrero – in qualche modo tappa finale di un viaggio iniziato quasi due anni fa, nella reclusione della pandemia, in un’altra stanza dall’altro lato d’Italia, attraverso queste canzoni”.
 Partiamo dall’immagine di copertina dell’album, una wunderkammer del XX secolo: una collezione di oggetti dal tratto surreale che suggerisce il contenuto delle tue canzoni?
Partiamo dall’immagine di copertina dell’album, una wunderkammer del XX secolo: una collezione di oggetti dal tratto surreale che suggerisce il contenuto delle tue canzoni?
Un vero e proprio nesso tra gli oggetti e le canzoni non c’è, se non la varietà. È più un insieme di cianfrusaglie che potrebbero essere rimaste in fondo alla valigia dopo una serie di viaggi. L’oggetto centrale della copertina è infatti la valigia, con il prato e il cielo, che sembrerebbe surreale o artificiale ma esiste davvero. La cover e la grafica sono nate grazie al mio amico italo-sloveno Anton Špacapan Vončina, illustratore e scenografo, al quale avevo fatto ascoltare i provini. Ogni tanto ci sentivamo per telefono e parlavamo del progetto, facendo una sorta di brainstorming, e lui buttava giù schizzi e disegni vari, finché non mi ha parlato di questa valigia. A febbraio sono poi andato a trovarlo a Nova Gorica e, insieme a Luca Chinaglia che ha fatto le foto e Marco Devetak che si è occupato di assemblare la grafica, è stato realizzato tutto il lavoro, anche il curioso contenuto interno.

Le tracce che aprono il disco sono dedicate al mito di Fred Buscaglione e a quello di Torino, come se, abbandonato l’ombelico del tuo mondo, le Langhe, la prima tappa del viaggio fosse proprio il capoluogo piemontese.
Quello verso Torino è anch’esso un viaggio dai vari significati: un percorso a ritroso, alla città della mia infanzia, un ricordo alla città di mio padre e un omaggio al nostro capoluogo di regione. Dopo avere cantato, nei miei primi due album, soprattutto le Langhe, luogo di adozione e di ataviche radici, ho voluto omaggiare il posto dove ho trascorso i miei primi sei anni di vita. Non sono ancora riuscito a scrivere compiutamente del paese dove sono cresciuto, Garessio, anche se è naturalmente contemplato nel brano che si intitola Lungo il Tanaro ed era citato anche nel pezzo La leggenda di Aleramo. Per quanto riguarda Buscaglione, è un personaggio che mi fa pensare alla Torino degli anni ‘50, in cui crebbe mio padre. Inoltre è simbolo di quella contaminazione culturale che pervade l’album e, più in generale, il mondo globalizzato di oggi. Nel caso di Buscaglione, la mescolanza era ed è tra l’immaginario americano e il vecchio mondo piemontese, infatti il pezzo è cantato in dialetto su un ritmo di swing.

Nella malinconica Bar dell’Angelo – ancora una canzone torinese dedicata ai fatti collegati all’omonimo bar e a Carmine Civitate e a Emanuele Iurilli – ricordi un grumo di episodi degli anni di piombo, mettendoti dalla parte di chi ne fu vittima inerme “in quegli anni bastardi, tra i deliri di un’ideologia”.
Fin da ragazzino mi ha sempre incuriosito molto leggere le vicende degli anni di piombo. Credo che l’input mi venne dalla visione del film Il caso Moro con Gian Maria Volonté. A Torino abitavamo a Madonna di Campagna, in via Paolo Veronese 342, il Bar dell’Angelo era al numero 340. Contro il muro di quel bar che dava sul nostro cortile tirai i primi calci al pallone. Non ho mai più rivisto la casa e il quartiere. Mia madre mi aveva accennato solo vagamente a una sparatoria avvenuta nel bar ma, pochi anni fa, mi sono imbattuto in un documentario intitolato Anni spietati – Torino racconta violenza e terrorismo dove, in una delle prime inquadrature, si vede proprio la piccola casa monofamiliare in cui abitavamo. Sono rimasto molto sorpreso ed è così che ho scoperto la storia del Bar dell’Angelo e tutta la scia di sangue che si trascinava dietro, ma anche il fatto che quel quartiere fosse uno dei centri nevralgici del terrorismo. Ho iniziato a cercare quante più informazioni possibili su quella vicenda specifica, avvenuta pochi mesi dopo la mia nascita e, nella miriade di emozioni e connessioni che mi scatenavano quelle scoperte, è venuta fuori spontanea la canzone in cui, come già altre volte, ho mescolato storia personale e collettiva. In quei tragici episodi, tutti strettamente connessi, persero la vita dapprima Matteo Caggegi e Barbara Azzaroni che, come militanti di Prima Linea, avevano fatto una scelta pericolosa, in seguito il diciottenne Emanuele Iurilli e il padre di famiglia Carmine Civitate, totalmente innocenti ed estranei a quei fatti. Due vite spezzate in un modo assurdo proprio mentre io compivo i primi passi. Ricordarli anche nel titolo della canzone mi è sembrato doveroso.

Orangotango ci porta nel “pensiero triste che si balla”; eppure l’atmosfera argentina alla Astor Piazzolla è stemperata da un testo tra l’ironico e – mi viene da dire – il carnascialesco…
Orangotango è un divertissement che nasce dal gioco di parole del titolo e, al tempo stesso, una danza tra l’erotico e il sensuale, come da tradizione, e l’aspetto animalesco ma anche giocoso del sesso.

I fiati balcanici alla Goran Bregović che dominano Jugoslavia celebrano un luogo che c’è sempre stato e che, allo stesso tempo, non c’è più. Qual è la storia di questa canzone?
Quattro anni fa sono stato invitato a suonare al Festival Če povem di Nova Gorica. Era la prima volta che superavo la frontiera orientale ed è stato come entrare in un mondo del tutto sconosciuto, anche se a pochi chilometri oltre il confine, e udire una lingua incomprensibile e misteriosa. Nonostante questa distanza, con i ragazzi del luogo ho avvertito da subito un’affinità e una fratellanza particolari, tanto che sono diventati degli amici con cui mi sento di frequente e da allora non ho mai mancato una partecipazione. L’ispirazione per questo brano mi è venuta al ritorno dalla seconda edizione, dopo aver incontrato un’amica. È una ragazza di frontiera, appunto, perfettamente bilingue. Essendo più o meno mia coetanea mi ha fatto pensare a quel mondo ancora più estraneo, per cultura, economia, modelli sociali, che era la Jugoslavia di quando eravamo bambini, quando esisteva ancora la cosiddetta cortina di ferro. Due mondi così diversi che però in lei erano totalmente integrati. Inoltre, da quelle parti, i simboli della vecchia Jugoslavia sono spesso ancora visibili. Ho avuto l’idea del testo e solo in un secondo tempo ho provato ad adattarlo a una musica tipicamente balcanica. Per quanto la Slovenia non sia propriamente i Balcani, a volte le cose si percepiscono di più standone sul confine che non essendoci immersi. È una sorta di vertigine che danno certi luoghi di frontiera e che ho avvertito in particolar modo lì a Gorizia.

Nagìra… è il fulcro del tuo album, un ibrido tra Piemonte e Cuba sul ritmo del son. Spiegaci qual è il gioco di parole che sta dietro questo strano titolo.
Na gira, scritto staccato, significa semplicemente un giro. Ma l’ho voluto scrivere attaccato perché evocasse, allo stesso tempo, un qualche lontano luogo esotico, essendo appunto un album incentrato sul viaggio e che attinge a varie tradizioni musicali: potremmo dire un album di world music. La parola è presa dal coro della canzone che dice: Se na gira, con custa brüta pandemia, et pöri gnanca fè, na gira. Come per il precedente Marelanga, è stato l’ultimo pezzo che ho scritto e riassume un po’ lo spirito dell’intero progetto, per questo l’ho scelto anche come titolo del disco.

La più sognante e malinconica tra le nuove canzoni è ovviamente Saudade da cidade de Lisboa (quasi fado). Canti di “quel senso di un altrove,/ sembrava d’esser lì e in mille altri dove”. Quanto è forte oggi il bisogno di evasione?
Personalmente, oggi come ieri, il bisogno è sempre stato forte. La realtà, la quotidianità spesso stanno strette. È per questo che si viaggia in fondo, per vedere nuove realtà, per immaginare altre vite, per fuggire dalla routine, anche se poi siamo allo stesso tempo esseri abitudinari. Ma credo che questa evasione sia anche uno degli attributi dell’arte. Si legge, si guarda un film, si va a teatro, si ascolta musica talvolta anche per evadere, per fare un viaggio con la fantasia e con le emozioni.

L’album si chiude con Rinascerò. È un risorgere, una ripartenza? Da che cosa?
Da qualsiasi momento di fallimento, timore o sconforto. L’avevo abbozzata diversi anni fa ma ho deciso di registrarla e metterla in conclusione a questo album che ho realizzato durante la pandemia perché assumeva, allo stesso tempo, un significato collettivo.
Non possiamo terminare l’intervista senza fare cenno ai bellissimi arrangiamenti dei tuoi brani e agli strumentisti che ti hanno accompagnato in questa avventura…
Devo innanzitutto menzionare due persone: Francesco Bordino e Beppe Rosso. È ormai consuetudine che quando registro un provino lo faccia sentire a loro per consigli su arrangiamenti, impressioni o altro (insieme a Simone Barbiero, che ha suonato il basso e con cui mi sentivo spesso). Francesco si è occupato anche della parte di registrazione in studio, del mixaggio e del mastering, mentre Beppe ha scritto tutto le parti di archi, oltre a supervisionare i brani dal punto di vista armonico. Poi ci sono i musicisti che hanno registrato: Alberto Parone alla batteria, Gianpiero Malfatto agli ottoni, Michele Lazzarini ai sax, Giuseppe Gullà al clarinetto.
Giacomo Verri, scrittore
Pubblicato venerdì 7 Ottobre 2022
Stampato il 15/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/pentagramma/nagira-dalle-langhe-a-nova-gorica-passando-per-cuba/