
Ada Gobetti (aveva sposato Piero nel 1923, dopo averlo conosciuto collaborando ad Energie Nuove e alla Rivoluzione Liberale), negli anni del fascismo fu al centro di una rete clandestina di intellettuali, tra i quali Carlo Rosselli, che avrebbe portato alla costituzione del movimento Giustizia e Libertà. Nel 1941, Ada (che nel 1937 si era risposata con Ettore Marchesini), partecipò alla fondazione del Partito d’Azione e dopo l’armistizio, col figlio Paolo (che nel dopoguerra sarebbe diventato critico cinematografico dell’edizione torinese de l’Unità), entrò nella Resistenza, costituendo un primo nucleo di partigiani nella “borgata Cordola” di Meana di Susa.
Oltre a mantenere i collegamenti tra Torino e le formazioni GL operanti in Val Susa e nei vari centri del Piemonte, Ada Gobetti collaborò alla costituzione dei Gruppi di Difesa della Donna. Di quella drammatica esperienza scriverà in Diario Partigiano, pubblicato la prima volta nel 1956 e ristampato nel 1972.
Dopo la Liberazione Ada Gobetti, che fu vice sindaco comunista di Torino, si impegnò in una vasta attività di pedagogista (si era laureata nel 1925), di traduttrice e di scrittrice. Nel 1953 dirige, con Dina Bertoni Jovine, la rivista Educazione Democratica e, nel 1959, fonda il Giornale dei Genitori che, dopo la morte di Ada, sarebbe stato diretto da Gianni Rodari. Nel 1961, con il figlio Paolo e con la nuora, Carla Nosenzo, Ada fonda a Torino il “Centro Studi Piero Gobetti”, che ha dato un importante contributo alla vita culturale torinese e che ha pubblicato, tra l’altro, l’intera corrispondenza tra Piero ed Ada ed una monografia su questa valorosa protagonista della Resistenza. È scomparsa nel 1968.
Questo testo è preso da Diario Partigiano.
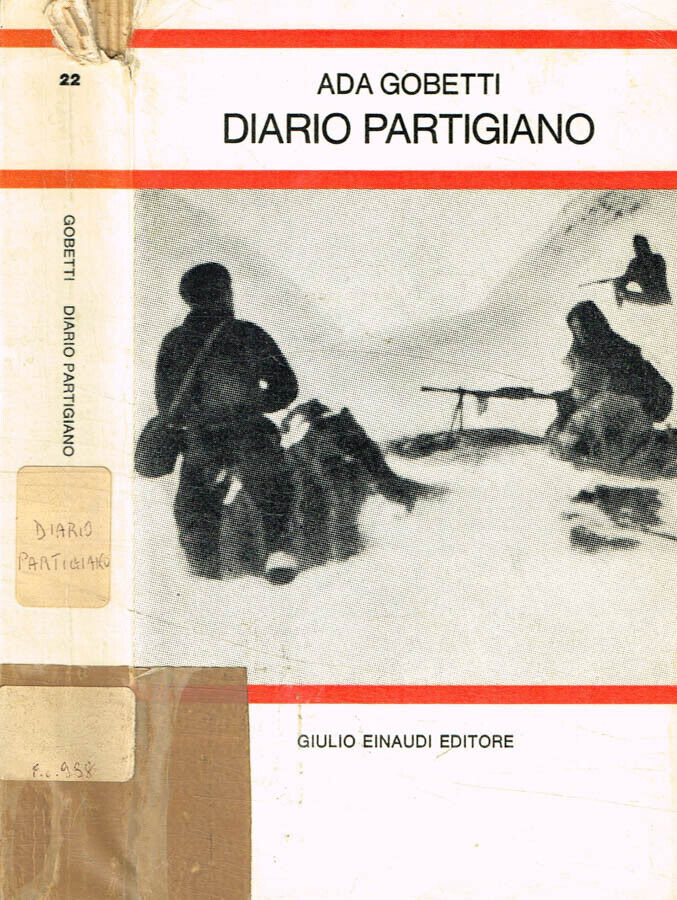 Credo di dover incominciare il mio racconto da quel momento – verso le 4 del pomeriggio del 10 settembre 1943 – in cui, mentre con Paolo, Ettore e Lisetta (1) stavo distribuendo manifestini all’angolo di via Cernaia e corso Galileo Ferraris, vidi, con occhi increduli, passare una fila d’automobili tedesche.
Credo di dover incominciare il mio racconto da quel momento – verso le 4 del pomeriggio del 10 settembre 1943 – in cui, mentre con Paolo, Ettore e Lisetta (1) stavo distribuendo manifestini all’angolo di via Cernaia e corso Galileo Ferraris, vidi, con occhi increduli, passare una fila d’automobili tedesche.
Prima, nei quaranta giorni badogliani, non era stata, per me, una cosa veramente seria. Un’eccitazione, una festa continua, questo sì: sin dal primo momento, il mattino del 26 luglio, quando avevo udito la notizia per radio a Meana, gradatamente, confusamente, prima in cecoslovacco, poi in greco, e avevo avuto una reazione di riso quasi isterico; e poi, il ritorno precipitoso a Torino; e la casa piena di gente; e tutti gli amici che si potevano ormai vedere liberamente; e quelli che, giorno per giorno, tornavano dal confino, dall’esilio, dal carcere – Rossi e Ginzburg, Venturi e Foa (2) – e l’eccitazione della prima stampa semiclandestina; un turbine in cui era bello sentirsi trascinare, una gioia che pareva un giusto compenso a tanti anni d’isolamento. M’ero buttata a «lavorare» con gli amici che m’ero trovati accanto, quelli con cui ero rimasta o ero venuta a contatto negli anni precedenti e che si richiamavano in parte alle idee di Piero: senza capirci molto, in fondo, senza neanche tentar di capire; con pura adesione sentimentale, con entusiasmo pieno di fede. Quando ci ripenso, oggi, mi pare impossibile d’aver potuto essere in quei giorni, nonostante l’età e l’esperienza, così fanciullescamente superficiale e felice; con uno spirito quasi d’innocenza, uno stato d’animo di vacanza (credo, del resto, che questo fosse lo stato d’animo di molti tra noi). L’unica cosa seria forse era la sensazione che, come nella più bella vacanza, tutto questo «non poteva durare»; e l’attesa di qualcosa che ci avrebbe ben altrimenti e più profondamente impegnati.
Quel giorno, dunque, quando vidi passare le automobili tedesche, ebbi improvvisa la sensazione che la vacanza fosse finita. Non che mi rendessi conto, neanche parzialmente, della realtà della situazione. Continuavo anzi a ragionare col solito stolto, incosciente ottimismo: le automobili tedesche portavan certo dei parlamentari; le proposte sarebbero state respinte; Torino si sarebbe difesa.
La gente s’affollava intorno a noi. È uno dei ricordi più patetici di quel giorno l’ansia dei passanti che, vedendoci con dei fogli stampati in mano, ci credevano al corrente delle segrete cose e c’interrogavano, sperando di sapere, di capire: patetici nel loro isolamento, nel loro abbandono: lasciati a se stessi, senz’armi materiali né morali, senza un orientamento, senza una parola d’ordine. Eppure chi sa quanti di quelli che a noi si rivolgevano con così commovente speranza avrebbero saputo, se si fosse tesa loro la mano, dimenticare il loro inutile se stessi e diventare «compagni» nel senso più alto della parola. Io avrei voluto tender loro la mano, ma non ero né più ricca né più armata di loro. Continuavo a dir stupide parole d’incoraggiamento, guardando la facciata della Camera del Lavoro. Eran passate poche ore soltanto dalla riunione del mattino (3): quella gioia, quell’entusiasmo del sentirsi veramente uno tra molti, quel senso di fraternità conquistato attraverso il comune sperare e il comune soffrire: era mai possibile che quella forza fosse stata illusione? Eppure ogni volta che riabbassavo gli occhi sui manifestini che tenevo in mano, le parole stampate («resistenza», «volontà rivoluzionaria», «libertà», «giustizia») mi parevan sempre più vane, più pietose e irreali.

Fu Renato Martorelli (4) a convincerci ch’era ormai assurdo sperare: e fu anche l’ultima volta che lo vidi. (Quante figure – nobili, care figure come la sua – appariranno per un attimo in queste pagine per poi allontanarsi in un’ombra senza ritorno). Era con un altro e mi venne incontro deciso, il volto abitualmente pallido segnato dalla preoccupazione e dalla stanchezza: – Se ne vada, che cosa sta a fare? Adami Rossi (5) ha consegnato la città ai tedeschi. Se ne vada subito.
La folla intorno incominciava a diradarsi; ci allontanammo, ancora increduli, a malincuore. A casa, un giovane che stava ascoltando la radio, ci accolse con tono eccitato: – Farinacci parla da Monaco; han ricostituito il partito fascista; è un vero incitamento alla guerra civile! – Alzai le spalle con un senso di fastidio. Poco m’importava di Monaco e di Farinacci in quel momento; mi pareva che ci fossero cose più urgenti da fare: bruciare la carte intanto, soprattutto le schede di quelli che s’erano iscritti nei «Volontari della nazione armata» per il «Fronte italiano della resistenza». Una pesante stanchezza fisica incominciava a pesare su di me: mentre Lisetta mi preparava un caffè, mi accinsi a radunare e bruciare i documenti pericolosi.
Paolo intanto discuteva violentemente con alcuni amici: – Bisogna fare qualcosa; non si può cedere in questo modo; togliamo le rotaie; tiriamo su le barricate – gridava con un tono di disperazione che suonava strano nella sua voce ancora infantile. Era la sua prima delusione d’amore; era la prima volta in cui, fanciullo, aveva amato qualcosa, aveva creduto in qualcosa, in quella forte volontà di resistere che intuitivamente s’era sentita intorno; e ora non voleva credere che fede e amore fossero stati vani.
Arrivò Ettore con la notizia che un suo collega aveva trovato un fucile: che cosa bisognava farne? – Prenderlo – dissi subito. Ettore ripartì di corsa e Paolo scomparve dietro di lui.
Le carte bruciavano. Lo studio era deserto. Nella sala da pranzo – quasi ubbidendo a un istintivo bisogno di maggior riservatezza – si teneva una specie di consiglio di guerra. C’erano Andreis, Agosti, Foa, Venturi, Peccei (6). E c’era anche Luigi Scala: Scala, uscito dalla lunga prigionia soltanto due giorni prima e che dovevo rivedere per un momento tre anni dopo, al suo ritorno da Mauthausen, così fisicamente distrutto che neanche il suo spirito indomabile sarebbe riuscito a salvarlo.
Le decisioni furon prese rapidamente: bisognava scomparire, dividersi, pur tenendosi segretamente in contatto; si sarebbe visto che forme avrebbe preso l’offensiva poliziesca e come si sarebbe potuto lavorare. Un gruppo sarebbe andato nella Val Pellice, un altro nel Cuneese; noi ci saremmo portati, per il momento, nella Val Susa, a Meana.
Qualcuno arrivò ansante con la notizia che un autocarro carico di SS stava per arrivare a casa mia, in via Fabro. Di nuovo alzai le spalle: mi pareva del tutto improbabile che le SS ci dessero tanta importanza. Convenimmo tuttavia ch’era prudente sciogliersi il più presto possibile; promisi, a malincuore, che anche noi saremmo andati a dormire alla Vigna Allason (7). Ci salutammo alla svelta, senza particolare commozione. Scesi anch’io sotto il portone. Ettore arrivava portando un fucile modello ’91, il modello su cui, ragazzina, durante l’altra guerra, avevo imparato a sparare. – Seppelliscilo in cantina, – suggerii, accarezzando fuggevolmente la lunga canna. E in cantina rimase, per venti mesi, finché, nelle notti dell’insurrezione, servì a sparare contro gli ultimi carri armati tedeschi.

Ma Paolo dov’era? – È andato alla caserma Valdocco, a veder se trova altre armi – disse Ettore. Vi corsi anch’io, con una certa ansia: era là, infatti, con una piccola folla, che guardava, smarrita e impotente, i soldati alle finestre, «consegnati» nella caserma. – Poveri ragazzi! – commentavano le donne; e alcune gridavano: – Scappate! Tornate a casa, da vostra madre! Non vorrete mica farvi prendere dai tedeschi! – E i soldati le guardavano, tentati e incerti: come orientarsi in questo mondo in sfacelo in cui anche gli ultimi punti fissi di disciplina, di patriottismo, d’onore, già vacillanti da tempo, crollavano ora tragicamente?
Passò intanto qualcuno con un rotolo di cuoio grezzo; si stava svuotando un vicino deposito militare abbandonato. Così come l’aura eroica del mattino aveva fatto appello a quanto c’era di più alto, il senso della dissoluzione rafforzava ora gl’istinti meno controllati dell’uomo. La piccola folla si disperse rapida, inseguendo il fugace bene che le si offriva, e i soldati rimasero soli a fissar con occhi vuoti e malinconici la strada deserta.
Armi intorno non se ne vedevano. Ritornammo indietro in un silenzio greve di tristezza. Rientrando, la casa ci apparve come un campo di battaglia abbandonato: cenere, carte lacerate, mozziconi di sigarette ovunque; sul tavolo della sala da pranzo, due rivoltelle Beretta e un centinaio di caricatori.

Mentre Ettore e Paolo nascondevan le armi e io cucinavo in fretta delle uova, giunse Luigi Capriolo (8). Da quando lo conoscevo – ed erano ormai molti anni – sempre l’avevo visto sorridere. Sorrideva, uscito dal primo periodo di prigionia, annunciandomi il suo prossimo matrimonio; sorrideva, dopo altri duri anni di prigione, dicendomi che il matrimonio ormai era sfumato, ma che il «lavoro» continuava e lui era contento lo stesso. E da lui correvamo nei momenti più acuti d’angoscia e di sollievo: nell’ora di dichiarazione di guerra alla Francia, come nell’ora dell’attacco tedesco alla Russia: nella sua semplicità sentivamo qualcosa di saldo e continuo, e in lui tutto era assolutamente vero. Ma in quella sera del 10 settembre, entrando da noi, non sorrideva: il suo volto, così poco romantico, era segnato dalla stessa stanchezza greve che avevo visto sul volto dei soldati della caserma, sul volto di molti che s’incontravan per via. Profondamente cosciente del significato politico del momento, soffriva tuttavia nei nervi e nel sangue del tragico smarrimento che si sentiva attorno. Ma con Paolo s’intesero subito. Mentre si buttava giù un boccone in fretta, li sentivo discorrere con espressioni e termini che dovevan dopo pochi giorni entrare nella normalità quotidiana, ma che in quel momento ancora mi suonavano nuovi e accompagnati da un’oscura minaccia: – Organizzare la resistenza… sabotare… squadre armate… – Il mattino dopo intanto, sarebbero andati insieme in cerca d’armi.

Mentre si stava uscendo arrivò Momi Banfi (9), sfinito. Militare, era riuscito avventurosamente a non farsi prendere dai tedeschi; da tre giorni non dormiva, non aveva pace; barcollava dalla stanchezza. Ma non si poteva lasciarlo nella casa che noi abbandonavamo stimandola pericolosa; e come fargli fare i sei chilometri per arrivare alla Vigna? Capriolo disse che l’avrebbe portato lui a dormire in un posto sicuro, da un compagno. E, per la prima volta in quella sera, lo vidi sorridere: la simpatia umana, la gioia di poter dare aiuto a chi, s’anche prima ignoto, combatteva la stessa battaglia, ridestava in lui l’ottimismo e la speranza. Su quel suo sorriso ci separammo. E così lo rividi nel pensiero quando, sedici mesi dopo, ebbi da un giornale clandestino, in Francia, notizia della sua orribile fine (10); e così lo rivedo oggi ancora.
Fuori, nella strada, nel tram, la vita esterna appariva squallidamente normale. Allo smarrimento incredulo, alla ribellione irosa, stava ora succedendo, nei più, la rassegnata stanchezza indomita del popolo italiano. S’eran sopportati i bombardamenti, gl’incendi, la carestia; si sarebbe sopportata anche l’occupazione. Che se ne sarebbe usciti, tutti erano certi, in fondo al cuore. Ma come, ben pochi sapevano.
Io non sapevo, certo. E del resto quel nostro salire nella sera verso la collina non aveva per me nulla d’insolito. Quante volte durante il periodo dei bombardamenti, avevam percorso quella strada! E la casa settecentesca, vigilata dai due antichi cipressi, era pur sempre la stessa; e la stessa la cordiale, serena accoglienza che sempre ci si trovava.
Soltanto il mattino dopo incominciai a rendermi veramente conto della realtà quando, passando in tram dinanzi a Porta Nuova, vidi dei soldati tedeschi, armati sino ai denti, in divisa mimetizzata, di guardia presso i mitragliatori. Di colpo cadde l’assurda, incredula speranza che ancora, per difendersi, aveva alimentato il mio cuore. Ne provai una pena insostenibile; mi misi a piangere, senza riuscire a frenarmi; un’altra donna che aveva seguito il mio sguardo si mise a piangere anch’essa; un uomo tossì burberamente e girò la testa; un altro chinò il capo e chiuse gli occhi; «mah!» fece il fattorino con un sospiro.
Il mattino passò rapido nel provvedere a piccole cose pratiche. Paolo se ne andò con Capriolo. Vidi Carlo Galante che veniva da Cuneo dove Galimberti e Bianco avevan già cominciato a raccogliere squadre d’armati; vidi Grosso (11), un nostro organizzatore sindacale che mi parlò del lavoro da lui fatto quel mattino e la sera precedente per ritrovare i contatti con i gruppi operai; vidi Perosino, un giovane che quell’anno era stato mio allievo al Sommeiller – strano che m’avesse individuata e venisse proprio da me –: aveva due bombe a mano in tasca (eran due «Balilla», le prime che vedevo) e molti progetti in testa circa l’organizzazione dei giovani, colpi di mano, ecc.

La bomba a mano SRCM 35, soprannominata “Balilla” (http://www.smalp155.org/images/scrm35army.jpg)
Dalla stanchezza opaca che m’ero sentita attorno, dal vuoto in cui m’era parso di trovarmi, rinascevano le iniziative, le speranze; la volontà di resistenza prendeva forma. Più che mai sentivo di dover rimanere nella mia casa, che il mio istinto non mi diceva in pericolo, e che avrebbe potuto essere per molti forse l’unico punto di riferimento. Decisi comunque che saremmo partiti per Meana nel pomeriggio. Il lunedì – eravamo di sabato – almeno io sarei tornata. Presi accordi con la portinaia, la valorosa Espedita che per venti mesi instancabilmente, giorno e notte, vegliò su noi e sulla nostra casa e a cui credo che dobbiamo in gran parte l’inverosimile nostra incolumità. Pregai l’avvocato Cattaneo, che abitava allora al pian terreno, di spostar su una determinata finestra la gabbia dei canarini, qualora ci fosse stato qualche allarme, affinché non dovessi trovarmi involontariamente in gabbia anch’io.
Alla stazione, tra la folla che pareva l’abituale massa di «sfollati», tutto era come al solito: c’eran soltanto i tedeschi di guardia, impassibili e nemici, come isolati da un cerchio magico. – Che differenza da ieri mattina – sentii dire dietro di me. Mi volsi: eran due giovani in tuta; evidentemente erano stati anch’essi alla riunione alla Camera del Lavoro; e nei loro occhi increduli c’era la stessa nostra pena.
Ma lo scoramento più doloroso lo vidi nei soldati che, risalendo la valle, incontrammo nelle stazioni e soprattutto a Bussoleno. Erano i resti della IV Armata che, dopo aver tentato di resistere e combattuto al Moncenisio e a Modane (qualcuno era riuscito a ostruire la galleria del Frejus) s’eran trovati senza capi, senza direttive. Sbandati, altro non cercavano ora che sfuggire ai tedeschi, tornarsene a casa. Dopo tre anni di «naia» subita senza convinzione, per due giorni avevan veramente creduto di dover combattere; ma s’eran trovati soli; e alla fiammata d’entusiasmo eroico tanto più grevi eran successe la delusione e l’amarezza. Qualcuno aveva bevuto per stordirsi, qualcun altro cercava d’esasperare in sé un senso di sollievo con l’idea che per lui ormai la guerra era finita.
Ma sollievo ed ebrezza sapevan di disperazione; e una tristezza senza conforto nasceva dallo spettacolo di quell’inutile forza e di quell’inutile dolore. E come sempre, nei momenti più tragici, accanto alla bontà generosa dei molti (migliaia di soldati fuggiaschi furono in quei giorni, nella Val Susa, forniti d’indumenti civili) si rivelava il sordido egoismo di alcuni. Quando il treno lasciò la stazione, mi rimase negli occhi il gesto d’un tale che, tenendo in mano una vecchia giacca, cercava di contrattarne il prezzo con un soldato ubriaco e seminudo. Giungere a Meana fu come ritrovare un dimenticato paradiso. Qui la dissoluzione non era ancor giunta. Tra i castagni dorati dal tramonto, rientravano i carri, carichi di fieno; da ogni casa si levava nel cielo il fumo del focolare. S’udivan giochi di bimbi, gridar d’animali. Come se tutto il mondo fosse in pace.
Paolo scappò via subito e tornò dopo un’ora, gli occhi sfavillanti. Con un gesto di trionfo – lo stesso gesto con cui qualche anno prima mi mostrava il quadrifoglio o il fungo trovato – depose sul tavolo due bombe a mano e un fucile. Era stato al vicino casello ferroviario, abbandonato dai militi.
– Domani – disse – andrò con Gianni (12) a fare un giro negli altri caselli. Vedrai che troveremo un mucchio di roba.
Avrei voluto chiedergli: – E poi? Che cosa vuoi fare? Che cosa bisogna fare? – Ma non ne ebbi il coraggio. Mi sentivo stanca, come svuotata: non potevo affrontare la situazione, prendere decisioni. Volevo, per un momento ancora, ignorare, dimenticare. Dimenticare e dormire.
Il mattino seguente – era domenica – dopo una notte di sonno e la prospettiva di un’intera giornata di pace, ebbi finalmente agio di pensare. Capivo, pur confusamente, che s’iniziava per noi un periodo grave e difficile, in cui avremmo dovuto agire e lottare senza pietà e senza tregua, assumendo responsabilità, affrontando pericoli d’ogni sorta.
Tutto questo personalmente non mi spaventava; il mio ideale di bambina, di adolescente – e in fondo in fondo, ahimè, anche di persona adulta – non era stato forse «la piccola vedetta lombarda»? Ma tremavo per mio figlio che vedevo lanciato così decisamente verso l’azione. Cercai di parlargliene nel pomeriggio sul terrazzo dominato dal Rocciamelone, legato al ricordo di tante ore lontane d’innocente riposo e di giochi sereni. Ma, forse per reazione, Paolo esecra i romantici atteggiamenti eroici che costituiscono il fondo del mio carattere anche se, con lunga e dolorosa disciplina, ho sempre tentato di frenarli. Non c’era bisogno di prender decisioni, disse. Ci avrebbe pensato la situazione stessa a dirci quel che bisognava fare.
Fischiettando, si lasciò scivolare dal terrazzo sul prato sottostante, s’avviò verso la ferrovia. Ettore e io ci guardammo. Per lui era tutto così semplice. Ma forse aveva ragione. In momenti simili, parole e programmi erano inutili. Avremmo fatto giorno per giorno quel che avremmo sentito di dover fare.
NOTE
(1) Paolo è il figlio di Ada e Piero Gobetti e aveva allora 18 anni. Ettore è Ettore Marchesini che aveva sposato Ada nel 1937 (Piero era morto nell’esilio di Parigi nel 1926, poco dopo la nascita di Paolo). Lisetta è Lisetta Giua, studentessa torinese antifascista.
(2) Ernesto Rossi, scrittore di economia politica. Vittorio Foa, dirigente sindacale. Franco Venturi, storico e professore universitario. Leone Ginzburg, scrittore, morì per le torture subite ad opera dei nazifascisti durante l’occupazione di Roma. Erano tutti vittime del Tribunale Speciale del fascismo, membri di “Giustizia e Libertà”, cui appartenevano anche Ada ed Ettore.
(3) La mattina del 10 settembre aveva avuto luogo davanti alla Camera del Lavoro un grande comizio, con la partecipazione di antifascisti di ogni tendenza.
(4) Avvocato, membro del Partito socialista italiano di unità proletaria, venne fucilato dai fascisti nel 1944.
(5) Generale fascista, comandante militare di Torino, che poi aderì alla rsi.
(6) Membri del Partito d’Azione.
(7) La vecchia villa sulla collina torinese proprietà della scrittrice Barbara Allason dove, durante la Resistenza, trovarono rifugio numerosi antifascisti e perseguitati.
(8) Operaio comunista, divenne più tardi capo partigiano nelle valli di Lanzo e poi nelle Langhe.
(9) Arialdo Banfi, detto Momi, membro del Partito d’Azione e in seguito senatore socialista.
(10) Capriolo venne impiccato dai nazifascisti il 13 agosto 1944.
(11) Sindacalista, membro del Partito d’Azione.
(12) Gianni Jarre, studente, amico di Paolo Gobetti e con lui per breve tempo organizzatore di bande partigiane in Val di Susa.
Da Patria indipendente n. 8 del 21 settembre 2003
Pubblicato venerdì 8 Settembre 2017
Stampato il 04/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/anniversari/mio-8-settembre/








